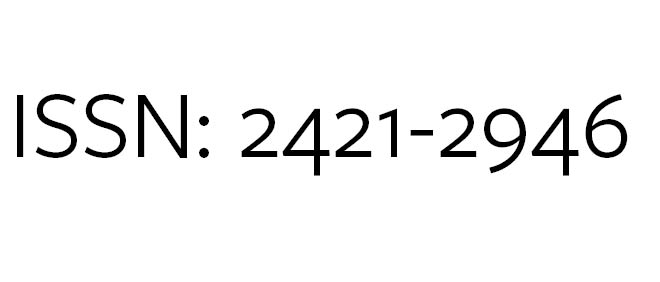Vol. 11, n. 1, aprile, 2025
Teorie e Pratiche dell’Inclusione
Avvalorare l’inclusione. L’«intersoggettività che scuote» e la soggettivazione professionale
Stefano Oliverio1
Sommario
Dopo avere discusso il dibattito dell’area tedesca in cui i sociologi hanno contestato la fondatezza e significatività della distinzione «pedagogica» fra integrazione e inclusione, il contributo fornisce un’interpretazione dell’inclusione come Wertpräferenz, mobilitando alcune intuizioni di Hans Joas e introducendo la distinzione fra norme e valori. La rivendicazione dell’inclusione come «valore» viene, quindi, collegata alla riflessione deweyana sul giudizio di pratica. Tale capacità di giudizio è qui interpretata nei termini di «carattere metodologico», da promuovere attraverso percorsi di formazione dei docenti orientati alla soggettivazione professionale.
Parole chiave
Inclusione, Valore, Giudizio di pratica, Carattere metodologico, Pragmatismo.
THEORIES AND PRACTICES OF INCLUSION
Affirming Inclusion as a Value. «Shattering Intersubjectivity» and Professional Subjectification
Stefano Oliverio2
Abstract
After discussing a debate within the German sociological community, where the legitimacy and significance of the pedagogical distinction between integration and inclusion are contested, the paper offers an interpretation of inclusion as a Wertpräferenz. It draws on some insights from Hans Joas, introducing the distinction between norms and values. The claim of inclusion as a «value» is then connected to Deweyan reflections on the judgment of practice. This capacity for judgment is here interpreted in the light of the notion of «methodological character» to be promoted through teacher training programs aimed at fostering professional subjectification.
Keywords
Inclusion, Value, Judgment of practice, Methodological character, Pragmatism.
Premessa
Nell’editoriale del primo numero del 2024 di «Pedagogia più Didattica», dedicato a La scuola inclusiva, Massimo Baldacci (2024) ha richiamato l’attenzione sui «preoccupanti segnali di regresso rispetto ai risultati democratici conseguiti in tanti anni sul fronte dell’inclusione» (pp. 1-2), l’eco dei quali si è fatta sentire anche sulla grande stampa.
Come annotato da Maura Striano (2014, p. 70), «il termine inclusione ha iniziato a essere introdotto nei testi normativi e di indirizzo negli ultimi dieci anni [a inizio millennio, ndr], all’interno del framework concettuale e semantico delineato dai documenti delle Nazioni Unite, dell’UNESCO e della Comunità Europea»; a sua volta, Baldacci rimarca come l’impulso inclusivo sia solidamente radicato nella nostra Costituzione, nei suoi principi ed ethos. Opportunamente egli sottolinea, inoltre, che «l’inclusione non si realizza automaticamente, inserendo semplicemente l’alunno con disabilità o straniero nella classe. Un’autentica inclusione richiede sia condizioni culturali che condizioni materiali. Le une e le altre, prese isolatamente, sono necessarie ma non sufficienti. Soltanto la loro combinazione può rendere possibile una vera inclusione» (Baldacci, 2024, pp. 2-3).
Pur condividendo l’enfasi sugli aspetti materiali e sul rischio che il discorso pedagogico troppo spesso indugi, invece, su disincarnate riflessioni sulle sole dimensioni culturali, è su queste ultime che ci si soffermerà nel presente contributo. In particolare, attraverso una prospettiva di interrogazione filosofico-educativa, si intende evidenziare come la postura inclusiva del docente (ma l’argomentazione potrebbe essere estesa ad altre professionalità) esiga che l’inclusione sia intesa come «valore» e «carattere metodologico», in un’accezione specifica di tali dizioni che sarà delineata nel prosieguo del testo.
L’argomentazione si svolgerà in due tappe. Dapprima, si presenterà il dibattito dell’area tedesca in cui i sociologi hanno contestato la fondatezza e significatività della distinzione «pedagogica» fra integrazione e inclusione, quasi imputando ai pedagogisti di avere trasformato indebitamente i concetti analitico-descrittivi di inclusione e integrazione in Wertpräferenzen (Emmerich, 2022), ossia in opzioni assiologiche. Per rispondere a tale accusa, da un lato, si mobiliteranno alcune intuizioni di Hans Joas e si introdurrà la sua distinzione fra norme e valori, al fine di arricchire il dispositivo teorico di Iris Young circa il nesso fra inclusione e democrazia; dall’altro, ci si richiamerà al modo in cui Dewey intende «valore» nella sua riflessione sul giudizio di pratica. In questo senso si indicherà che uno dei compiti del docente/professionista inclusivo è quello di saper effettuare giudizi di valore circa l’inclusività dei contesti e delle pratiche e ciò non è questione tecnica di efficienza ma implica una riflessività attenta ai conflitti di valori presenti nella situazione (Manno e Cataldo, 2024). Tale capacità di giudizio sarà quindi interpretata nei termini di «carattere metodologico» da promuovere attraverso percorsi di formazione dei docenti orientati alla «soggettivazione» e non solo alla qualificazione e socializzazione (Biesta, 2014).
L’inclusione come Wertpräferenz
Nella sua riflessione su Inklusion/Exklusion in quanto «concetto chiave della scienza dell’educazione», Markus Emmerich (2022, p. 219) principia ricordando come la «scienza dell’educazione si contraddistingua per una stupefacente competenza nella re-interpretazione, con cui riesce a incorporare semanticamente le terminologie di altre discipline».3
Nella scia di questa premessa, il pedagogista tedesco passa in rassegna alcune costruzioni concettuali della sociologia, che è la disciplina in cui la nozione di inclusione fa la sua prima comparsa, per poi evidenziare tre elementi di differenza con la scienza dell’educazione:
- in quest’ultima il concetto di inclusione non ha tanto, a suo avviso, significato analitico quanto anzitutto normativo-valoriale, indicando una Wertpräferenz;
- ciò comporta che si ridefinisce (e in realtà assottiglia) il nesso intrinseco con la nozione di esclusione: mentre i sociologi, che si accostano alla problematica con intenzioni analitiche e non normative, mostrano come ogni processo di inclusione sia di per sé anche un processo di esclusione, per la pedagogia l’esclusione è l’opposto dell’inclusione, quindi qualcosa da superare (e che può essere superato);
- infine, anche la nozione di «integrazione» riceve un altro significato rispetto alla sociologia.
Riguardo a questo ultimo punto, il sociologo Jörg Michael Kastl (2012) è particolarmente caustico rispetto al modo in cui il discorso pedagogico si appropria e ridescrive il concetto di integrazione:
Integrazione diviene [in pedagogia] una categoria di manchevolezza [Defizit-Kategorie], essa è datata, storicamente sorpassata. Totalmente sorpassata? No, c’è un piccolo villaggio scientifico che ostinatamente si attiene a un modo di esprimersi completamente diverso. Parlo […] della sociologia. […] È stata anche la sociologia che ha messo in gioco il concetto di «inclusione» — in particolare con Talcott Parsons nel suo saggio del 1965 sull’emancipazione degli afroamericani («Blacks») negli USA — peraltro senza che in lui il concetto di integrazione perdesse la sua funzione. Il concetto di inclusione in sociologia serve alla descrizione avalutativa della realtà, non come concetto di valore. «Integrazione» non è in alcun modo, per i sociologi, una tappa precedente rispetto a quella dell’inclusione […] (p. 6, corsivi aggiunti eccetto che per «descrizione»).
Kastl (2012) sottolinea come in sociologia, lungi dall’essere contrapposti, i due concetti sono sì distinti ma, in un certo senso, da combinare. Infatti, «l’inclusione riguarda la questione […] dell’“accesso” degli individui ai sistemi sociali […] nonché il processo e i meccanismi per produrre tale accesso» (p. 7), laddove l’integrazione, come da etimo della parola latina,
presuppone l’accesso a un contesto sociale, quindi l’inclusione. Tuttavia, in linea di principio, l’integrazione riguarda qualcosa di diverso, ossia il «carattere unitario» dei sistemi sociali: come coesione […] e interazione delle varie parti, sottosistemi di un sistema sociale e/o come questione dell’integrazione e dell’interazione degli individui nel e con il sistema sociale (p. 10).
Tale indagine terminologico-concettuale conduce Kastl a denunciare ciò che definisce «la retorica della propaganda sull’inclusione» (p. 22) e a supportare le visioni, quali quella del pedagogista Jürgen Oelkers (2012), che liquidano (un certo discorso su) inclusione come mera «ideologia pedagogica», ribadendo che «il primo passo per evitare ciò sarebbe […] riprendere una concezione più differenziata e basata sulla realtà del rapporto tra inclusione e integrazione e, con ciò, assumere un atteggiamento più critico nei confronti delle promesse della pedagogia della diversità» (Kastl, 2022, p. 22, corsivi aggiunti).
Ogni ammonimento contro le derive retorico-propagandistiche non può che essere benvenuto, come anche il richiamo a un’attenzione analitica ai contesti (che la migliore ricerca pedagogico-didattica non ha, peraltro, mai mancato di coltivare). Ma ciò non dovrebbe comportare un’eccezione incondizionata alla considerazione dell’inclusione come «valore» in nome di approcci avalutativi. Infatti, nel discorso squisitamente pedagogico la questione dei valori è centrale (Colicchi, 2021) ma, in un’ottica pragmatista, la «dicotomia fatto-valore» (Putnam, 2004) è problematica anche nelle scienze sociali.
In questo senso, benché si possa sicuramente attingere, in quanto pedagogisti, alla sociologia, essa deve rimanere «fonte» e non essere presa per «contenuto» (Dewey, 1984, pp. 16 e sgg.). Un esempio può essere rappresentato dal secondo summenzionato punto evidenziato da Emmerich, ossia il diverso regime di relazione tra le nozioni di inclusione ed esclusione che si disegna all’interno del discorso sociologico (assunto come neutralmente avalutativo) rispetto a quanto avviene in pedagogia. Come si è argomentato altrove (Oliverio, 2010), commentando alcune posizioni di Iris Young (2000), una definitio minima di inclusione può essere che essa è non-esclusione, dove il «non» indica la resistenza e la lotta contro l’esclusione, attraverso una riconfigurazione dello spazio pubblico, che parte dalla richiesta di chi è «fuori» e appella a una revisione di lessici, procedure e istituzioni che deve essere operata congiuntamente da chi è «fuori» e chi è «dentro» gli assetti vigenti. In questo senso, la pedagogia dell’inclusione deve essere pensata nei termini di una pedagogia della liberazione e dell’emancipazione (Hoffmann, 2018). Ne deriva che l’ottica dell’inclusione come Wertpräferenz — e non come semplice descrizione di stati di fatto — è cruciale e non avventizia rispetto a un pensamento pedagogico dell’inclusione. È alla questione del valore che, quindi, ci si rivolgerà nel prossimo paragrafo.
Inclusione e l’«intersoggettività che scuote»
Mette conto riprendere alcuni spunti di Iris Young al fine di meglio impiantare la discussione su come si intenda «valore» nel contesto della presente argomentazione e per completare la definitio minima di inclusione da un’ottica differente ma non alternativa.
La filosofa politica statunitense prende l’abbrivio dalla «convinzione che il processo democratico è di solito un mezzo necessario e appropriato» al fine di «promuovere cambiamenti legali, amministrativi e sociali verso una maggiore giustizia» (Young, 2000, p. 5, corsivi aggiunti) e dal fatto che «le democrazie esistenti sono realmente democratiche in alcuni rispetti, riguardo ad alcuni temi e istituzioni. In effetti, la maggior parte delle società hanno alcune pratiche democratiche. La democrazia non è un “tutto-o-niente” ma è questione di gradi; le società possono variare sia quanto all’estensione sia quanto all’intensità del loro impegno per la pratica democratica» (Young, 2000).
Ora, il modo privilegiato per accrescere il gradiente di democraticità di una società è proprio promuovere l’inclusione in quanto la
legittimità normativa di una decisione democratica dipende dal grado in cui coloro che ne sono interessati [affected] sono stati inclusi nei processi decisionali e hanno avuto l’opportunità di influenzarne gli esiti. Appelli all’inclusione sorgono dalle esperienze di esclusione — dai diritti politici fondamentali, dalle opportunità di partecipare, dai termini egemonici del dibattito (pp. 5-6, corsivo aggiunto).
Young distingue due forme di esclusione, l’esterna e l’interna; quest’ultima è intesa come quella condizione in cui «i termini del discorso fanno assunzioni che alcuni non condividono, l’interazione privilegia certi stili di espressione, la partecipazione di alcune persone è scartata come “fuori posto”» (p. 53).
Per contrastare l’esclusione interna e promuovere «la trasformazione dello stile e dei termini del dibattito pubblico e, mediante ciò, aprire la possibilità di significativi cambiamenti negli esiti» (p. 12), Young ricorre a una matrice teorica fondata sulla teoria dell’agire comunicativo di Habermas, individuando tre modi di comunicazione (il saluto, la retorica e la narrazione).
Senza poter analizzare oltre le sue concezioni, si vuole sottolineare come Young imposti il nesso fra inclusione e democrazia anzitutto in un’ottica normativa (ossia relativa alle norme che regolano i processi decisionali) e nella prospettiva della «giustizia». Non si intende minimamente negare la strategicità di tale prospettiva ma la si vuole «completare» con un’enfasi sulla questione del «valore», attraverso la riflessione di Hans Joas (1999) sulla genesi dei valori.4
La mossa principe di Joas consiste nell’istituire una distinzione netta fra norme e valori, che egli interpreta come la versione contemporanea della differenza classica fra «il giusto» e «il buono». Tale rivendicazione del ruolo specifico del «valore» è da lui collegata altresì all’esigenza di riconoscere la creatività dell’agire umano. Infatti, secondo Joas (1999) i valori nascono da un movimento di auto-trascendenza o, meglio, di trascendenza del sé ed è interessante notare come, al fine di delineare come si originino i valori, lo studioso tedesco riconosca il proprio debito anzitutto con la tradizione del pragmatismo classico.
Da William James egli riprende la distinzione fra «morale» e «religione», con la prima che opera — rispetto alle nostre possibilità di azione — nel senso della limitazione, proibendo certi fini o inibendo certi mezzi, laddove la religione, jamesianamente intesa, amplia le nostre possibilità di azione, indicando nuovi orizzonti, appassionandoci a nuove forme dell’esistenza, educando nuove forme del sentire (p. 78). In altre parole, la morale agisce in senso «restrittivo e imperativo», mentre la religione in direzione espansiva e «attrattiva» (p. 259).
È opportuno non lasciarsi sviare dalla nostra precomprensione dei termini «morale» e «religione»: come accennato, l’appropriazione che Joas fa di James è funzionale a individuare un posto per i valori accanto alle norme e a riproporre e attualizzare la distinzione tra il giusto e il buono e, in questo senso, ciò che James chiama «morale» si colloca dal lato delle norme e del giusto, mentre la religione da quello del «valore» e del «buono».
Per iniziare a ricondurre, non senza una qualche forzatura esegetica, le riflessioni di Joas al contesto qui preso in esame, l’inclusione come giustizia (ossia in quanto rispetto delle norme che regolano la convivenza) è agíta dal/la docente nella misura in cui ottempera alle leggi, indicazioni, regolamenti, linee guida, ecc. che prescrivono certi corsi d’azione ovvero certe misure al fine di scongiurare ogni forma di discriminazione ed esclusione. E, inoltre, esige che ella/egli, in quanto professionista e cittadino/a, sia vigilante a che nel proprio ambito di azione tutti gli attori operino in tale orizzonte normativo e si attivi per promuovere migliori normative ove quelle in essere siano superate dall’insorgere di nuovi bisogni, interessi, aspirazioni, che necessitino di essere tradotti in nuovi diritti.
Tuttavia, questa sensibilità all’emergere di nuove istanze è tanto più affinata quanto più l’inclusione è esperita come valore, quindi non tanto nel senso del rispetto delle regole date bensì in quello del generoso slancio verso l’individuazione di nuove esigenze, aspirazioni e interessi. In altre parole, la realizzazione di ciò che è «giusto» non esaurisce il campo di ciò che è «pedagogicamente buono/desiderabile» in termini di inclusione. Si potrebbe persino asserire che il carattere «restrittivo e imperativo» dell’approccio normativo — per quanto ovviamente cruciale — può rischiare, se assolutizzato, di restringere l’immaginazione «valoriale», ossia l’attrazione verso nuovi traguardi da conseguire, e di frenare così quel movimento di autotrascendenza senza cui non si dà valore.
La nozione di autotrascendenza, in quanto trascendimento del Sé, è centrale ed è anzitutto a Dewey che Joas si riconnette e, più in particolare, al Dewey di A Common Faith. In quest’opera, annota Joas (1999, pp. 174-175), Dewey distingue tre forme di ri-orientamento nella vita e le rende con tre termini — accomodation, readaptation e readjustment — che è difficile tradurre in italiano (e in tedesco) in quanto si tratta di tre diverse forme di «adattamento»: nella prima ci si conforma alle circostanze che non possono essere modificate; nella seconda si adatta il mondo a noi, mentre nella terza «ne va della nostra persona nella sua interezza e non di singoli desideri e bisogni nella loro relazione alle condizioni dell’ambiente» (p. 175). Massimamente interessante è che tale «sé nella sua interezza» è esperito in un rapporto «immaginario» (p. 178):
Come i valori non esistono in un regno ideale trascendente, così il sé nella sua interezza non è presente in qualche luogo, per esempio nel nucleo della persona o nella statica perfezione, aspettando solo di essere realizzato nella vita pratica. […] Tuttavia parliamo di un sé nella sua interezza o di un’autorealizzazione, che ha senso solo qualora al sé presentemente reale possa essere attribuito qualcosa di non ancora realizzato, che nondimeno, in qualche modo, deve essere presente prima della sua realizzazione e non sorgere solo nella realizzazione. […] Tale accentuazione dell’immaginario non è da intendersi nel senso di una riduzione all’illusorio […]. Non c’è alcun dualismo in Dewey fra reale e possibile ma il reale contiene possibilità e gli esseri umani posseggono, nella forma della facoltà di immaginare [Einbildungskraft], un organo per la considerazione [Erfassung] del possibile (pp. 178-179, corsivi aggiunti).
Centrale è, quindi, l’esercizio dell’immaginazione in quanto capacità di intenzionare l’ideale, rammentando che per Dewey «i valori o gli ideali [sono] il risultato di processi creativi di idealizzazione di possibilità contingenti» (p. 180, corsivi nell’originale).
La relazione a valori — intesi non come già collocati in un dominio a parte bensì come idealizzazione di possibilità dell’esistere e, connessi, quindi con un movimento di autotrascendenza — e la formazione integrale del sé sono, quindi, intimamente legati.
Il «luogo» di tale processo creativo di nascita dei valori e di formazione del sé nella sua interezza è ciò che Dewey chiama «comunicazione», l’evento sempre rinnovato che inter-rompe l’autocentratura isolazionista, apre alla condivisione dell’altrui esperienza e alla «radicale disponibilità di lasciarsi scuotere dalla persona dell’altro e, con ciò, di realizzarsi con gli altri esseri umani e oltre di loro: in quanto intersoggettività che scuote» (p. 184, corsivi aggiunti).
Queste riflessioni ci consentono di comprendere che intendere l’inclusione come Wertpräferenz, lungi dal costituire un limite di concettualizzazione, debba essere assunto, invece, come un punto di forza di una visione squisitamente pedagogica. Infatti, se ogni comunicazione — in quanto messa in comune di significati che consente l’emergere e il crescere della comunità (Dewey, 1980, pp. 7 e sgg.) — è educativa, e ogni educazione è comunicazione, il dittico concettuale di Democracy and Education deve essere completato dal terzo elemento dell’inclusione, quale dinamica valoriale attrattiva che va incontro alle sollecitazioni dell’altro, nella misura in cui questi presenta istanze, richieste, aspirazioni e interessi che scuotono le pratiche intersoggettive vigenti. Ma questo andare incontro presuppone una trasformazione del nostro sé che lo renda capace di cogliere ciò che può non essere ancora stato articolato in modo riconoscibile ed eccede i quadri esistenti o li sconvolge. A tal fine, le norme non sono sufficienti ma vi è bisogno di un esercizio — sempre contestuale e incarnato — di immaginazione, che trascenda lo status quo, e anche quella forma di sé che è a esso adattato, e proietti nell’avventura del possibile: in altre parole, l’inclusione è sempre da esperire come un a-venire.
Nuovi valori possono emergere dall’incontro con l’intersoggettività che scuote (ossia con un’intersoggettività che venga vissuta nelle sue valenze scuotitrici, senza facili pacificazioni), nella misura in cui, tuttavia, l’esperienza dello sconvolgimento non si traduca in contrapposizione. In questo senso, il movimento espansivo dell’inclusione è la risposta — in termini di crescita — all’esperienza dell’intersoggettività che scuote.
Tale risposta nel senso della crescita accade nella forma di ciò che potremmo definire avvaloramento, che deve essere distinto dalla valutazione: quest’ultima è la determinazione del valore di un fenomeno sulla base di standard già dati, laddove il primo è il processo che dà/riconosce/fa nascere valore, idealizzando le possibilità contingenti (e ancora inedite) dell’esperienza.
Come detto, le esperienze di avvaloramento così intese sono sempre contestuali, incarnate in situazioni e connesse a una trasformazione del sé. Potranno poi essere (anche) codificate in norme (o regolamenti, linee guida, ecc.) che ne garantiscano un’efficacia pubblica più ampia (e una loro «valutabilità» nella logica dell’accountability) ma non devono essere confuse con esse.
Dal momento che l’inclusione come valore riguarda la prospettiva alla prima persona degli attori sociali (e non la prospettiva alla terza persona delle normative), la questione cruciale diviene quella della coltivazione della postura inclusiva in quanto atteggiamento epistemico-relazionale avvalorante, immaginativamente aperto alle possibilità inesplorate ma attivabili nell’esperienza. Ricontestualizzando una nozione di Gert Biesta (2014), possiamo dire che tale coltivazione non riguarda il piano della qualificazione professionale e nemmeno quello della socializzazione professionale — che invece possono essere cruciali per un rispetto non burocratico delle normative — bensì quello della soggettivazione professionale, perché concerne «la formazione della persona nella sua interezza (non, desidero sottolinearlo, in quanto individuo privato ma come professionista)» (p. 135, corsivi nell’originale), il cui
principio guida […] è l’idea della saggezza pedagogica, ossia l’abilità di formulare giudizi pedagogici saggi. […] Ho di mira ciò che si potrebbe chiamare formazione professionale basata sul giudizio o focalizzata sul giudizio. Non si occupa soltanto di una qualsiasi forma di apprendimento esperienziale o pratica ma prende costantemente come suo punto di riferimento l’abilità di formulare giudizi pedagogici saggi — il che significa che si impegna costantemente nella questione su che cosa sia pedagogicamente desiderabile in relazione a una particolare costellazione di scopi educativi (pp. 135-136, corsivi nell’originale).
Ho parlato di ricontestualizzazione della nozione di Biesta perché, nella scia dell’argomentazione condotta nel presente contributo, si invita a pensare a tale soggettivazione professionale nel senso di quella trascendenza del sé introdotta in riferimento a Dewey, in quanto condizione della nascita di valori. Analogamente, l’enfasi sul giudizio può essere declinata nella direzione dell’educazione al giudizio di valore per come Dewey (1979) lo descrive nel suo saggio sul giudizio di pratica:
Io non credo che le valutazioni abbiano luogo e che i valori siano posti in essere se non in una situazione durevole in cui le cose hanno la potenzialità necessaria a portare avanti dei processi. C’è una relazione stretta tra il prevalere, l’audacia, la valentia e il valore. Ma il termine «valore» non è una mera duplicazione del termine «efficienza»: esso aggiunge qualcosa. Quando ci muoviamo verso un risultato e al tempo stesso siamo stimolati a muoverci verso qualcos’altro che è incompatibile con esso […], una cosa ha una potenza duale. […] Non qualsiasi potenza […] ma la potenza che possiede la caratteristica specifica di ricadere nel giudizio relativo ad azioni future, indica quindi valore o cose dotate di valore. […] La riflessione è il processo che consiste nel trovare ciò che vogliamo, ovvero ciò che, come si dice, vogliamo veramente, e questo significa formare nuovi desideri, nuove direzioni di azione. […] Giudicare il valore significa impegnarsi nell’istituzione di un valore determinato laddove non ve n’è alcuno. Non è necessario che valori determinati siano disponibili antecedentemente quali dati per la valutazione. Inoltre, laddove essi sono dati, sono unicamente termini per la determinazione di un valore non ancora esistente (pp. 34-35).5
La logica dell’avvaloramento è quindi distinta da quella dell’efficienza — vi aggiunge qualcosa, per dirla con Dewey; ciò non implica che non ci si possa (e, invero, ci si debba) accostare alle questioni dell’inclusione (anche) in termini di «efficienza» (ad esempio in riferimento all’adeguato rispetto delle normative e all’uso sapiente delle risorse disponibili); tuttavia, sarebbe esiziale schiacciare il movimento dell’inclusione su questa sola dimensione — in ultima istanza ispirata alla razionalità tecnica (Schön, 2006) — perché si rischierebbe di recidere quel nesso triadico che lega comunicazione-educazione-inclusione nell’ottica dell’ideale democratico, inteso deweyanamente come forma di vita mirante alla crescita dei soggetti e della comunità.
La capacità di formulare giudizi di valori, ossia di avvalorare l’inclusione, dovrà andare a costituire il «carattere metodologico» del/la docente. Riprendo tale nozione da alcuni studiosi del Teachers College (Raup et al., 1950), che nel secondo dopoguerra la proposero nell’ambito di una riflessione su come, in contesti di pluralismo assiologico, la formazione dei docenti dovesse anzitutto essere indirizzata a questioni di valore e all’educazione al giudizio di pratica.6
Il sostantivo («carattere») rimanda al fatto che
[i] giudizi di pratica operano per ricostruire i significati ai fini del ripristino di un’azione più sicura di sé. È quindi di estrema importanza notare che il carattere del soggetto che giudica è esso stesso costituito di significati. Questi significati sono integralmente coinvolti nella situazione insoluta. Essi derivano da precedenti giudizi, propri e di altri. Essi sono forme di abiti, interessi, atteggiamenti, aspirazioni, ideali, concezioni. In quanto personalmente organizzati nel soggetto individuale che giudica, essi costituiscono il suo sé e la sua mente. Non operano in modo freddo e neutrale nella situazione del giudizio. Piuttosto operano secondo preferenze, cercando di imprimere un significato e un’interpretazione prediletta sulla situazione che viene giudicata (Raup et al., 1950, p. 87).
L’aggettivo («metodologico») sottolinea l’esigenza che tale carattere non concerna solo la strutturazione del complesso dei significati ricostruiti o in via di ricostruzione, ma anche l’incorporazione e organizzazione dei metodi e delle tecniche con cui la/il docente è in grado di ricostruire la situazione di intersoggettività che scuote nel senso dell’apertura inclusiva e di ritessere la trama integrale del suo sé.
Per quel che si è venuti argomentando la formazione di tale carattere metodologico dovrebbe avvenire attraverso pratiche che, da un lato, coltivino abilità di pensiero immaginativo-creativo nel loro intreccio con quelle di pensiero orientato a valore (e, in questo senso, il modello della comunità di ricerca filosofica — opportunamente adattato a fini di soggettivazione professionale — potrebbe giocare un ruolo fondamentale: cfr. anche Oliverio, 2022); e, dall’altro, recuperino la tradizione degli esercizi spirituali in quanto pratiche di cura di sé che rendono possibile processi auto-trasformativi attraverso un’interazione attenta con ciò che ci circonda (Brunstad e Oliverio, 2020).
È necessario rispondere, in conclusione, a una possibile obiezione: non si rischia di cadere nella peggiore delle «retoriche dell’inclusione» (stigmatizzate da Oelkers), nel momento in cui si concettualizza l’inclusione come valore, mobilitando nozioni che i classici del pragmatismo formulano in riferimento al fenomeno religioso?
Si è già accennato a come non ci si debba far sviare dalla nostra precomprensione di senso comune circa il termine «religione». Inoltre, si potrebbe richiamare il fatto che si può definire quella di Dewey la visione dell’educazione come religione (cfr. Oliverio, 2020). Ma soccorrono anche alcune considerazioni di Bruno Latour (2015), il quale annota che:
La parola «religione» non fa altro che designare ciò a cui ci si attiene, ciò che si protegge con cura, ciò che dunque si è attenti a non trascurare. In questo senso, è comprensibile che non esista un collettivo irreligioso. Ma esistono collettivi che trascurano molti elementi che altri collettivi considerano estremamente importanti e di cui devono prendersi costantemente cura. Introdurre nuovamente la questione religiosa non significa quindi, prima di tutto, impegolarsi in credenze in qualche fenomeno più o meno strano, ma diventare attenti allo shock, allo scandalo, che la mancanza di cura da parte di un collettivo può rappresentare per un altro (pos. 4337, corsivi aggiunti).
Così argomentando, il sociologo francese radicalizza una folgorante intuizione di Michel Serres (2011) che, lavorando sull’etimo della parola, connessa a un’opera di «legatura», allaccio (di relazioni), ma anche di assemblaggio e collezione, indica la negligenza come il vero opposto del religioso: «Ma non dicono mai che parola sublime la lingua pone di fronte alla religione, per negarla: la negligenza. Chi non ha alcuna religione non deve dirsi ateo o miscredente ma negligente» (p. 81).
Seguendo questa traccia, l’assenza di avvaloramento inclusivo sarebbe una manifestazione di incuria (pedagogica) e l’insegnante non-inclusiva/o un docente negligente. Non è forse questa una definizione adeguata di che cosa si intenda pedagogicamente come «inclusione» in quanto Wertpräferenz?
Bibliografia
Baldacci M. (2024), La scuola inclusiva, «Pedagogia più Didattica», vol. 10, n. 1, pp. 1-4.
Biesta G.J.J. (2014), The Beautiful Risk of Education, Boulder and London, Paradigm Publishers.
Brunstad P.O. e Oliverio S. (2020), Practical wisdom and spiritual exercises in teacher education. What does «being taught» by the ancients mean? In K. Smith (a cura di), Validity and Value of Teacher Education Research, Bergen, Fagbokforlaget, pp. 51-70.
Colicchi E. (2021), I valori in educazione e pedagogia, Roma, Carocci.
Dewey J. (1979), The logic of judgments of practice. In J.A. Boydston (a cura di), The Middle Works of John Dewey, vol. 8, Carbondale, Southern Illinois University Press, pp. 14-82, ed. or. 1915.
Dewey J. (1980), Democracy and Education. In J.A. Boydston (a cura di), The Middle Works of John Dewey, vol. 9, Carbondale, Southern Illinois University Press, ed. or. 1916.
Dewey J. (1984), The sources of a science of education. In J.A. Boydston (a cura di), The Later Works of John Dewey, vol. 5, 1929-1930, Carbondale, Southern Illinois University Press, pp. 1-40.
Emmerich M. (2022), Inklusion/Exklusion. In M. Feldmann et al. (a cura di), Schlüsselbegriffe der allgemeinen Erziehungswissenschaft. Pädagogische Vokabular in Bewegung, Weinheim-Basel, Beltz Juventa, pp. 219-228.
Hoffmann Th. (2018), Inklusive Pädagogik als Pädagogik der Befreiung. Fünf Thesen. In Th. Hoffmann, W. Jantzen e U. Stinkes (a cura di), Empowerment und Exklusion: Zur Kritik der Mechanismen gesellschaftlicher Ausgrenzung, Gießen, Psychosozial Verlag, pp. 19-48.
Joas H. (1999), Die Entstehung der Werte, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
Kastl J.M. (2012), Inklusion und Integration — oder: Ist «Inklusion» Menschenrecht oder eine pädagogische Ideologie? Soziologische Thesen, relazione tenuta nell’ambito dei Friedrichshainer Kolloquien 2012, https://www.imew.de/fileadmin/Dokumente/Volltexte/FriedrichshainerKolloquien/Kastl_Inklusion_und_Integration_IMEW_Okt2012_END.pdf (consultato il 2 agosto 2024).
Latour B. (2015), Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime, Cambridge (UK), Polity, Kindle edition.
Manno D. e Cataldo D. (2024), Diventare autori dell’inclusione. Appunti per la formazione degli insegnanti, «Annali — Università degli Studi Suor Orsola Benincasa», pp. 193-216, https://universitypress.unisob.na.it/ojs/index.php/annali/article/view/2068 (consultato l’8 aprile 2025).
Oelkers J. (2012), Inklusion als Aufgabe der öffentlichen Schule. In S. Seitz et al. (a cura di), Inklusiv gleich gerecht? Inklusion und Bildungsgerechtigkeit, Bad Heilbrunn, Klinkhardt, pp. 32-45.
Oliverio S. (2010), L’inclusione interculturale come frontiera educativa. In M. Striano (a cura di), Pratiche educative per l’inclusione sociale, Milano, FrancoAngeli, pp. 52-79.
Oliverio S. (2020), Tra fede laica e realizzazione dell’umano: per un’educazione religiosa «deweyana»? In G. Baggio et al. (a cura di), Esperienza, contingenza, valori. Saggi in onore di Rosa M. Calcaterra, Macerata, Quodlibet, pp. 155-159.
Oliverio S. (2022), Educazione al giudizio professionale e dilemmi della pratica docente, «Pedagogia Oggi», vol. 20, n. 1, pp. 40-47.
Putnam H. (2004), The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays, Cambridge (MA), Harvard University Press.
Raup R.B. et al. (1950), The Improvement of Practical Intelligence. The Central Task of Education, New York, Teachers College University Press.
Schön D.A. (2006), Educare il professionista riflessivo. Per una nuova prospettiva della formazione e dell’apprendimento nelle professioni, Milano, FrancoAngeli.
Serres M. (2011), Le contrat naturel, Paris, Flammarion.
Striano M. (2014), Inclusione e sviluppo sociale e educazione, «Civitas Educationis. Education, Politics and Culture», vol. III, n. 1, pp. 69-80.
Striano M., Melacarne C. e Oliverio S. (2018), La riflessività in educazione. Prospettive, modelli, pratiche, Brescia, Morcelliana-Scholé.
Young I.M. (2000), Inclusion and Democracy, Oxford, Oxford University Press.
-
1 Professore Associato, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Napoli Federico II.
-
2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Naples Federico II.
-
3 Tutte le citazioni da testi citati dall’originale sono a mia cura.
-
4 È da rilevare come Joas (1999, pp. 274 e sgg.) disegni la sua proposta in nitida distinzione da quella habermasiana che, come detto, presiede al dispositivo concettuale di Iris Young. Non può essere questa la sede di un approfondimento di tale importante snodo teorico.
-
5 Ciò che nella citazione Dewey definisce «valutazioni» corrisponde a quanto si è qui chiamato «avvaloramento».
-
6 È da ricordare che, sulla base di un lettura un po’ semplicistica della teoria deweyana del giudizio, Raup e colleghi presentavano la propria concezione del giudizio di pratica come alternativa a quella di Dewey, laddove qui le si combina. Per un approfondimento di tale questione cfr. Striano, Melacarne e Oliverio (2018, cap. 9).
Vol. 11, Issue 1, April 2025