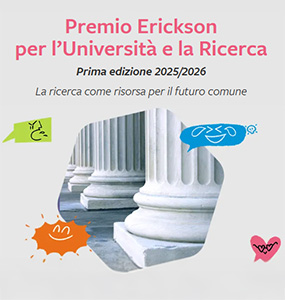Vol. 2, n. 2, ottobre 2025
Indagine sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nei laboratori degli studenti
Sara Pellegrini1
Sommario
Viene presentata una ricerca basata sulla matrice dei dati che si è svolta a maggio 2024 e che ha impegnato 547 studenti del Corso abilitante per Classi Di Concorso dei 30 CFU, impegnando un largo numero di professionisti della formazione umana per esplorare le loro riflessioni sull’introduzione dell’Intelligenza Artificiale-IA nei laboratori attraverso questo studio realizzato mediante un questionario che intende sondare:
- le piste di ricerca significative;
- le infrastrutture a supporto dei laboratori sono pronte a operazionalizzare l’IA;
- la cura dell’extra-curricolare per accogliere il cambiamento apportato dall’IA;
- le credenze e le opinioni.
L’inter-retroazione della vita digitale, con il reale e l’IA nei laboratori, sta ridefinendo il panorama scientifico e sociale. La transizione ecologica nel tessere nuovi paradigmi scientifici e sociali, ci espone alla emergente dimensione On-life che alimenta la relazione tra l’uomo e gli algoritmi di IA, migliorando le strategie del pensiero e le tattiche possibili. I laboratori sono pertanto l’ambiente naturale per promuovere scoperte che trasformano la nostra vita quotidiana e le attività professionali. Pertanto, diviene prioritario sostenere le sfide etiche e pratiche per continuare a promuovere una ricerca responsabile e inclusiva, garantendo che i benefici di queste trasformazioni siano eque e distribuite.
Parole chiave
Intelligenza Artificiale, laboratori, innovazione, ambiente, piste di ricerca.
Survey on the use of Artificial Intelligence in student laboratories
Sara Pellegrini2
Abstract
Research is based on the data matrix is presented that took place in May 2024 and involved 547 students of the 30 CFU Qualifying Course for Competition Classes, engaging a large number of human training professionals to explore their reflections on the introduction of Artificial Intelligence-AI in laboratories through this study carried out through a questionnaire that intends to probe:
- the significant research paths;
- the infrastructures supporting the laboratories are ready to operationalize AI;
- the care of the extra-curricular to accommodate the change brought by AI;
- beliefs and opinions.
The inter-feedback of digital life, with the real and AI in laboratories, is redefining the scientific and social landscape. The ecological transition in weaving new scientific and social paradigms, exposes us to the emerging On-life dimension that fuels the relationship between humans and AI algorithms, improving the strategies of thought and possible tactics. Laboratories are therefore the natural environment to promote discoveries that transform our daily lives and professional activities. Therefore, it becomes a priority to support ethical and practical challenges to continue to promote responsible and inclusive research, ensuring that the benefits of these transformations are fair and distributed.
Keywords
Artificial Intelligence, laboratories, innovation, environment, research paths.
Introduzione
Questo articolo esamina l’uso dell’Intelligenza Artificiale (IA) nei laboratori didattici come strumento di innovazione educativa, affrontando le percezioni e le sfide di 547 studenti. Strutturato in cinque sezioni, l’articolo si apre con un inquadramento teorico sull’IA in ambito formativo, delineando le opportunità e i rischi che l’integrazione di queste tecnologie comporta. La sezione metodologica fornisce una base solida per le riflessioni e mostra come l’IA possa migliorare le competenze in un’ottica relazionale e collaborativa, che si connette con la sezione dedicata a esplorare le implicazioni etiche, sottolineando l’importanza di linee guida che garantiscano un uso inclusivo e consapevole dell’IA. La tesi del saggio sostiene che, con una gestione etica, didattica e educativa, l’IA nei laboratori didattici può preparare gli studenti alle complessità di un mondo interconnesso. Le conclusioni offrono spunti su come questi spazi possano evolversi in ambienti di apprendimento per affrontare le aderenze del presente per il futuro.
La nostra esistenza nella società dei dati (Accoto, 2019) è diventata impensabile senza la presenza di pratiche, di prodotti nonché di servizi e tecnologie (Floridi, 2024). Il termine tecnologia è rappresentativo di un’ampia serie di artefatti che ci consentono di compiere, qui come altrove, altri e ulteriori prodotti materiali e immateriali. Mentre noi siamo intenti a realizzare un qualsiasi progetto nella nostra vita, la tecnologia, mediante la digitalizzazione e l’ottimizzazione dei processi (Panciroli e Rivoltella, 2023), compie un numero plurale di azioni per noi. La rivoluzione dell’IA, espressa attraverso la pluralità sistemica della postmedialità (Eugeni, 2021), della piattaformizzazione (Colombo, 2020) e della datificazione (Panciroli e Rivoltella, 2023), ci permette di estendere e intensificare la nostra funzionalità, evitando attività indesiderate e permettendoci di focalizzarci su ciò che desideriamo veramente. Ci consente infine di approcciare alle attività in modo diverso, spesso con risultati migliori. L’IA esegue con precisione ogni compito assegnato, reiterando le operazioni in modo efficace, soprattutto se arricchita da informazioni rilevanti, che attraverso una maggiore interazione dialogica, le permettono di riorganizzare il design delle informazioni in combinatorie divertenti e creative. Qui avviene il superamento dell’agentività, che ibridandosi con l’IA genera l’agentività artificiale (Floridi e Cabitza, 2021). L’attributo di artificiale acquisisce una connotazione piena di umanità (Carr, 2023), poiché «le tecnologie sono artificiali, ma — di nuovo il paradosso — l’artificialità è naturale per gli esseri umani» (Panciroli e Rivoltella, 2023, p. 35).
L’umanità da sempre converte il vecchio per il nuovo, metamorfosandone le movenze (Morin, 2022): la transizione attiva un corso-forzoso culturale che genera nuove esperienze relazionali. Laddove avviene la trasformazione si avvera l’unicità. Partendo dal presupposto che ogni trasformazione è unica, dobbiamo anche considerare che «alcune di queste hanno cambiato in maniera irreversibile il modo i cui comprendiamo noi stessi, la nostra realtà e l’esperienza che ne facciamo, con implicazioni complesse nel lungo periodo». (Floridi, 2022, p. 11).
È emozionante essere consapevoli di essere gli ultimi dei viventi analogici e sapere che le nuove generazioni potranno solo immaginare come era la realtà offline: a noi è stata donata la responsabilità di guidare l’umanità nella transizione digitale per edificare lo scambio etico che sottende la spinta intergenenerazionale (Floridi, 2024), affrontando quei problemi etici che si disvelano nel rapporto con la tecnologia, comportando una visione fatta di relazioni per comprendere le interazioni tra la persona e l’ambiente, tra gli studenti e il laboratorio, tra l’uomo e l’algoritmo, nonché tra l’algoritmo e il mercato. Ciò comporta una postura sempre aperta per avere cura della propria mente (Mortari, 2022), che non rinuncia a porsi e a porre domande sull’individuo, sulla personale autonomia, su chi si vuole essere, su chi si può diventare, sui desideri, sulle necessità e sulle preferenze. Molte sono le considerazioni sulla datificazione, sull’IA e sul protagonismo degli algoritmi (Innerarity, 2022), che farebbe echeggiare il timore dell’algocrazia (Eugeni, 2021) anche nei laboratori.
«Proprio per questo motivo, ogni analisi di come si possa educare all’IA, nella prospettiva della Media Literacy, ovvero dello sviluppo di responsabilità e senso critico, non può che prendere le mosse da un inquadramento del significato della cittadinanza al tempo del digitale» (Panciroli e Rivoltella, 2023).
Onlife e laboratori: le virtù
Una società giusta affida alla pedagogia il compito di vivificare personalità non viziate da pregiudizi e che sono pluralisticamente disposte a riconoscere i valori, le tradizioni e a comprendere il significato civilizzatore della solidarietà (Sandel, 2020). L’Onlife e il suo essere nei laboratori, soprattutto quelli medici hanno acuito le due criticità paradigmatiche dell’etica e della giustizia, che sono costitutive di regolarità e di punti di equilibrio, ovvero le virtù.
Le riflessioni di molti autori sulle discontinuità del secolo (Malavasi, 2022) vengono a confermare tutti quei cambiamenti delle informazioni che partono debolmente dalle piazze, attraversano le strade per modificare i trasporti e divenire vere e proprie infrastrutture della mente: la transizione si deve misurare con almeno due scenari in movimento, quali quella del cosmo (Bawden e Robinson, 2016), ovvero di quella rete di interconnessioni di cui nessuno potrà più fare a meno e quello regolativo della giustizia. Avendo questi abolito il fattore della distanza e del fare e avendo, quindi, ridefinito il rapporto spazio-temporale e modale delle relazioni, succede che i movimenti tellurici di rango elettronico scuotono anche i valori delle concezioni classiche dell’uomo e quindi l’idea di giustizia, intesa come virtù completa, quale principio costitutivo della norma stessa capace di comprendere tutte le altre poiché veicola l’idea regolativa di giustizia.
L’etica delle virtù trova le sue origini nell’Etica nicomachea di Aristotele, dove queste, le virtù, rappresentano un punto di equilibrio tra due estremi, il giusto mezzo. Il coraggio, ad esempio è una virtù in quanto rappresenta il punto dell’equilibrio tra la codardia e la temerarietà. Anscombe, nel suo influente articolo Modern moral philosophy, nella critica alle teorie etiche contemporanee, come il consequenzialismo e il deontologismo, sostiene quell’approccio aristotelico più radicato nel carattere e nelle virtù, poiché ha rilevato che molte delle teorie etiche moderne si basano su concetti privi di fondamento, come l’obbligo morale senza un contesto teleologico che lo giustifichi (Anscombe, 1958). MacIntyre, nel suo celebre libro After virtue, nell’ampliare la critica di Anscombe, pone al centro della crisi dell’etica moderna la perdita di un consenso condiviso su cosa costituisca la vita buona, credendo che solo tramite la riscoperta delle virtù, radicate in pratiche sociali e comunità, possiamo ristabilire una base solida per la moralità (MacIntyre, 1981). Egli sottolinea come «una virtù sia un’abitudine acquisita di tipo pratico che conduce a una buona vita per l’essere umano» (MacIntyre, 1981). L’etica delle virtù trova ampio consenso e applicazione nei vari contesti contemporanei, quali la bioetica, esaminando come le virtù possano guidare le decisioni mediche. Pellegrino e Thomasma, in The virtues in medical practice, hanno esplorato come le virtù come la compassione, la saggezza e l’integrità siano fondamentali per una vita medica etica (Pellegrino e Thomasma, 1993). Le critiche all’etica delle virtù spesso si concentrano sulla sua presunta mancanza di capacità di fornire una guida chiara in situazioni dilemmatiche. Slote, in Morals from motives, ha tentato di rispondere a queste critiche sviluppando una versione della teoria delle virtù che integra elementi di motivazione morale, cercando di risolvere i problemi legati alla relatività culturale delle virtù (Slote, 2001). Nonostante le critiche, l’etica delle virtù rimane una componente vitale del dibattito etico contemporaneo, offrendo una prospettiva unica e ricca sull’importanza del carattere morale. Come afferma Annas in Intelligent virtue, «le virtù non sono solo disposizioni passive, ma capacità attive che guidano il nostro comportamento e la nostra crescita morale» (Annas, 2011). Pertanto, quella che dai tempi della Grecia ad oggi è dedita alla costruzione della buona persona, deve essere elevata alle nuove richieste di sistematicità che emergono proprio dalle circostanze dettate dal mutamento. In una tale prospettiva occorre condurre riflessioni che abbracciano il laboratorio nella sua sistematicità con le comunità, le società, lo Stato e non ultime le Università, per domandarci che tipo di pensiero vorremmo costruire. Tali domande sono imprescindibili e richiedono sensibilità per le frequenze del mondo. Il nostro futuro e la nostra società saranno completamente diversi da quelli attuali; pertanto, le regole possono aiutare a definire le caratteristiche della società futura, soprattutto sulla tecnologia. L’Europa è molto attenta alla generazione di regole. Abbiamo una via europea alle regole per l’Intelligenza Artificiale che ha come suo unico punto di riferimento una parola chiave che si chiama Welfare, quale civiltà del domani fatta di diritti umani. Questa è la strada europea, questa è la strada del futuro e pur trattando di laboratori e di tecnologia alla fine si ritorna sempre all’umano, poiché la più grande tecnologia di sempre è l’uomo (Morin, 2022). Quindi prima ancora di armeggiare strutturalmente, per non creare condizioni critiche congiunturali, nei laboratori con l’IA abbiamo bisogno di chiederci che tipo di uomo abbiamo in mente per il nostro futuro e quale umanità. Ecco possiamo pensare a un uomo che cura e contestualizza l’intelligenza artificiale digitale e di una umanità che accompagna il cambiamento e che «prende in carico» le plurali forme di capacità di azione. «Il modo in cui gli individui entrano in contatto con le tecnologie digitali non è un processo univoco» (Elliott, 2021). Occorre pertanto che i laboratori definiscano le condizioni per gestire la capacità di azione che il digitale sta creando, implicando una particolare sensibilità all’innovazione della nostra governance, poiché la tecnologia in ogni sua forma acquisisce una neutralità personale e contestuale che genera problemi di equilibrio di awareness, trustworthyn ed explainability (Panciroli e Rivoltella, 2023). Nonostante le preoccupazioni, si presenta uno scenario incredibile che non può che infondere ottimismo, seppure le opportunità del futuro dipendano ora come allora dalla nostra capacità di operare in favore dell’agentività, delle inter-retroazioni tra lo studente e il docente, l’alfabetizzazione, i diritti, nonché la responsabilità e la fiducia.
Laboratorio come percorso
La didattica come scienza si pone come un percorso che conduce all’approccio con l’universo culturale umano. La cultura della didattica si manifesta come impegno autonomo e scientifico, nonché conoscitivo, a recuperare le pluralità dei contributi che discendono dalle altre scienze (Crispiani e Moliterni, 2022). La didattica è un tentativo sistematico di fondare sul piano epistemologico un sapere destinato a nutrire l’uomo di contenuti funzionali da spendere tra mediazioni e ambienti di apprendimento pieni di operosità. La storia della didattica laboratoriale fornisce un campionario abbastanza vario di proposte che tendono a implementare le nuove relazioni euclidee in una pluralità di orizzonti culturali che insistono sul pensiero dello studente, caratterizzando il laboratorio e dilatandone il significato. Il laboratorio nel rispondere all’emergenza del problema della cultura, del linguaggio e del pensiero diviene quello spazio dove si opera sulle connessioni bio-antropologiche per mostrare come l’uomo sia, allo stesso tempo, totalmente biologico e culturale, ibridando le nuove interazioni del linguaggio con la cultura. L’emergenza della mente presuppone nuove interazioni del linguaggio con la cultura. Pertanto, l’introduzione dell’IA nel laboratorio presuppone operazioni linguistiche interagenti per accompagnare il fenomeno del ricercatore poliglotta (Rossi, 2009), per essere in quel dialogo dialogale (Panikkar, 1990). Bisogna poi apprendere a conoscere, cioè a collegare, ad analizzare e a sintetizzare insieme con atteggiamento sussuntivo proprio della pedagogia trasformativa (Crispiani, 2004). Pertanto, l’introduzione dell’IA nel laboratorio presuppone operazioni linguistiche interagenti per accompagnare una riflessione mirata al ruolo della meta-tecnologia e alla sua dimensionalità nella progettazione educativa (Pagliara et al., 2024).
Laboratorio e IA rappresentano entità legate inscindibilmente al proprio ambiente, le quali possono essere conosciute solo nella loro relazione contestuale e ciò comporta l’ampliamento della prospettiva per corredare il laboratorio non di tool o app in più, ma di strategie che profilano il pensiero a orizzonti scientifici e tecnologici inediti. L’integrazione dell’IA nei laboratori degli studenti, in particolare nell’approccio Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics-STEAM, riflette una tendenza crescente all’uso strategico di tecnologie per migliorare i risultati e l’accesso all’istruzione, attraverso le tattiche strutturate o semi-strutturate (Panciroli e Rivoltella, 2023). Questo approccio è esplorato da Almasri, che discute il potenziale degli strumenti basati sull’IA per ricreare complessi test scientifici attraverso laboratori virtuali (Almasri, 2024). Gli studiosi hanno osservato che ciò migliora l’apprendimento esplorativo e democratizza anche l’accesso a una formazione scientifica di alta qualità. Questi ambienti virtuali consentono agli studenti di eseguire esperimenti che sarebbero poco pratici o pericolosi in contesti tradizionali, estendendo così le opportunità educative oltre le aule convenzionali, come nei laboratori distribuiti in cloud oppure inseriti in contesti reali particolari. Nel regno dell’apprendimento personalizzato, ricercatori come Shiva e colleghi evidenziano che il mix dell’IA permette di adattare i contenuti educativi alle esigenze dei singoli studenti, ottimizzando così le esperienze di apprendimento, anche mediante il tracciamento del processo di apprendimento (Shiva et al., 2024). Pensiamo ai sistemi di tutoraggio intelligenti, Intelligent Tutor Assistant (ITA) o Intelligent Tutor System (ITS), che adattano il ritmo e la complessità del materiale in base ai progressi di uno studente (Panciroli e Rivoltella, 2023). Nel panorama scientifico italiano è interessante accennare anche a Tutorbot, frutto di un pionieristico progetto dell’Università della Calabria (De Pietro, 2006). Le strategie di tutoring sono state studiate anche da Bastani e colleghi, i quali hanno osservato come gli studenti ai quali sono stati offerti suggerimenti incrementali mediante specifici prompt, senza offrire loro soluzioni complete si è incoraggiato l’apprendimento autonomo, dimostrando come il tutor può concorrere a incrementare le prestazioni durante le sessioni pratiche assistite se supportato da strategie didattiche (Bastani et al., 2024).
I molti lavori che prendono corpo nei laboratori e che orami operano quotidianamente ibridazioni e integrazioni dell’IA nell’istruzione, come notato da Adams e colleghi e da Poornesh, non possono che generare dubbi, preoccupazioni sulla privacy e azioni plurali volte a garantire un accesso equo e inclusivo agli strumenti con l’IA per combattere i pregiudizi e le problematiche insiti negli algoritmi (Adams et al., 2022; Poornesh, 2024). L’uso etico dell’IA richiede una riflessione critica sulle implicazioni pedagogiche e sugli impatti sociali, sostenendo un quadro etico completo per guidare l’integrazione delle tecnologie di IA negli ambienti educativi, poiché la tecnologia può modificare il sé degli studenti (Elliott, 2021). Nonostante ciò, la presenza di IA nei laboratori degli studenti presenta plurali vantaggi processuali nelle operazioni con i dati, nell’autovalutazione, nonché sulla gestione del feedback e del coworking (Pagliara, Bonavolontà e Mura, 2024): nei laboratori si costruiscono nuove «concatenazioni di senso», influenzando i progressi della tecnologia e regolando sia l’etica, che la pratica. I contributi di questi ricercatori forniscono una base per comprendere quali sono gli spazi di intersezione il potenziale dell’IA nei processi evolutivi, evidenziando l’importanza di una valutazione e di un adattamento continui della relazione tra l’uomo e le tecnologie per soddisfare ciò che appartiene all’educativo e all’etica. La ricerca nei laboratori didattici ha identificato una pluralità di strategie che possono modellare il processo di apprendimento attraverso esperienze attive e pratiche: ad esempio l’uso dell’apprendimento esperienziale, basato sulle teorie di Gobbo e colleghi, sottolinea l’importanza di coinvolgere gli studenti in un ciclo di esperienza, riflessione, concettualizzazione e sperimentazione (Gobbo et al., 2024). L’apprendimento basato sull’indagine, supportato da studiosi come Krajcik e Shin, implementa la creazione di ambienti in cui gli studenti generano ed esplorano le loro domande, promuovendo un’indagine scientifica più approfondita e un pensiero critico (Krajcik e Shin, 2023). Gli studi sull’apprendimento collaborativo (Chounta, 2020) espongono i vantaggi delle interazioni tra i partecipanti nei laboratori, migliorando la comprensione attraverso attività e discussioni condivise. L’integrazione della tecnologia (Linn et al., 2023) ha ampliato le capacità dei laboratori attraverso simulazioni virtuali, poiché operando sui processi di realizzazione degli esperimenti, quelli complessi risultano essere maggiormente accessibili e sicuri. Le strategie laboratoriali relativi ai processi della valutazione (Brookhart, 2023), sostengono che il feedback a sua volta incide sull’apprendimento piuttosto che sulla valutazione delle prestazioni degli studenti. Particolarmente interessante è il lavoro di Zimmerman sull’apprendimento autoregolato che illustra come i laboratori aiutino a sviluppare quelle competenze di apprendimento critico per tutta la vita, come l’autovalutazione e l’adattamento (Zimmerman, 2022). La pluralità dei modi di approcciare all’apprendimento nei laboratori, dinamici e inclusivi, nutre l’autenticità delle strategie del pensiero, assicurando ai laboratori il ruolo di ambienti di apprendimento fondamentale per gli studenti.
Metodo e risultati
Il questionario è stato autoprogettato e distribuito in modalità sincronica a 547 partecipanti attraverso la piattaforma Survey Monkey (Survey monkey Inc.). Ogni iscritto al corso dei 30 CFU ex art. 13 poteva partecipare al sondaggio una sola volta a maggio 2024 ed è stata vivamente raccomandata l’attenta partecipazione, soprattutto per le domande aperte. Si potevano tralasciare delle domande e perciò il numero totale delle risposte non corrisponde sempre perfettamente al numero intero dei partecipanti. Le domande dell’indagine sono state divise nelle seguenti cinque categorie esplorative.
- Caratteristiche antropologiche: riguardanti il profilo professionale, il genere, la loro distribuzione demografica e il titolo di studio. Non ho chiesto la distribuzione geografica poiché essendo nota all’iscrizione potevamo osservare che essi coprono significativamente l’intera Nazione. Caratteristiche conoscitive. Questa sezione ha indagato le infrastrutture cognitive dal punto di vista della conoscenza, competenza e i requisiti per accedere alla riflessione. Si vuole esplorare il loro vissuto laboratoriale e cosa pensano del laboratorio, quale strategia didattica.
- Caratteristiche funzionali: si sono esplorati gli aspetti relativi all’operatività funzionale degli studenti.
- Caratteristiche riflessive: si sono indagate le opinioni sulla qualità dell’insegnamento sull’intelligenza artificiale nei laboratori, come i partecipanti valutano la qualità delle strutture per supportare l’apprendimento sull’intelligenza artificiale, la soddisfazione delle attività extracurricolari disponibili per approfondire la conoscenza sull’intelligenza artificiale e se considerano l’IA un acceleratore del pensiero.
- Caratteristiche strumentali: gli organizzatori hanno verificato l’adeguatezza degli strumenti digitali, assicurandosi che le infrastrutture fossero adeguate dal punto di vista informatico per quel che riguarda il setting tecnologico di hardware, software e area personale e connettività e uso della piattaforma cloud. I risultati sono stati infine valutati e rappresentati utilizzando il software SurveyMonkey.
L’indagine ha coinvolto per lo più donne, docenti e aspiranti tali. I risultati mostrano una distribuzione d’età variegata, con picchi tra i 30 e i 50 anni, e anni di laurea concentrati intorno al 2004, 2006, 2014 e 2019. L’analisi evidenzia che l’esperienza laboratoriale ha un impatto significativo sul percorso formativo, soprattutto grazie alla chiarezza espositiva e all’uso di mediatori didattici, apprezzati da quasi tutti i partecipanti all’indagine. Inoltre, il laboratorio stimola competenze trasferibili, ma l’uso dell’IA è considerato efficace seppure con scarso impatto sulla motivazione. Pertanto, l’inclusione e la collaborazione sono elementi chiave, che contribuiscono a una crescita professionale e all’approfondimento delle competenze educative. Le risposte suggeriscono infine una buona percezione dell’insegnamento dell’IA, pur evidenziando la necessità di ampliare le attività extracurricolari per favorire ulteriori ricerche e applicazioni pratiche.
Discussione
L’indagine condotta fornisce una panoramica complessa e dinamica sull’efficacia del laboratorio corredato di IA e delle infrastrutture disponibili nell’ambiente di apprendimento, mostrando una percezione generalmente positiva evidenziata dalla valutazione complessiva della qualità dell’insegnamento dell’IA come buona. Questo riflette un apprezzamento significativo per la didassi laboratoriale e l’accessibilità delle risorse. Gli intervistati hanno esposto un alto livello di fiducia riguardo le attività extracurricolari e le infrastrutture come le biblioteche, che giocano un ruolo cruciale nel supportare l’apprendimento e la ricerca sull’IA. L’attenzione che i partecipanti rivolgono alla pluralizzazione delle risorse è vicina alle perplessità che l’UNESCO esprime anche nella Digital Learning Week del 2024, dove si evidenzia come la velocità di fruizione di IA sia più vorace dell’adattamento della didattica e dei «saperi sapienti», generando un disequilibrio tra innovazione e formazione, nonché tra la transizione green e quella digitale. Il disallineamento è tale, che le Nazioni sono intente a promuovere l’uso responsabile delle tecnologie digitali in educazione, evidenziando le seguenti criticità: la carenza di Linee guida per l’IA, tanto nelle scuole quanto nelle università, rivelano questioni irrisolte che incidono profondamente sul valore della formazione umana; poi ci sono le innovazioni legate ai libri di testo che portano con sé sfide complesse poiché si tratta di dilemmi che toccano la responsabilità educativa e aprono interrogativi fondamentali sull’etica, sull’equità e sul diritto allo studio; non ultimo il pensiero comparativo e riflessivo che il laboratorio dovrebbe generare poiché esso non colloca adeguatamente nel percorso didattico lo strumento IA, quale risorsa tattica in favore dello studente, ma tutto sussiste ancora in un regime di approssimazione e di consuetudinarietà. Malgrado le criticità, l’IA comunque comporta nuovi percorsi della mente dai quali emergono spazi di miglioramento, allorquando essa è offerta agli studenti all’interno di una strategia didattica con fare educativo di precisione e con funzione di tutor processing.
Tutti questi aspetti possono essere pensati nelle proprie realtà istituzionali, quale la scuola e quale università, in quanto dalle Linee Guida generali e sovranazionali sull’IA dovrebbero scaturire percorsi di contestualizzazione per ogni istituzione educativa. Solo così esse diventerebbero dinamiche, contestuali e strettamente collegate al territorio, andando oltre l’autoreferenzialità, per intrecciarsi in modo profondo con il curricolo formativo e le operazioni cognitive che lo sottendono. La società conoscitiva sembra richiedere pertanto alla didattica una dilatazione di senso per schiudere a movimenti metacognitivi interattivi e comparativi. Quindi si auspica la non generazione di operazioni isolate e disgiunte, poiché è essenziale promuovere nella didattica quell’approccio problematicista che comporta il superamento dei confini infradisciplinari e transdisciplinari. Ne consegue pertanto la costruzione di una didattica che superi i confini disciplinari per tessere un sistema concettuale capace di identificare quei «connettivi sinaptici» che alimentano la rete interdisciplinare e il pensiero. Questo approccio all’IA nei laboratori punta a intrecciare saperi diversi per promuovere una revisione profonda del pensiero e una metamorfosi della conoscenza, ricomponendo l’aiuto allo sviluppo secondo una visione globale e unitaria. Attraverso la prospettiva transdisciplinare, si abbraccia quindi un’idea ecologica ed ecosistemica del mondo, dove ogni sapere contribuisce a una nuova organizzazione cognitiva e riflessiva. Quest’ultima deve essere pronta a operare con l’IA, integrando le tecnologie emergenti in un sistema laboratoriale interconnesso e flessibile, capace di affrontare con un atteggiamento critico e riflessivo le complessità e le sfide del nostro tempo.
L’intensità aumenta ancor più quando il dibattito si concentra a pensare l’IA quale possibile acceleratore del pensiero, un concetto esplorato in diversi studi volti a estendere le capacità cognitive umane mediante l’IA stessa (Panciroli e Rivoltella, 2023). La maggior parte degli intervistati ritiene che l’IA possa effettivamente ampliare le capacità cognitive, facilitando nuove forme di apprendimento e innovazione, che però sembrano assumere le movenze di una cognizione critica e attenta a considerare tutti quegli aspetti rilevati da Zhang e Aslan (Zhang e Aslan, 2021). Tale percezione è espressione di un elevato grado di ipercomplessità poiché molteplici sono i fattori da tenere in debita considerazione e plurali sono le domande da porre. Se per accelerazione del pensiero intendiamo la sollecitazione di «zone di sviluppo prossimali» mediante l’IA, allora la didattica laboratoriale non può non elicitare esperienze di interpretazione del testo, qualunque esso sia, come anche la riflessione e la produzione di domande o prompt per operare con l’IA. Contemporaneamente lo studente, che è immerso nell’esperienza laboratoriale, sviluppa conoscenze e competenze essenziali al laboratorio quale momento apprenditivo unico. Esso compiere una stima dei vantaggi e dei costi della strategia utilizzata, apportando modifiche di processo e opportune modellizzazioni, stabilizzando la funzione di monitoraggio che dovrebbe sostenerlo proprio allorquando si presentano quei problemi legati all’explainability e ai bias. Ecco che mediante la didattica il percorso situato e partecipato poiché le preferenze tattiche, selezionate nei laboratori, sono per lo più dialogate, nonché dialogiche, e volte alla caratterizzazione della cultura del laboratorio e delle professioni, generando il linguaggio, le convinzioni e differenti gradi di consapevolezza e d’interesse.
L’approccio cognitivo e interattivo all’IA nei laboratori imprime nell’azione cognitiva quel fare anticipatorio, dove lo strumento è già presente nelle rappresentazioni mentali dello studente già quando inizia a tracciare i primi pensieri e le prime operazioni, tra scritture, riscritture e correzioni, ipotizzando dove e quando e come impiegare l’IA. Quindi l’enfasi sulla processualità implica il farsi dell’azione e il suo controllo: in questo modo si allenano gli studenti anche ad essere allertati rispetto ai possibili bias e ad essere coscienti dell’explainability, poiché l’attenzione al processo e al monitoraggio delle fasi riguarda anche la valutazione complessiva dell’azione globale e la sua applicazione. Perciò nel laboratorio si dovrà essere attenti non solo alla capacità di esecuzione ma anche alla capacità di padroneggiare le fasi e le risorse impiegate e alla trasferibilità della procedura stessa.
Seppure al laboratorio partecipano studenti con differenti gradi di expertise possiamo dotare gli stessi di strumenti cognitivi strategici comunque sottesi da una didassi unitaria, senza segmentare gli obiettivi formativi e il processo operativo, preservando lo script e il senso delle opportune modellizzazioni delle procedure mediante azioni di scaffolding per supportare la persona inesperta ad essere accompagnata nel percorso mediante l’uso di IA nei momenti critici dell’esecuzione di un compito cognitivo. In entrambi i casi, sia del soggetto esperto che del soggetto non esperto, l’azione pedagogica, anche in virtù dei talenti, è volta ad accompagnare i processi per orientarli attraverso quella spinta didattica che delinea una esperienza di apprendimento tattica, coerente e organizzata e che seleziona il suo percorso, ponendo attenzione al modo in cui le idee sono connesse, i punti di passaggio tra un’operazione e l’altra e l’organizzazione delle fasi e delle azioni. Ciò è supportato dall’elevato grado di interazione e collaborazione osservato nei laboratori, dove l’IA tende a stimolare un apprendimento più dinamico e interattivo. Nonostante l’ampio riconoscimento delle potenzialità dell’IA, i feedback indicano che il suo impiego non è ancora pienamente efficace nel motivare gli studenti o nel garantire l’acquisizione di competenze, con solo il 10% dei partecipanti che riporta un apprendimento significativo di nuove competenze attraverso l’uso dell’IA (Baker e Siemens, 2014). Questo suggerisce la necessità di una attenta operazionalizzazione dell’IA nei processi didattici e una sua dedicata calibrazione, proprio per rispondere con pertinenza alle esigenze educative specifiche degli studenti, che ad oggi utilizzano l’IA principalmente per risolvere difficoltà immediate e per aumentare il grado di organizzazione di qualcosa che non padroneggiano.
Le complessità aumentano allorquando proviamo a contestualizzare strategicamente l’IA: ciò avviene quando la collochiamo nelle operazioni formali, ma con una interattività culturale, storica e istituzionale, volta a declinarla in quel raggio di azione dove le persone studiano, agiscono e operano. Pertanto, il successo di IA rispetto ai guadagni formativi dipende dal sistema di abilità e di significati culturali che il laboratorio riesce a organizzare e a condividere. Quindi, l’IA incontra la sua natura cognitiva quando incarna la concezione situata dell’operare e quando gli studenti generano pratiche di azione relazionali per comunicare strategicamente con l’IA, ovvero come porre domande, come generare i prompts e come avere il controllo dei processi e dei risultati o attivare altre operazioni quando il risultato è non idoneo o è inaspettato, divenendo un vero e proprio contesto interattivo. Ciò schiude a una comunità di discorso di nuova generazione che organizza, elabora e negozia, tra algoritmi e riflessioni, pratiche di co-costruzione.
È soddisfacente notare come il lavoro svolto dalla comunità scientifica e professionale abbia consolidato questioni civiche essenziali, quali la collaborazione, l’inclusione e le riflessioni sulle azioni che in questa ricerca si palesano imprescindibili e costanti: è infatti evidente come quegli aspetti quali l’interesse generale e duraturo sono suscitati dall’ambiente di apprendimento, come anche dall’efficacia del docente che predispone l’ambiente di apprendimento, permettendo agli studenti di sviluppare competenze generalizzabili, trasformative e quindi trasferibili. Non solo, l’incremento delle pratiche di IA tende a concentrare inaspettatamente le risorse sulle attività extra-disciplinari e a confermare che l’evoluzione dell’uomo nuovo per un Emilio Contemporaneo (Morin, 2022) vuole favorire un pensare accorto che coglie la complessità del reale. Quindi se si credeva che l’IA avrebbe comportato in modo inesorabile l’aumento delle solitudini, al contrario essa può contribuire a generare nell’uomo l’istanza di cura educativa e di aiuto quale spazio per la vita e per un pensare pluralistico.
Il valore di questa esplorazione trova la sua sorgente in quegli ambienti di apprendimento supportati dall’IA che debbono essere corredati di un assetto epistemologico robusto, basilare per affrontare sia le sfide relative alla sua implementazione, che le riflessioni in situazione sulla relazione studente-laboratorio-IA. Occorre infatti lavorare per tessere le premesse di una equilibrata dimensione per supportare le future generazioni di docenti nell’infondere interesse e motivazione tra gli studenti. Si suggerisce, quindi, un approccio più focalizzato sulle dinamiche interattive infrastrutturali e sulle personalizzazioni distribuite, affinché l’onlife possa divenire una realtà autentica. Nel superare quella cultura, che da Platone ad oggi, ha osservato il mondo separando l’esterno dall’interno (Rossi, 2009), il nuovo assetto culturale che procede con una dialettica metamorfosata, ha bisogno di accompagnare il cambiamento attraverso le sinergie scientifiche, pervadendo la realtà didattica di innovazione, mediante un aiuto intenzionale alla processazione dell’IA nei laboratori, per favorire la riflessione in relazione alla consapevolezza etica, al dominio di lavoro, alle relazioni transdisciplinari, a procedure e risorse autentiche, un linguaggio proprio e con una propria letteratura, nonché alla percezione della necessaria convergenza di più professionisti che insistono sull’IA nei laboratori. Il prolungamento delle azioni già iniziate dalle precedenti interpretazioni che a loro volta comportano delle torsioni semantiche esprimono le reinterpretazioni (Rossi, 2009) che, schiudendo a una ecologia di secondo livello (Crispiani, 2019) debordano verso un vero e proprio sistema pedagogico e didattico caratterizzato da un corredo tecnologico plurale (Crispiani, 2019) che attira un percorso di ri-generazione (Gaspari, 2021) esperienziale per ricondurre a unità l’ecologia, l’azione e non ultimo il fine quale processo di umanizzazione.
Conclusioni
Il presente studio ha esplorato l’impiego dell’IA nei laboratori nell’ambito dell’educazione superiore, focalizzandosi sull’efficacia del laboratorio nei suoi molteplici aspetti e sull’utilizzo delle risorse in laboratori dedicati all’IA. Attraverso la pluralità delle riflessioni sono stati identificati aspetti chiave della relazione tra lo studente e l’IA nel contesto laboratoriale. Il metaruolo del campione, che è allo stesso tempo docente e studente, ci rivela come la complessità dell’«unidualità» (Morin, 2022) non riesca comunque a ricomporre un quadro armonico dei risultati: questi ultimi, infatti, sono per lo più positivi ma in modo frammentario, il che ci porta a riflettere sul «dislivello prometeico» (Anders, 1992). Le difficoltà legate all’incertezza, alla parcellizzazione del senso e alla debolezza etica fanno emergere la speranza derivante dall’autopoietica dei sistemi viventi e dalla galimbertiana visione dell’uomo quale «animale non ancora stabilizzato» (Rossi, 2009).
Laddove erranza e incertezza diventano i vettori principali della svolta paradigmatica, l’umanità accetta la sfida delle sfide: costruire reti di connessione attraverso le alleanze intergenerazionali e i legami scientifici dei laboratori arricchiti dell’IA per i contesti di vita, affinché la loro organizzazione didattica possa incrementare la cura dell’ambiente di apprendimento, quale catalizzatore di trasformazioni personali e sistemiche. La cura delle connessioni, che da generazionali diventano generative e la continuità degli scambi, nonché la possibilità di operare con strumenti innovativi inseriti in un contesto didatticamente orientato alla implementazione del pensiero critico e collaborativo, offrono agli studenti esperienze formative e opportunità trasformative. Le ricerche, però chiariscono che l’IA apporta benefici agli studenti quando è utilizzata in maniera strategica e riflessiva dal punto di vista didattico, diventando uno strumento operante all’interno del processo di umanizzazione nella sua globalità. Ciò comporta la cura dei percorsi educativi stessi dedicati alla formazione umana, che valorizzino la personalizzazione e la crescita individuale in un contesto collettivo e inclusivo. Pertanto, la lavorazione ad alta granularità delle Linee Guida per un uso responsabile e mirato dell’IA nei laboratori diviene imprescindibile per tradurre adeguatamente le potenzialità dell’IA in esperienze concrete e significative.
Promuovere questa visione significa preparare gli studenti ad affrontare le complessità della società digitale, fornendo loro gli strumenti per diventare cittadini consapevoli e innovatori responsabili del futuro. Se sin dall’inizio della storia ad oggi, la parola quale unità minima di significato consentiva all’uomo di produrre un numero infinito di messaggi attraverso le infinite combinatorie che si concretavano nella frase, ora invece con l’IA lo studente per accedere alla comunicazione deve porsi in una specifica modalità interrogativa e relazionale mediante i prompts: ovvero quell’insieme di dati, informazioni, istruzioni, rappresentativi di un insieme operativo, che descrive ciò che si desidera generare con la frase finale, la quale è molto simile a una serie di note e accordi poste in sequenza (Manzo, 2023), ovvero in un pentagramma. Questa rivoluzione, che è comunicativa, relazionale, motivazionale, cognitiva e intellettiva, richiede un percorso di apprendimento che offre allo studente un adeguato grado di preparazione dedicata al mondo dell’IA e il docente, selezionando le opportune scelte didattiche introduce agli studenti le nuove trame relazionali per guidare, accompagnare e monitorare gli stessi nel percorso di apprendimento, rilevando come essi reagiscono all’esposizione al mondo dell’Onlife (Rosati e Sebastiani, 2021).
L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nel contesto educativo rappresenta quella svolta decisa a interpellare il reale per richiedere una profonda riflessione sulle implicazioni pedagogiche, didattiche e valoriali. La visione inclusiva, espressa in modo particolare dai partecipanti di questa ricerca, fornisce all’intero sistema didattico gli strumenti per comprendere e promuove un approccio che rispetti e valorizzi la diversità e l’inclusione educativa. Il laboratorio si palesa quindi quale scelta significativa poiché lontano da ogni approccio rigido e predeterminato, consente alla comunità scientifica e professionale di osservare l’innovazione mediante una prospettiva pedagogica interattiva con l’IA che sia flessibile, dinamica e aperta, offrendo la possibilità di interpretare la tecnologia in modo adattivo, rispondendo alle esigenze mutevoli degli studenti e della società.
L’ambiente di apprendimento laboratoriale non può limitarsi a pensare solo al fare laboratoriale, ma deve sia intraprendere una profonda riflessione sulle implicazioni etiche e sociali dell’uso dell’IA nel contesto di apprendimento, sia concepire il momento laboratoriale quale luogo dove gli studenti apprendono a porsi domande etiche complesse che coniughino il dirompente utilizzo di IA, ma ancor più «l’esserci con altri» (Heidegger, 1999). La spinta civica del processo di inclusione diviene quella forza promotrice di una mediazione etica, che nel contestualizzare l’uso dell’IA nel processo di apprendimento tende a generare le influenze dell’ambiente di apprendimento, trasformando l’IA in un possibile mezzo per favorire l’emancipazione sociale e individuale degli studenti. Gli strumenti tecnologici devono quindi essere utilizzati con discernimento, come supporti che arricchiscano l’apprendimento e aiutino a raggiungere guadagni formativi autentici e significativi. Osservare il sorgere dell’umanesimo tecnologico ci offre il vantaggio di orientare il senso delle interazioni tra l’intelligenza umana e l’IA e quindi di connettere l’uomo, il soggetto e la storia.
Nelle moltiplicazioni presenti e future degli artefatti il «caring adult, ovvero il soggetto adulto con responsabilità di cura» (Mortari, 2015) sarà chiamato a operare per creare ambienti di apprendimento personalizzati, cuciti sui diversi stili di apprendimento e sui bisogni e sui desideri degli studenti, superando le limitazioni tradizionali dell’educazione e aprendo la strada a una didattica più inclusiva e attenta alla persona (Rosati e Sebastiani, 2021), per costruire quella la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e di come queste possano influenzare l’inclusione e la responsabilità educativa. La competenza tecnologica per essere tale sarà quindi accompagnata da una coscienza critica, in grado di valutare l’impatto etico, sociale ed economico dell’IA nel contesto didattico (Ranieri et al., 2024) e nel reale.
Va sottolineato che la ricerca presenta limiti, tra cui l’impiego di un questionario auto-progettato, che potrebbe sollevare dubbi sulla validità e affidabilità dello strumento di indagine. Infine, la ricerca evidenzia un gap nella identificazione di metodologie stabilizzate e dedicate all’integrazione dell’IA nei laboratori; poiché il campo è ancora in fase di sviluppo, sono necessari ulteriori studi e riflessioni che comprendano il curricolo e l’intero ambiente di apprendimento.
Per il futuro auspico che le ricerche possano intraprendere un percorso attento alla validazione strutturato dello strumento di rilevazione, ampliamento del campione e l’implementazione della varietà dei contesti, l’adozione di una visione longitudinale attenta a una analisi critica in profondità delle tematiche che oggi si presentano nella loro debolezza e vulnerabilità e l’ampliamento delle variabili contestuali proprie dell’IA e del laboratorio.
Bibliografia
Accoto C. (2019), Il mondo ex machina. Cinquanta brevi lezioni di filosofia dell’automazione, Milano, EGEA.
Adams A., Burton B., e Cathrin, C. (2022), Ethical frameworks for AI in education: A need for community engagement, «Journal of AI Ethics», vol. 18, n. 2, pp. 135-152.
Almasri F. (2024), Exploring the impact of Artificial Intelligence in teaching and learning of science: A systematic review of empirical research, «Res Sci Educ» vol. 54, pp. 977-997.
Anders G. (1992), L’uomo è antiquato, vol. 2. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, Torino, Bollati Boringhieri.
Annas J. (2011), Intelligent virtue, Oxford, Oxford University Press.
Anscombe G.E.M. (1958), Modern moral philosophy, «Philosophy», vol. 33 n. 124, pp. 1-19.
Aristotele (2009), Etica Nicomachea, Bari, Laterza.
Baker R. e Siemens G. (2014), Educational data mining and learning analytics. In K. Sawyer (a cura di), Cambridge Handbook of the Learning Sciences, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 253-274.
Bastani H., Bastani O., Sungu A., Ge H., Kabakcı Ö. e Mariman R. (2024), Generative AI can harm learning, Philadelphia, PA, The Wharton School Research Paper.
Bawden D. e Robinson L. (2016), Information and the gaining of understanding, «Journal of Information Science», vol. 42 n. 3, pp. 294-299.
Bonavolontà G. e Pagliara, S.M. (2024), Intelligenza artificiale ed elementi per la progettazione educativa riflessioni pedagogiche, «Mizar. Costellazione di pensieri», vol. gennaio-giugno 2024, n. 20, pp. 4-16.
Brookhart S. (2023), Assessment literacy in a better assessment future, «Chinese Journal of Applied Linguistics», vol. 46 n. 2, pp. 162-179.
Carr N. (2023), The shallows: What the Internet is doing to our brains, New York, NY, Norton & Company.
Chounta I.A. (2020), Collaborative learning and patterns of practice. In A. Tatnall (a cura di), Encyclopedia of education and information technologies, London, Springer, pp. 310-323.
Colombo F. (2020), Ecologia dei media. Manifesto per una comunicazione gentile, Milano, Vita e Pensiero.
Crispiani P. e Moliterni P. (2022), Intervista sulla didattica con Elio Damiano, Chiaravalle, AN, Editore Itard.
Crispiani P. (2019), Ippocrate pedagogico. Manuale professionale di Pedagogia speciale della Abilitazione e della Riabilitazione, Chiaravalle, AN, Editore Itard.
Crispiani P. (2004), Didattica cognitivista, Roma, Armando Editore.
De Pietro O. (2006), Strumenti innovativi di supporto alla formazione. Un agente intelligente: Tutorbot. In C. Piu (a cura di), Simulazione e competenze. Gli effetti della simulazione nella certificazione delle competenze e nella loro corretta gestione, Roma, Monolite, pp. 143-159.
Elliott A. (2021), La cultura dell’intelligenza artificiale. Vita quotidiana e rivoluzione digitale, Torino, Codice.
Eugeni R. (2021), Capitale algoritmico. Cinque dispositivi postmediali (più uno), Brescia, Scholè.
Floridi L. (2024), Filosofia dell’informazione, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Floridi L. e Cabitza F. (2021), Intelligenza artificiale. L’uso delle nuove macchine, Milano, Bompiani.
Gaspari P. (2021), Cura educativa, relazione d’aiuto e inclusione. Le categorie fondative della pedagogia speciale nelle professionalità educative, Roma, Anicia.
Gobbo M., Orian L. e Rivoltella C. (2024), Il laboratorio sperimentale e virtuale come ambiente di apprendimento. In E. Ghibaudi, E. Aquilini, G. Villani e M. Venturi (a cura di), I tanti volti della chimica. Percorsi innovativi per insegnarla e comprenderla, Bologna, CLUEB, pp. 155-179.
Heidegger M. (1999), Prolegomeni alla storia del concetto di tempo, Genova, Il Melangolo.
Innerarity D. (2022), Una teoria della democrazia complessa, Roma, Castelvecchi.
Krajcik J. e Shin N. (2023), Student conceptions, conceptual change, and learning progressions. In G.N. Lederman, D.L. Zeidler e J.S. Lederman, Handbook of research on science education. Volume III, London, Routledge, pp. 121-157.
Linn M.C., Donnelly-Hermosillo D. e Gerard L. (2023), Synergies between learning technologies and learning sciences: Promoting equitable secondary school teaching. In Handbook of research on science education. Volume III, London, Routledge, pp. 447-498.
MacIntyre A. (1981), After virtue: A study in moral theory, Notre Dame, IN, University of Notre Dame Press.
Malavasi P. (2022), PNRR e formazione. La via della transizione ecologica, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore.
Manzo G. (2023), L’intelligenza artificiale per la didattica speciale. Nuove forme di comunicazione, Roma, Anicia.
Morin E. (2022), Svegliamoci! La sfida della complessità, Sesto San Giovanni, MI, Mimesis.
Mortari L. (2022), La pratica dell’aver cura, Milano-Torino, Pearson.
Mortari L. (2015), Aver cura della vita della mente, Roma, Carocci.
Pagliara S.M., Bonavolontà G. e Mura A. (2024), Educating with Artificial Intelligence through an inclusive lens: New horizons for personalisation, «Journal of Inclusive Methodology and Technology in Learning and Teaching», vol. 4 n. 1.
Panciroli C. e Rivoltella P. (2023), Pedagogia algoritmica per una riflessione educativa sull’intelligenza artificiale, Milano, Morcelliana.
Panikkar R. (1990), La torre di Babele. Pace e pluralismo, Fiesole, FI, Edizioni Cultura della Pace.
Pellegrino E.D. e Thomasma D.C. (1993), The virtues in medical practice, Oxford, Oxford University Press.
Poornesh M. (2024), Through a teacher’s lens: Combating bias in AI-powered education for a just future, «The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas», vol. 97, n. 4, pp. 119-124.
Ranieri M., Cuomo S. e Biagini G. (2024), Scuola e intelligenza artificiale. Percorsi di alfabetizzazione critica, Roma, Carocci.
Rosati A. e Sebastiani R. (2021), Intelligenza artificiale e nuove prospettive di ricerca pedagogica, «QTimes-Journal of Education, Technology and Social Studies», vol. 13 n. 1, pp. 109-129.
Rossi P.G. (2009), Tecnologia e costruzione di mondi. Postcostruttivismo, linguaggi e ambienti di apprendimento, Roma, Armando Editore.
Sandel M.J. (2020), The tyranny of merit: What’s become of the common good?, New York, NY, Farrar, Straus and Giroux.
Shiva K., Etikani P., Bhaskar V.V.S.R., Nuguri S. e Dave A. (2024), Explainable AI for personalized learning: Improving student outcomes, «International Journal of Multidisciplinary Innovation and Research Methodology», vol. 3, n. 2, pp. 198-207.
Slote M. (2001), Morals from motives, Oxford, Oxford University Press.
Zhang K. e Aslan, A.B. (2021), AI technologies for education: Recent research & future directions, «Computers and Education: Artificial Intelligence», vol. 2.
Zimmerman B. (2022), Self-regulated learning and science education: Insights from laboratory studies, «Metacognition and Learning», vol. 17 n. 1, pp. 5-29.
Zurru A.L. (2022), In che senso è possibile innovare a scuola attraverso la Didattica Speciale?, «Education Sciences & Society», vol. 13 n. 2, pp. 172-185.
Sitografia
https://www.unesco.org/en/weeks/digital-learning (consultato il 28 ottobre 2025).
Vol. 2, Issue 2, October 2025