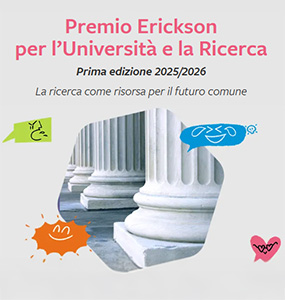Vol. 2, n. 2, ottobre 2025 — pp. 5-10
EDITORIALE
Le macchine sanno educare?
Nel pieno dell’Antropocene,1 quando lo sviluppo tecnologico sembra aver contaminato ogni aspetto della natura umana, domandarsi «le macchine sanno educare?» non sembra anticipare una realtà distopica ma, piuttosto, tracciare alcune linee del presente. L’interrogativo entra nel solco della più celebre domanda di Alan Turing «le macchine possono pensare?» con cui il matematico inglese anticipò il dubbio che avrebbe poi colto l’umanità in tempi più recenti rispetto al rapporto da assumere con le cosiddette macchine intelligenti, frutto dell’ingegno stesso dell’essere umano, ma talmente complesse da spaventare il suo stesso creatore. Gli sviluppi della modernità ci hanno condotto in una fase particolare del progresso in cui il dubbio ci sta sopraffacendo, in cui mettiamo in discussione quella stessa realtà che manipoliamo e costruiamo con le nostre mani. L’idea di umanità e del controllo sui nostri artefatti è messa in discussione: guardiamo con sospetto le macchine frutto del nostro ingegno poiché cominciamo a dubitare delle loro «intenzioni», quasi avessero avuto un salto di specie: che la loro intelligenza sia tale da permetterle di acquisire un pensiero proprio e autonomo, di una propria volontà, lontano dalle vere intenzioni del genere umano, distanti dallo scopo per cui sono state create? Siamo forse sull’orlo di un passaggio di consegne tra il creatore e le sue creature? La nostra umanità è in pericolo? In altre parole, siamo passati dal dubbio che ci dispiega Turing sulle capacità di pensiero delle macchine a uno ancora più profondo e inquietante su di una possibile autonomia di pensiero: che le macchine possano essere dotate di una coscienza? E se così dovesse essere, che rapporto vorranno intraprendere con gli esseri umani? Pensieri distopici che nel passato sembravano appartenere alla fervida immaginazione di autori di romanzi di fantascienza, ma che ora, invece, sono oggetto di speculazione in molti campi del sapere.
Del resto, gli appelli che arrivano da molti ambienti di intellettuali — ma anche da alcuni tecnici pentiti e spaventati dalle loro stesse creazioni — invitano a considerare di fermare lo sviluppo tecnologico, soprattutto sul piano dell’intelligenza artificiale generativa, così da prendersi un attimo in più di tempo per riflettere meglio, per capire le conseguenze dell’accelerazione tecnologica, per scrutare le nostre creazioni. Sul piano del dibattito oggi non c’è campo del sapere, né conversazione, né ambito che non interpelli, in maniera sempre più diretta e preponderante, il significativo cambiamento dei parametri stessi che ridefiniscono il rapporto tra l’uomo e le macchine intelligenti. Si è ormai delineato un piano di ragionamento in cui l’essenza stessa dell’umanità è posta al centro di numerose analisi e speculazioni. Il tutto mentre lo sviluppo tecnologico sembra non conoscere pause, lanciato in una corsa esponenziale in cui quotidianamente la simbiosi uomo-macchina amplia i suoi confini: non c’è espressione dell’umanità — il lavoro, gli affetti, la conoscenza, la ricerca, la medicina, ecc. — che oggi possa dirsi slegata dalla tecnologia: l’immersione è totale, con passaggi repentini da un modello di utilizzo all’altro. Da semplici strumenti con cui amplificare le capacità umane, si ha come l’impressione, forse il timore, che le macchine siano sul punto di diventare qualcos’altro, forse un’altra forma di esistenza destinata a contaminare per intero il genere umano.
Il mercato, molto attento a queste dinamiche, scommette su questi scenari. Molte aziende sono pronte a offrire al vasto pubblico robot dalle sembianze umanoidi pronti a entrare nelle nostre case, per aiutarci con le faccende domestiche e, forse, anche per sostenerci nell’accudimento dei nostri figli. Un salto di specie non indifferente nella composizione stessa dell’idea di famiglia allargata, in cui forse, ben presto, inseriremo a tutti gli effetti l’umanoide di famiglia, membro di diritto del nostro nucleo familiare, a cui dovremo anche riservare il giusto spazio nell’album di famiglia. Del resto, se è in grado di gestire le faccende domestiche, perché non potrebbe acquisire quelle capacità motorie fini essenziali per poter cambiare il pannolino di un infante? Azzardo: le conoscenze tecniche per poter svolgere questa mansione probabilmente sono già disponibili nel pacchetto di capacità degli umanoidi: quindi, ancora una volta, il dubbio riguarda l’utilizzo o meno di questa tecnologia. Fino a che punto possiamo delegare i nostri obblighi di genitori senza perdere la nostra umanità? Tema certamente controverso, che richiede una riflessione collettiva.
Ma torniamo alla domanda di apertura sulla capacità delle macchine di educare e proviamo ad abbozzare una risposta scrutando, nuovamente, la direzione che sta intraprendendo il mercato. Soprattutto proviamo a leggere i piani delle grandi aziende Big-Tech, che più che anticipare il futuro, sembrano costruirlo. Tali aziende pare non abbiano dubbi al riguardo. La tecnologia e, in modo particolare, l’intelligenza artificiale sono al centro di iniziative e sperimentazioni che promettono di rivoluzionare dalle fondamenta l’idea stessa di educazione e l’idea di un sistema educativo basato sulla relazione individuo-individuo. Un’educazione in cui al centro del processo educativo prendono sempre più spazio le macchine dotate di intelligenza artificiale. Gli esempi recenti di Google o OpenAI vedono lo sviluppo di programmi che promettono in un futuro sempre più prossimo di realizzare processi di apprendimento personalizzato grazie a tutor digitali che adattano i contenuti e gli insegnamenti alle esigenze dei singoli alunni. I primi effetti sembrano già dispiegarsi, non solo sul piano dello studio e dell’approfondimento individuale. Ad esempio, infatti, la sperimentazione dell’Alpha School2 di Austin, San Francisco, sembra aver fatto già un passo decisivo verso questo modello di insegnamento, con l’uso esteso di programmi e strumenti didattici basati sull’intelligenza artificiale che seguono gli alunni durante il loro percorso di studi, senza l’intervento degli insegnanti umani. Gli alunni interagiscono con strumenti dotati di intelligenza artificiale che sono completamente dedicati a loro, alle loro caratteristiche e peculiarità e che, dunque, sono in grado di mettere in campo percorsi didattici realmente personalizzati, con un insegnante che svolge i compiti di supervisionare e facilitare il processo. Ma questo è solo un esempio di un movimento molto più ampio ed esteso che sta interessando molti Paesi del mondo, soprattutto quelli in cui lo sviluppo tecnologico è in una fase di forte espansione. Ci eravamo da poco abituati all’idea di una classe ricca di strumenti tecnologici e digitali quali tablet, computer, touch-board, ecc. che già dobbiamo constatare che questa dotazione tecnologica rischia di essere obsoleta.
L’educazione sembra essere messa particolarmente sotto pressione da queste dinamiche, ponendo molti dubbi e contraddizioni rispetto alla postura da assumere. Emergono, in ordine sparso, le posizioni più disparate. A soffermarsi solo sul contesto della scuola convivono atteggiamenti contrastanti tra una palese insofferenza verso uno sviluppo tecnologico che sembra quasi svilire il ruolo educativo dell’insegnante e mettere in pericolo gli alunni, cui fanno da contraltare gruppi di entusiasti che vedono nella tecnologia l’opportunità di ridisegnare le prassi didattiche, gli stili d’insegnamento, gli approcci alla conoscenza e l’intera architettura del processo educativo.
Fuori da toni provocatori e eccessivamente drammatici, possiamo sostenere che la presenza della tecnologia sul piano educativo stia facendo confluire una certa vitalità negli approcci educativi e questo potrebbe determinare un salto di qualità e una possibile ricomposizione dell’idea stessa di educazione. L’essere umano nel mondo contemporaneo si interroga sulla natura stessa della propria umanità, sui propri confini, come è sempre avvenuto nelle epoche storiche precedenti. Un’idea nuova di uomo è sempre stata in grado di portare con sé una visione rinnovata della realtà. L’uomo è passato dalla convinzione di essere al centro dell’universo, padrone e signore di quanto esiste, a una posizione postumana in cui i propri diritti possono essere parificati, se non addirittura superati da quelli di altri esseri viventi, come quelli degli animali. Nella condizione postumana l’uomo perde la funzione di referente privilegiato della realtà stessa a cui appartiene, che egli stesso contribuisce a modellare con le sue azioni e con gli artefatti di cui si circonda. Noi siamo esseri in continuo divenire, non siamo mai definiti stabilmente, neanche nella nostra posizione rispetto alla realtà. Nella condizione moderna le vecchie dicotomie — natura/tecnologia, locale/globale, presente/passato, giusto/sbagliato, umano/non-umano, uomo/donna, ecc. — diventano più flebili, sono fluide e quindi richiedono un tipo diverso di educazione, non fosse altro per la necessità di aiutare le nuove generazioni a comprendere la fluidità delle società in cui crescono.
La tecnologia entra nel contesto educativo e lo fa in una fase storica in cui i confini digitali, fisici e biologici sono quanto mai sfumati. Ciò significa che sta cambiando il soggetto stesso dell’educazione, cioè l’individuo. Chi educa lo fa in favore di individui che sono già postumani, non nel senso che hanno perso la loro umanità, ma nella misura in cui sono portatori di nuove forme di socialità, di comunicazione, di relazione, che trascendono i confini della carnalità. La scienza ci rappresenta, a volte in maniera eccessivamente allarmistica, l’emergere di cambiamenti che stanno interessando la configurazione stessa del cervello umano, del suo funzionamento e che quindi portano gli individui a comprendere la realtà in maniera differente. Questo cambiamento dell’individuo e dell’umanità si origina dalla tecnologia, la cui forza dirompente è in grado di ridisegnare la civiltà nella sua interezza. Cosa che sta già avvenendo. Le macchine sono già tra noi, sono già nella nostra dimensione esistenziale. Stanno già influenzando i nostri comportamenti, i nostri valori, la nostra cultura, con mutamenti che sono continui e che avvengono a tutti i livelli. Di fatto, nel momento in cui ci stiamo chiedendo se le macchine sono in grado di educare, in realtà lo stanno già facendo, e anche in maniera piuttosto marcata. I robot umanoidi di cui presto disporremo in maniera diffusa entreranno a far parte di un contesto complesso e multiforme in cui gli individui sono educati attraverso una molteplicità di fattori che mescolano il fattore umano propriamente detto, il rapporto individuo-individuo, sul piano carnale, con le interazioni e le ibridazioni che avvengono con la tecnologia. Nessun individuo che vive nelle società tecnologicamente avanzate è puro, libero dalla tecnologia: in realtà, in maniera più o meno marcata, è già il frutto di un’ibridazione, una forma di homo sapiens digitale e tecnologico che educa e che a sua volta è educato da altri sapiens digitali.
Quindi la risposta alla domanda presuppone un passaggio di consapevolezza: le macchine stanno già contribuendo alla nostra educazione. E allora non ci resta che passare alla domanda successiva e chiederci: come vogliamo che le macchine ci educhino?
Simone Digennaro
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
-
1 L’Antropocene è un termine utilizzato per definire una nuova epoca geologica, caratterizzata dall’influenza dominante dell’essere umano sull’ambiente terrestre su scala globale.
-
2 Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’iniziativa https://alpha.school/ (consultato il 12/11/2025).