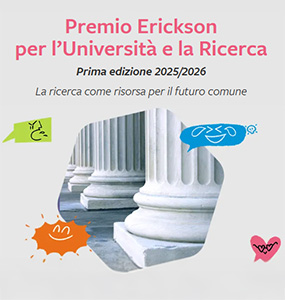Vol. 2, n. 1, aprile 2025
Oltre l’aula tradizionale: l’impatto delle piattaforme e-Learning sullo sviluppo delle competenze
Davide Richard Bramley1
Sommario
L’e-learning ha rivoluzionato il sistema educativo, offrendo nuove opportunità per l’insegnamento e l’apprendimento anche nelle scuole superiori di secondo grado. Queste piattaforme online facilitano l’accesso a risorse educative e promuovono l’acquisizione di competenze digitali, di auto-apprendimento e di collaborazione, cruciali nel contesto educativo e lavorativo contemporaneo, specialmente a causa dei molteplici mutamenti a cui la società ed il mercato del lavoro sono sottoposti repentinamente. Per approfondire la tematica è stata condotta una revisione della letteratura che si è interessata maggiormente della possibile integrazione di queste piattaforme all’interno degli istituti superiori di secondo grado, andando a cogliere quali aspetti, vantaggi e criticità potrebbero emergere promuovendo un utilizzo più consapevole di queste strumentazioni online all’interno dello specifico contesto scolastico proposto in riflessione. Tra gli elementi di maggior rilievo è opportuno citare in primo luogo la promozione dell’autonomia nello studio, aspetto centrale promosso dall’e-learning, in grado di favorire lo sviluppo di capacità di gestione del tempo e di autodisciplina. Oltre a questo, un utilizzo consapevole di questi strumenti digitali faciliterebbe la collaborazione tra studenti attraverso forum, chat e lavori di gruppo virtuali, promuovendo capacità di team working e di condivisione di idee e proposte, oltre a garantire un apprendimento maggiormente personalizzato e permettendo loro di approfondire tematiche o argomenti ritenuti di maggior interesse.
Parole chiave
E-learning, piattaforme online, formazione superiore, esperienza didattica onlife, post-Covid19.
Beyond the Traditional Classroom: The Impact of e-Learning Platforms on Skills Development
Davide Richard Bramley2
Abstract
E-learning has revolutionised the education system, offering new opportunities for teaching and learning in secondary schools. These online platforms facilitate access to educational resources and promote the acquisition of digital, self-learning and collaboration skills, which are crucial in today’s educational and working environment, especially due to the multiple changes to which society and the labour market are continuously subjected. To delve into this issue, a literature review was conducted that was more interested in the possible integration of these platforms within secondary schools, going to grasp which aspects, advantages and criticalities could emerge by promoting a greater use of these online tools within the specific school context proposed in reflection. Among the most important elements, it is worth mentioning in the first place the promotion of autonomy in study, a central aspect promoted by e-learning, fostering the development of time management skills and self-discipline. In addition to this, a conscious use of these digital tools would facilitate collaboration between students through forums, chats and virtual group work, developing team working skills and the sharing of ideas and proposals, as well as favouring more personalised learning and allowing them to delve more deeply into themes or topics considered to be of greater interest.
Keywords
E-learning, online platforms, higher education. onlife learning experience, post-Covid19.
Introduzione
Nonostante un incrementale inserimento e utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme e-learning e portali di archiviazione delle informazioni all’interno di scuole, istituti e università, la vera spinta che ha interessato la penisola italiana, nei confronti di un approccio maggiormente integrativo verso queste strumentazioni collegabili in rete, è avvenuta proprio grazie a un evento tragico e inaspettato, al di fuori del controllo dell’uomo (Sheth, 2007; Catino, 2014). Ci si riferisce, come del resto era intuibile far intendere, alla diffusione del virus denominato Covid-193, la cui portata di propagazione ha condotto i Paesi del mondo a rispondere a tale pandemia con un blocco delle attività lavorative, le quali sono state sostituite, laddove possibile, con la pratica del telelavoro e dello smart working (Di Domenica et al., 2020; Di Mascio, Angeletti e Natalini, 2021). L’Italia non è certo stata esclusa da tale scelta: malgrado la diffidenza e l’immaturità strutturale nei confronti di un’attività svolta da remoto (Di Mascio, Angeletti e Natalini, 2021), non sempre condotta con delle tecnologie e delle strumentazioni adatte alla situazione, senza contare la scarsa potenza della banda che caratterizza alcune regioni4, anche all’interno della penisola è stato imposto il proseguimento del proprio lavoro a distanza, direttamente dalla propria abitazione.
In tal senso, le scuole e le università non sono certo state escluse da tale imposizione, portando dirigenti scolastici e rettori accademici a fornire il massimo supporto sia al proprio corpo docenti che verso studenti e studentesse, affinché si garantisse una continuazione nei confronti del lavoro dei professori e delle professoresse coinvolti e verso la prosecuzione della formazione dei discenti (Uleanya e Naidoo, 2023). Per fare ciò sono state adoperate, in maniera decisamente più massiccia rispetto al passato, le cosiddette piattaforme e-learning (Di Domenica et al., 2020), la condivisione in rete di lezioni online in modalità sincrona o asincrona, portali e forum per la strutturazione di attività e compiti da poter svolgere direttamente da casa, evitando il rischio di contagio e mantenendo un’erogazione del servizio, per certi versi, abbastanza adeguata o quantomeno sufficientemente soddisfacente (Ceravolo et al., 2023). Per evitare fraintendimenti, una piattaforma e-learning è un ambiente digitale integrato progettato per l’erogazione, la gestione e la fruizione di percorsi formativi a distanza, in grado di facilitare l’interazione tra discenti stessi o con i docenti, attraverso strumenti multimediali avanzati, consentendo il monitoraggio sistematico delle attività didattiche, supportando la valutazione continua e personalizzata delle competenze acquisite (Di Domenica et al., 2020). Naturalmente, considerando una scarsa sperimentazione nei confronti di queste modalità telematiche, oltre che un compartimento tecnologico scolastico non sempre all’altezza delle esigenze della didattica e una connessione in rete non particolarmente ottimale5, l’Italia ha dovuto scontrarsi con una realtà tutt’altro che idilliaca e favorevole rispetto a tale evento extra ordinario e imprevisto (Scaratti, 2021; Triacca et al., 2021).
D’altronde, è proprio per merito di variazioni nell’ambiente esterno, di eventi inaspettati e inattesi, o di rischi e incertezze nel proseguimento dei propri processi che le organizzazioni complesse hanno la possibilità di mettersi e rimettersi in gioco (Audia et al., 2000), andando a sfatare quelle sicurezze sulle quali ci si era andati ad adagiare nel corso degli anni, senza sperimentare in modo adeguato ulteriori possibilità di manovra nelle proprie azioni (Catino, 2014). A questo punto della fase introduttiva, focalizzando l’attenzione nei confronti di un’erogazione di servizio in presenza, quali potrebbero risultare i vantaggi di un’implementazione stabile nell’utilizzo delle piattaforme e-learning all’interno delle scuole superiori di secondo grado? Attraverso quali pratiche scolastiche risulterebbe efficace adoperare l’utilizzo delle piattaforme digitali in maniera integrata nelle aule scolastiche?
Per poter riflettere in modo coerente ed efficace nei confronti del possibile impiego e mantenimento, seppur in parte e non a sostituzione, delle piattaforme di apprendimento e-learning nei confronti di un pubblico di discenti sufficientemente maturo, appartenenti alle scuole superiori di secondo grado, si propone come contributo una revisione di quella letteratura, nazionale e internazionale, che si è occupata di comprendere quali possano essere i punti di forza e le criticità di questi forum e queste tecnologie collegate in rete (Azmi et al., 2018; Pham et al., 2019; Dhawan, 2020; Saragih et al., 2021). In particolare, ci si concentrerà sulla promozione di un maggiore sviluppo di quelle competenze e capacità sempre più richieste sia dal mercato del lavoro che dagli organi governativi nazionali ed europei (Magni, 2023).
La scelta di focalizzare l’attenzione su questi istituti è dettata sia dalla già citata maturazione e maggior consapevolezza dei potenziali utilizzatori, sia per avvicinare questi studenti al possibile sviluppo di competenze necessarie, ad oggi, all’interno del mercato del lavoro, garantendo una formazione che abbracci non solo i piani di studio e i curricula proposti internamente nelle scuole, bensì che intercetti anche le esigenze e le necessità dei datori di lavoro e delle imprese.
Metodologia
Il metodo che è stato utilizzato per condurre il seguente contributo è una revisione della letteratura, sia nazionale che internazionale, che si è interessata a partire dal 2019 (ultimi cinque anni considerati), dell’utilizzo e delle potenzialità delle piattaforme di e-learning all’interno delle scuole superiori di secondo grado. Lo studio, il cui scopo sarà quello di riflettere sulle potenzialità e le opportunità offerte da queste tecnologie, è stato svolto prendendo in considerazione manuali e contributi sia interni alla penisola, grazie ai quali si è andati a proporre un quadro di riferimento sulla scarsità di sperimentazione, sui limiti del Paese e sull’opportunità offerta da queste strumentazioni, sia provenienti da realtà estere, affinché si evincessero alcuni dei vantaggi provenienti dalle indagini condotte da nazioni esterne, interfacciando un dialogo e un confronto con ulteriori prodotti di ricerca.
Oltre al primo criterio di selezione temporale, riferito al considerare esclusivamente i contributi pubblicati negli ultimi cinque anni, post pandemia, gli studi e le indagini scelte per portare la tematica in riflessione sono stati preferiti anche in base a: pertinenza e attinenza con l’argomento trattato; presenza delle parole chiave utilizzate per la ricerca («e-learning»; «post pandemia»; «piattaforme online»; «competenze»; «e-learning e sviluppo delle competenze»; «scuola superiore di secondo grado»; e «onlife learning»); reperibilità e accessibilità della fonte (Creswell, 2012). I motori di ricerca che sono stati adoperati per la lettura e la selezione degli articoli sono stati: ERIC, Scopus e Google Scholar. La scelta di fruire di questi tre archivi digitali è scaturita per i vantaggi e le potenzialità degli stessi (Falagas et al., 2008; Mongeon e Paul-Hus, 2018): ERIC ha offerto una preziosa e ricca base di informazione relativa alle scienze dell’educazione, mentre Scopus e Google Scholar hanno ampliato la letteratura di riferimento, attraverso un ricco archivio di articoli e fonti accademiche.
Nonostante una focalizzazione nei confronti dei contributi pubblicati negli ultimi cinque anni, all’interno di questa riflessione sono stati sottoposti a revisione anche quegli articoli e manuali meno recenti ma in grado di fornire alcune informazioni chiave e le basi teoriche per approfondire il tema proposto.
Stando ai criteri citati, sono emersi 32 contributi prettamente incentrati sul tema proposto,6 grazie ai quali è stato possibile strutturare sia un quadro teorico chiaro e puntuale sulle potenzialità di queste piattaforme, proponendo un contributo in grado di offrire una riflessione che racchiuda gran parte degli studi recenti sulla questione e-learning nelle scuole e sul relativo sviluppo delle competenze indispensabili, ad oggi, per sapersi muovere nel mercato del lavoro e nella società contemporanea. Le fasi della literature review che hanno portato alla selezione di questi articoli e manuali sono state le seguenti (Creswell, 2014):
- definizione dell’obiettivo e delle motivazioni di interessamento al tema scelto, giustificando le ragioni per le quali sarebbe opportuno approfondire la tematica;
- pianificazione della revisione attraverso la selezione delle parole chiave e dei motori di ricerca (ERIC, Google Scholar e Scopus);
- strutturazione delle fonti emerse e dei relativi collegamenti tra autori e autrici;
- analisi e sintesi delle informazioni emerse dalla letteratura e dai dati con annesse riflessioni critiche;
- scrittura della revisione.
Attraverso le seguenti fasi è stato possibile comporre un contributo in grado di intercettare non solo i possibili punti a favore o di maggiore criticità di una potenziale integrazione permanente dell’utilizzo di metodologie e-learning nelle scuole superiori di secondo grado, bensì anche di individuare eventuali riflessioni e dinamiche che si possono inserire coerentemente all’interno del dibattito pedagogico sempre più attuale.
Come l’e-learning si appresta a divenire una risorsa preziosa per la formazione superiore
Il valore della presenza all’interno di scuole e università è un tema che ha interessato parecchio la letteratura pedagogica nazionale (Bertagna, 2014; Potestio, 2020; Magni, 2023): se da un lato il desiderio di proporre innovazione e sperimentazione didattica deve mantenersi saldo in questi istituti, dall’altro lato non bisogna privare l’esperienza educativa dei discenti da quell’insieme di interazioni e relazioni che appaiono estremamente importanti durante il proprio percorso formativo (Mari, 2019). Ciononostante, il fenomeno pandemico ha messo in moto una serie di iniziative, indagini e ricerche che ha potuto mostrare quali siano i punti di forza di un corretto utilizzo delle piattaforme e-learning (Uleanya e Naidoo, 2023; Bramley, 2024).
Motivare un interessamento nei confronti di queste risorse digitali non è sicuramente difficoltoso considerando lo scenario attuale della penisola. Infatti, tra le ragioni che potrebbero spingere a una raccomandazione maggiore nell’utilizzo di questi strumenti nelle scuole superiori vi sono:
- Un potenziale incremento degli investimenti nei confronti di strumentazioni digitali e nell’acquisto di licenze per specifici programmi di apprendimento all’interno delle scuole, offrendo percorsi e risorse più versatili e flessibili;
- Una risposta più rapida ed efficiente verso eventi imprevisti e inattesi (Catino, 2014; Paniagua e Istance, 2018), come una momentanea sostituzione del servizio in presenza a favore di quello a distanza (Manca e Delfino, 2021);
- Un adattamento mirato sulle esigenze di una società digitale (Pellizzer e De Rossi, 2022), i cui cambiamenti risultano sempre più repentini e rapidi all’interno dello scenario contemporaneo (Augé, 2018; Laurillard, 2024);
- L’aumento di skills e competenze tecniche relative all’uso di strumentazioni digitali e tecnologie collegate in rete (Roverselli e Paolone, 2013; Amicucci, 2019; Bramley, 2024), grazie alle quali sarà possibile agevolare l’inserimento di studenti e studentesse nel mercato del lavoro, proprio per merito di una formazione che si inserisca non solo nell’impartizione di conoscenze nozionistiche, bensì anche nella strutturazione di un percorso che integri l’utilizzo delle nuove risorse digitali (Moore e Piety, 2022).
Partendo da questi presupposti a supporto di un interessamento centrato verso la tematica presentata, verranno ora proposti quegli elementi che hanno permesso, ad oggi, di ponderare positivamente nei confronti di un maggiore inserimento di queste piattaforme digitali all’interno delle scuole, con particolare interesse verso quelle superiori di secondo grado.7
L’elemento cardine da considerare è sicuramente lo sviluppo delle cosiddette competenze,8 fattore emerso con grande rilievo all’interno della Comunità Europea nel 2006, oltre che dai contributi che verranno proposti. Le competenze chiave individuate dalle Raccomandazioni vanno a indicare la necessità e il bisogno di collegare le attività formative scolastiche con gli apprendimenti successivi, con le esperienze esterne alla scuola, con il mercato del lavoro e delle professioni, con un progetto di vita personale e professionale flessibile, adattabile e aperto a qualsivoglia imprevisto (Roverselli e Paolone, 2013; Amicucci, 2019). Scaturiscono dalla constatazione che la scuola stia trasmettendo forme di conoscenza che non riescono a intercettare le richieste dei datori di lavoro, i quali lamentano una formazione spesso distaccata dalle esigenze pratiche ed esperienziali delle organizzazioni complesse e delle imprese (ISTAT, 2019; ISTAT, 2023; Massagli, 2023).
Sotto questa prospettiva, un utilizzo costante, seppur in relativa parte, delle piattaforme e-learning all’interno delle scuole superiori può favorire lo sviluppo di competenze non solo legate alla sfera digitale, come si potrebbe pensare, attraverso la familiarizzazione con software e applicazioni essenziali nel mondo moderno (Moore e Piety, 2022; Weller, 2022), andando a migliorare anche le capacità di navigazione in rete. Oltre a questo, emergerebbero le capacità di pensiero critico e la valutazione della credibilità delle fonti, portando i discenti ad avere una maggiore consapevolezza nella ricerca di testi e articoli e nella sintesi delle informazioni attraverso la loro raccolta nelle differenti risorse in rete (Cottini, 2016; Sgambelluri, 2023). Sperimentare la ricerca dei dati online e interfacciarsi con differenti motori di ricerca, andando ad individuare e differenziare quelli più o meno efficienti e utili, risulta essere valore aggiunto al proprio percorso formativo, sia che questo si esaurisca formalmente con l’ottenimento di un diploma, sia che prosegua con un percorso accademico o simili. Adottare un approccio metodologico e didattico misto significherebbe, nel concreto, far emergere la necessità di usufruire di tali strumentazioni: per esempio, si potrebbero organizzare delle attività di gruppo da svolgere interamente online, offrire agli studenti piattaforme di dibattito costruttivo o forum digitali verso i quali ricorrere al momento di un eventuale chiarimento.
In questa direzione, un altro aspetto da considerare riguarda la promozione delle capacità comunicative, interattive e di team work. L’e-learning contribuisce a favorire la comunicazione tra pari e la collaborazione grazie agli strumenti per i lavori di gruppo online, aiutando gli studenti a sviluppare ulteriori competenze per il lavoro di squadra e la cooperazione (Bocci, Guerini e Marsano, 2017; Di Tore et al., 2019), offrendo anche dei feedback immediati. Queste piattaforme e strumentazioni digitali vanno a promuovere un’autonomia e una motivazione maggiori, insegnando agli studenti a gestire il proprio tempo e le proprie risorse senza una eccessiva o continua supervisione da parte degli insegnanti, divenendo più responsabili del proprio percorso educativo (Balzano, 2022).
Questa maggiore flessibilità d’azione e di scelta del proprio percorso formativo (ed esplorativo), richiesta non solo nelle scuole superiori ma anche nelle università nazionali «tradizionali» (Magni, 2023), garantisce agli studenti l’opportunità di affacciarsi a differenti risorse integrative e approfondimenti maggiori verso quelle materie che meglio si incasellano con i propri interessi, affermando ulteriormente la propria autonomia d’azione: infatti, niente esclude l’esplorazione di fonti, corsi e materiali provenienti anche da esperti esteri, professori e ricercatrici da tutto il mondo. Questo elemento aiuterebbe i neodiplomati ad avere una cognizione maggiore verso quale strada intraprendere una volta concluso il proprio percorso nei licei e negli istituti tecnici, sia che questi desiderino proseguire nelle università o all’interno del mercato del lavoro.
Una delle sfide principali è rappresentata dalla formazione dei docenti, che necessitano di sviluppare competenze specifiche sia dal punto di vista tecnico che pedagogico per poter integrare in modo efficace le piattaforme digitali nel loro approccio didattico (Farina, 2022; Marangi et al., 2022). Molti insegnanti devono modificare le proprie metodologie per adattarle all’ambiente virtuale, cosa che richiede una preparazione approfondita sui nuovi strumenti e sulle tecniche per stimolare l’apprendimento attivo online. Per superare queste sfide, è fondamentale investire in programmi di formazione continua per i docenti, in cui possano apprendere non solo l’uso di strumenti specifici ma anche metodologie per facilitare un insegnamento coinvolgente. Un supporto tecnico costante rappresenta, inoltre, un elemento essenziale per risolvere eventuali problemi tecnici che i docenti possono incontrare, fornendo loro un senso di sicurezza, soprattutto nelle fasi iniziali di implementazione.
Naturalmente, per permettere una piena ed efficiente integrazione dell’utilizzo di queste strumentazioni digitali all’interno delle scuole superiori, il bisogno impellente di un aggiornamento e finanziamento nei confronti di apparecchiature e piattaforme adeguate risulterà essere essenziale: dal momento in cui ci si accorge del valore formativo di queste piattaforme online, la possibilità di intravedere un quantitativo di risorse sia in termini di denaro che di tempo potrebbe risultare più attualistica. Offrire degli inserimenti di lezione proposti in modalità e-learning, dei laboratori didattici da svolgere online e delle ricerche da sviluppare in autonomia o in gruppo, potrebbe divenire quella chiave di lettura in grado di intercettare un aggiornamento maggiore della proposta scolastica, oltre che una risorsa estremamente utile affinché gli studenti riescano a sviluppare quelle competenze, digitali e trasversali, sempre più richieste all’interno della mutevole società contemporanea (Augé, 2018) e dalle imprese.
Conclusioni
Le piattaforme e-learning, divenute protagoniste all’interno della crisi pandemica, sono emerse con maggior prepotenza in concomitanza con un periodo emergenziale e incerto. Per questa ragione, la messa in moto raffazzonata e in termini di scadenza di queste strumentazioni online non ha permesso di riflettere a sufficienza su una potenziale integrazione delle stesse all’interno di una quotidianità didattica nella penisola italiana.
Considerando come le università avevano già offerto servizi simili o totalmente spostati online9 e come l’esperienza di Didattica a Distanza (DaD) delle scuole primarie non sia stata granché soddisfacente (Ranieri, 2020; Cingarotto, Mosa e Panzavolta, 2021), il pensiero di come promuovere tali strumenti si può collocare all’interno del campo dell’istruzione superiore di secondo grado, dove la maturità dei discenti è tale da offrire un’integrazione stabile con queste applicazioni in rete.
I vantaggi emersi durante la revisione dei contributi individuati hanno mostrato una buona correlazione tra l’utilizzo di queste piattaforme digitali e lo sviluppo di competenze utili a studenti e studentesse: la possibilità di svolgere delle ricerche maggiormente mirate e consapevoli va a collegarsi con un’esperienza di cooperazione maggiore. Ciò non deve certo esaurirsi a conversazioni non mirate alla risoluzione di casi, problemi e attività ponderate e organizzate dal corpo docenti, come può avvenire senza una metodologia pensata e gestita in modo efficace; al contrario, la necessità di allargare le modalità di erogazione del servizio, gli strumenti e le apparecchiature per la formazione dei discenti va a intendersi come un elemento di progresso e innovazione (Catino, 2014).
Come se non bastasse, la richiesta di maggior «esperienza» e «praticità» delle imprese nazionali si colloca positivamente con la possibilità di promuovere una formazione in grado di intercettare i bisogni di una società sempre più digitale e connessa (Bettinelli, 2022), attraverso l’impiego integrativo di queste tecnologie e-learning, le quali offrono il vantaggio aggiuntivo di manifestare al meglio i propri tempi e le proprie passioni, indagando autonomamente su fonti, risorse e materiali e avendo maggior cognizione di quali siano gli argomenti e le materie che realmente intercettano i propri interessi.
Per concludere, occorre precisare che la riflessione proposta da questo contributo ha lo scopo di offrire un posizionamento a favore dell’integrazione parziale di queste piattaforme, negando, tuttavia, una piena sostituzione; in tal senso, il valore della presenza in aula rimane indiscutibile, in grado di far interagire e relazionare tutte le persone coinvolte, partendo dai compagni di classe fino ad arrivare al corpo docenti e agli autisti degli autobus. Nonostante questo, le strumentazioni online possiedono la peculiarità di intercettare il bisogno di promuovere alcune delle competenze richieste dalla società e dal mercato del lavoro, di offrire uno spazio, seppur virtuale, dove poter esprimersi, collaborare, esplorare risorse e interessi, gestire il proprio tempo e di affacciarsi a una didattica proiettata al futuro.
Bibliografia
Amicucci F. (2019), Le competenze trasversali, «Prometeo», vol. 37, n. 148.
Audia P.G., Locke E.A. e Smith K.G. (2000), The paradox of success: An archival and a laboratory study of strategic persistence following radical environmental change, «Academy of Management Journal», vol. 43, n. 5, pp. 837-853.
Augé M. (2018), Non luoghi, Milano, Elèuthera.
Balzano G. (2022), Il ruolo del digitale a scuola dopo la pandemia. Verso una scuola 4.0, «Studi sulla Formazione/Open Journal of Education», vol. 25, n. 2, pp. 87-92.
Bertagna G. (2014), Lavoro e formazione dei giovani, Brescia, La Scuola.
Bettinelli E. (2022), Società digitale/società della conoscenza. Per una ulteriore analisi, tra progresso e crisi, «Studi di sociologia», vol. 60, n. 3, pp. 493-508.
Bocci F., Guerini I. e Marsano M. (2017), Le App come strumenti per l’apprendimento della letto-scrittura. Una rassegna, «Form@re», vol. 17, n. 2, pp. 225-237.
Bramley D.R. (2024), Tra lezioni in presenza e piattaforme E-learning. Riflettere sul ruolo delle tecnologie nelle università italiane, «QTimes – webmagazine», vol. 16, n. 3, pp. 942-953.
Ceravolo F.A., Ramella F. e Rostan M. (2023), La digitalizzazione della didattica nelle università italiane durante la prima fase di emergenza Covid-19. Una prima esperienza di transizione digitale? Problemi e prospettive, «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», n. 25, n. 1, pp. 181-199.
Cinganotto L., Mosa E. e Panzavolta S. (2021), Quando la webcam è accesa e la testa spenta. Strategie per una didattica attiva in DAD e DDI, «IUL RESEARCH», vol. 2, n. 3, pp. 251-266.
Cottini L. (2016), L’autodeterminazione nelle persone con disabilità. Percorsi educativi per svilupparla, Trento, Erickson.
Creswell J.W. (2012), Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research, 4ª ed., [s.l.], Pearson.
Creswell J.W. (2014), Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, London, SAGE Publications.
Dhawan S. (2020), Online Learning. A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis, «Journal of Educational Technology Systems», vol. 49, n. 1, pp. 5-22.
Di Domenica N., Redivo A., Rozzoni E. e Crippa G. (2020), Digital Marketing. Data, analytics, tecnologie e canali digitali, [s.l.], Pearson.
Di Mascio F., Angeletti S. e Natalini A. (2021), Smart working within Italian central government during the covid-19 pandemic, «Rivista Italiana di Politiche Pubbliche», pp. 95-125.
Di Tore S., Todino M.D. e Sibilio M. (2019), L’apprendimento in ambienti di mixed reality. In Rossi P.G., Garavaglia A. e Petti L. (a cura di), Le società per la società. Ricerca, scenari, emergenze sull’educazione al tempo del digitale, Atti del Convegno Internazionale SIRD, Roma 26-27 settembre 2019 – III tomo, Lecce, Pensa MultiMedia, pp. 151-156.
Falagas M.E., Pitsouni E.I., Malietzis G.A. e Pappas G. (2008), Comparison of PubMed, Scopus, web of science, and Google scholar. Strengths and weaknesses, «The FASEB Journal», vol. 22, n. 2, pp. 338-342.
Farina T. (2022), Scuola italiana e digitalizzazione. Temi e problemi educativi, «Pedagogia Più Didattica», vol. 8, pp. 147-158.
Ferrari S. e Pasta S. (2023), Information Literacy. L’istanza educativa centrale per la declinazione delle competenze digitali, «Annali online della Didattica e della Formazione Docente», vol. 15, n. 26, pp. 170-192.
Isidori M.V., Evangelista C., Giammario R. e Muselli M. (2023), Indagine sull’esperienza didattica degli insegnanti in servizio presso le scuole della Regione Abruzzo (AS 2021/22 in emergenza Covid 19). Bisogni formativi e nuovi scenari, «Research Trends in Humanities Education & Philosophy», vol. 5, n. 10.
ISTAT (2019), Ministero del lavoro, Inps, Inail, Anpal, Il mercato del lavoro 2018. Verso una lettura integrata, Roma.
ISTAT (2023), Rapporto annuale 2023. La situazione del Paese. Capitolo 2. Cambiamenti nel mercato del lavoro e investimenti in capitale umano, Roma.
Jamal S. (2021), The Impact of Online Learning on Students. Evidence from Lebanese French University-Erbil, «International Journal of Research in Business and Social Science», vol. 10, n. 3, pp. 522-532.
Laurillard D. (2024), The role of governance in opening up digital innovation in teaching and learning. In The Routledge Handbook of Global and Digital Governance Crossroads. Stakeholder Engagement and Democratization, London, Routledge.
Lovelock C. e Wirtz J. (2007), Services Marketing. People, Technology, Strategy, 6ª ed., [s.l.], Pearson.
Magni F. (2023), L’università e il rilancio della formazione terziaria. Nuovi paradigmi culturali, Roma, Studium Edizioni.
Maino F. e Razetti F. (2020), Iniziative di welfare aziendale, smart working e responsabilità sociale. Piccole e grandi organizzazioni di fronte alle sfide del COVID-19, «Quaderni di ricerca sull’artigianato», vol. 8, n. 2, pp. 215-247.
Manca S. e Delfino M. (2021), Adapting educational practices in emergency remote education. Continuity and change from a student perspective, «British Journal of Educational Technology», vol. 52, n. 4.
Marangi M., Pasta S. e Rivoltella P.C. (2022), Povertà educativa digitale. Costrutto, strumenti per rilevarla, risultati, «Q-Times Webmagazine», vol. 14, n. 4, pp. 236-251.
Mari G. (2019), La relazione educativa, Brescia, Scholé.
Massagli E. (2023), La didattica esperienziale. Apprendistato e impresa didattica nei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, Roma, Studium Edizioni.
Mongeon P. e Paul-Hus A. (2016), The journal coverage of Web of Science and Scopus. A comparative analysis, «Scientometrics», vol. 106, pp. 213-228.
Moore S.L. e Piety P.J. (2022), Online learning ecosystems. Comprehensive planning and support for distance learners, «Distance Education», vol. 43, n. 2, pp. 179-203.
Nadeak B. (2020), The Effectiveness of Distance Learning Using Social Media during the Pandemic Period of COVID-19. A Case in Universitas Kristen Indonesia, «International Journal of Advanced Science and Technology», vol. 29, n. 7.
Palermo R. (2024), Preventing and Countering Online Hate Speech. Un dispositivo didattico ibrido di Human Rights Education, Milano, FrancoAngeli.
Paniagua A. e Istance D. (2018), Teachers as Designers of Learning Environments. The Importance of Innovative Pedagogies, Paris, OECD Publishing.
Pellizzer L. e De Rossi M. (2022), Apprendere a scrivere in una società digitalizzata. Uno studio di caso in una one tablet per child school, «Graphos. Rivista internazionale di pedagogia e didattica della scrittura», n. 2, pp. 81-95.
Pham L., Limbu Y., Bui T., Nguyen T. e Pham T. (2019), Does E-learning Service Quality Influence E-learning Student Satisfaction and Loyalty? Evidence from Vietnam, «International Journal of Educational Technology in Higher Education», vol. 16, pp. 1-26.
Potestio A. (2020), Alternanza formativa. Radici storiche e attualità di un principio pedagogico, Roma, Studium Edizioni.
Ranieri M. (2020), La Scuola dopo la DaD. Riflessioni intorno alle sfide del digitale in educazione, «Studi sulla Formazione/Open Journal of Education», vol. 23, n. 2, pp. 69-76.
Roverselli C. e Paolone A.R. (2013), Competenze trasversali. Valutazione e valorizzazione delle esperienze di studio all’estero, Roma, Fondazione Intercultura.
Scaratti G. (a cura di) (2021), La ricerca qualitativa nelle organizzazioni, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Sheth J.N. (2007), The Self-Destructive Habits of Good Companies. And how to Break Them, Philadelphia, Wharton School/Pearson Education.
Sgambelluri R. (2023), Competenze digitali e processi inclusivi per lo sviluppo di intelligenze collettive nella Scuola 4.0, «Pedagogia Oggi», vol. 21, n. 2, pp. 107-116.
Tossy T. e Brown I. (2017), Collaborating Partnerships. A Project-Based Legitimizing Strategy Amongst East African E-learning Providers. In Information Technology Integration for Socio-Economic Development, pp. 32-51.
Triacca S., Pelizzari F., Scott Flavia M. e Rivoltella P.C. (2021), Planning the «New Normality» to Address the Pandemic in Higher Education. Blended Scenarios at the Catholic University of the Sacred Heart. In Casalino G., Cimitile M., Ducange P., Padilla Zea N., Pecori R., Picerno P. e Raviolo P. (a cura di), Higher Education Learning Methodologies and Technologies Online, Berlin, Springer.
Uleanya M.O. e Naidoo G.M. (2023), The use of e-learning during COVID-19 pandemic era, «Athens Journal of Education», vol. 10, n. 3, pp. 539-558.
Weller M. (2022), The rise and development of digital education. In Zawacki-Richter O. e Jung I.S. (a cura di), Handbook of Open, Distance and Digital Education, Singapore, Springer Nature, pp. 1-17.
Zuddas P. (2020), Covid-19 e digital divide. Tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell’emergenza sanitaria, «Osservatorio AIC», n. 2, pp. 285 ss.
-
1 Università degli Studi di Siena.
-
2 Università degli Studi di Siena.
-
3 Si fa riferimento alla propagazione del virus denominato COVID-19 e diffusosi a partire dalla fine del 2019 in tutto il mondo, portando le istituzioni e le organizzazioni a prendere provvedimenti di natura politica, economica e sociale.
-
4 I dati di Eurostat sono allineati con quelli del Desi, l’indice Ue che fotografa il livello di digitalizzazione degli Stati membri. Nella classifica riguardante la connettività, seppure l’Italia sia salita dal 23° al 7° posto in un anno, gli indicatori sono inferiori alla media dell’Ue, soprattutto per quanto riguarda l’adozione complessiva della banda larga fissa (66% in Italia, contro il 78% nell’Ue; https://www.corrierecomunicazioni.it/).
-
5 Per maggiori informazioni consultare www.corrierecomunicazioni.it (consultato il 19/02/2025).
-
6 Ricordando che, oltre a questi contributi, sono stati utilizzati ulteriori lavori, studi e riflessioni meno recenti, necessari, tuttavia, a predisporre alcuni dei concetti chiave e delle basi teoriche, senza contare i manuali di metodologia della ricerca (Creswell 2012 e 2014) o i report ISTAT (2019 e 2023) aggiunti.
-
7 Come espresso in precedenza, la scelta di interessarsi specificatamente nei confronti delle scuole superiori di secondo grado è giustificata da tre ragioni: prima fra tutte, l’età sufficientemente matura dei discenti, i quali hanno già esperienze nella navigazione in rete, la quale potrebbe essere bene indirizzata verso una consapevolezza critica maggiore; in secondo luogo, la necessità di offrire percorsi formativi maggiormente flessibili, intercettando interessi e preferenze di approfondimenti da parte di studenti e studentesse, portando queste persone a una scelta più ponderata per il proprio futuro; infine, l’esigenza di garantire una serie di competenze chiave per tutti quei futuri lavoratori in procinto di inserirsi con più facilità nelle organizzazioni.
-
8 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» 30.12.2006, L. 394/10-18.
-
9 Basti pensare alle università telematiche, le quali risultano avere un numero di iscritti sempre maggiore (Magni, 2023).
Vol. 2, Issue 1, April 2025