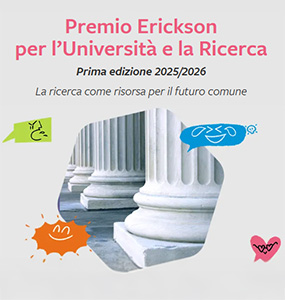Vol. 2, n. 1, aprile 2025 — pp. 5-10
EDITORIALE
Possiamo finalmente dirci postumani? La domanda potrebbe lasciare intendere un’attesa di un passaggio che, invece, in molti guardano con preoccupazione, perfino con una punta di rassegnazione, per un destino temuto ma comunque ineludibile.
Proviamo a cambiare prospettiva, e a dirci che essere postumani può significare la conclusione di quel complesso processo di sviluppo del genere umano, che ha compiuto tutti i gradi del passaggio evolutivo dall’uomo preistorico all’uomo postmoderno. La visione postumanista ci sollecita a una rivisitazione degli schemi interpretativi della realtà che sono tutti tipici dell’ideale umanistico, per metterli in relazione con i progressi dell’informatica, delle biotecnologie e delle neuroscienze che insieme stanno cambiando non solo il modo in cui oggi interpretiamo che cosa voglia dire essere umano ma anche la natura stessa dell’umanità. Il progresso scientifico ha forse superato il punto verso cui, in maniera più o meno conscia, si era proiettato: raggiungere nuove dimensioni oltre i confini naturali dell’uomo, andare oltre l’uomo, diventare, appunto postumano. Ma non nella misura, e qui s’inserisce una diversa chiave di lettura, di un annichilimento del genere umano ma quanto piuttosto di una sua evoluzione con la comparsa di individui con nuove peculiarità e capacità oltre che con nuove modalità di intendere il ruolo stesso del genere umano, dentro quel complesso esistenziale che chiamiamo realtà.
Se riavvolgiamo il nastro della storia dell’uomo possiamo riassumerla in un grande sforzo collettivo in cui gli sforzi compiuti e le conquiste ottenute hanno avuto un grande comune denominatore: l’affrancamento dai propri limiti biologici e naturali. Ancora una volta, se si legge tale affermazione attraverso l’osservazione del corpo, si nota come essa possa avere una serie di argomenti a suo sostegno. L’uomo è passato da essere un corpo, a vivere dentro la sua corporeità — come del resto fanno, per nostra conoscenza, tutte le creature animali dotate di un corpo — ad avere un corpo, a poterlo curare, adornare, modificare, perfino analizzare con gli strumenti culturali che sono stati sviluppati nel corso delle epoche storiche. A conclusione di questo percorso, oggi, l’uomo è in grado di definirsi come un soggetto incarnato, che è un corpo, che possiede un corpo, che può manipolare il corpo, e dunque sé stesso, secondo un disegno intelligente.
Nel corso della storia, il disegno intelligente — l’idea cioè che ci fosse un progettista, un deus, dietro tutti i processi evolutivi che hanno portato la realtà a essere quella che noi oggi osserviamo — non è stata mai un’opzione. Fino al momento in cui l’uomo non si è più limitato a osservare la realtà, ma ha cominciato a intervenire su di essa, dapprima per rispondere a dei bisogni immediati — il cibo, l’abitazione, la sicurezza personale e della propria comunità, ad esempio — ma poi, ben presto, per ampliare la portata della propria corsa evolutiva. È cominciata una lunga sperimentazione sulla realtà, governata dall’uomo, il quale ha cominciato a mescolare le leggi della natura con le leggi e i principi culturali che l’uomo stesso ha definito. Non è più possibile spiegare l’evoluzione di qualsiasi specie vivente su questo Pianeta senza metterla in relazione con le scelte e le influenze che il genere umano ha determinato su di essa. Ad uno sguardo purista questo argomento è la prova dell’eccessivo impatto dell’uomo sul Pianeta, della sua soverchiante presenza, che finisce per soffocare il libero gioco evolutivo e le leggi biologiche che per miliardi di anni hanno governato i rapporti tra le specie viventi. Con una lettura meno propensa alla condanna si può, invece, percepire e ricostruire il cammino di una specie che è stata in grado di andare oltre l’ordine biologico e di sviluppare capacità complesse di elaborazione e di interpretazione della realtà, tanto da poter giungere a essere in grado di poter progettare nuove realtà e di poterle realizzare.
I progressi della comprensione di come funzionano gli organismi hanno aperto possibilità inimmaginabili, così come sta facendo la sempre più acuta e approfondita conoscenza delle leggi dell’universo. Lo sviluppo tecnologico prosegue in modalità esponenziale arricchendo di anno in anno le possibilità applicative in tutti i campi del sapere. L’ingegneria genetica, da sola, ha completamente rivoluzionato il rapporto dell’uomo con la malattia, con la cura, finanche con la morte stessa. Stiamo rivedendo i concetti alla base della filosofia, dell’etica e della morale, poiché sono completamente cambiati i punti di riferimento su cui debbono poggiarsi le riflessioni in questi campi. A volte, in questo vortice di cambiamento, prevale un sentimento di allarmismo alimentato dalla paura di un eccesso di opportunità e di velocità, come se i cambiamenti che noi stessi avviamo oltrepassino la nostra capacità di farne un uso saggio e lungimirante. La preoccupazione di sostituirci a un qualche dio creatore è spesso paventata come la soglia oltre la quale non andare, per non intraprendere la strada di non ritorno.
Ma è nella natura stessa dell’essere umano divenire un creatore, un creator, cioè di colui che crea. Un soggetto dotato di ingegno e di spirito creativo che dà forma a qualcosa di nuovo, non presente nella realtà in quanto tale, ma generato dall’inventiva, dalle intuizioni, dalla capacità di saper immaginare una realtà diversa da quella data dalla cogenza della natura. L’uomo, nella sua storia evolutiva, è sempre stato un creatore. Quando diecimila anni fa si è sviluppata, con tutta la sua forza dirompente, la rivoluzione agricola, l’uomo ha fatto un balzo in avanti come creatore, imparando a governare la forza della natura per propri scopi, costringendo le piante e gli ortaggi a crescere secondo tempi, modi e circostanze imposte dall’uomo. E lo stesso è avvenuto per le specie animali che sono state addomesticate attraverso, ad esempio, gli incroci. Una sorta di ingegneria genetica ante litteram, che ha preceduto le complesse tecniche di cui oggi disponiamo. Questa svolta nel percorso di sviluppo dell’umanità è stata essenziale per permetterci, millenni dopo, di raggiungere le conquiste culturali, scientifiche e sociali che sono oggi patrimonio dell’umanità.
Tra diecimila anni, se avremo avuto la capacità come specie di continuare a prosperare, forse, la nostra epoca verrà vista come la culla di un’altra rivoluzione in cui l’uomo ha mosso i suoi primi decisi passi verso la rivoluzione postumana. Un periodo in cui si è concluso lo stadio evolutivo dentro l’uomo, dentro la sua carnalità, e si è aperta una fase postumana, in cui le capacità personali e collettive si amplificano grazie all’integrazione con i progressi della tecnologia e delle scienze. È abbastanza facile ipotizzare che nel giro di pochi decenni le scoperte nel campo della biotecnologia potrebbero consentirci di effettuare alterazioni enormi della fisiologia umana: il sistema immunitario potrebbe essere reso capace di resistere a qualsiasi tipo di minaccia, regalandoci un’esistenza priva di malattie, e quindi un ulteriore allungamento dell’aspettativa di vita. Allo stesso modo si potrà intervenire sulle nostre capacità intellettuali ed emotive. L’evoluzione che ha portato alla comparsa dell’Homo Sapiens è stata, per quanto ne sappiamo, frutto del caso e delle circostanze. Perché non poter prevedere un’ulteriore evoluzione, questa volta progettata dall’Homo Sapiens stesso? Sarà, evidentemente, la fine dei Sapiens ma non nell’accezione catastrofista che in diversi paventano, ma nella prospettiva di una staffetta generazionale di una specie umana che ha preparato i prodomi per la successiva venuta di una specie superiore.
Queste prospettive di cambiamento non devono comunque né eccessivamente allarmare coloro i quali sono preoccupati della fine dell’umanità, né d’altro canto devono esaltare i fautori di un imminente salto di specie. Se c’è una cosa che la storia ci insegna è appunto che tra la progettazione dell’uomo e la sua concretizzazione può occorrere un lasso di tempo molto lungo, con inciampi e imprevisti, alcuni dei quali non necessariamente negativi. Tra chi negli anni ’80 immaginava il futuro nel nuovo millennio, nessuno aveva previsto la penetrazione che poi ha avuto internet nella vita degli individui. Stiamo muovendo i primi incerti passi nella dimensione del postumano per cui abbiamo la necessità di continuare a comprendere ed esplorare questi nuovi scenari esistenziali.
In fondo, incamminandoci nell’era del postumano non facciamo altro che proseguire il movimento di emancipazione che l’umanità ha sempre cercato: emancipazione dalla natura, dalla necessità, dal dolore, perfino dalla propria finitezza. Un processo che è alla base del successo della specie Homo Sapiens come specie. Ma questo non significa abbandonare l’umano, né superarlo per qualcosa al di fuori dell’uomo, bensì continuare a interpretarlo, a reinterpretarlo nel segno della differenza e del cambiamento. L’uomo postumano non è il superuomo, ma un uomo che ha accettato la propria apertura, la propria disponibilità a mutare, a lasciarsi trasformare. E nel farlo si accorge anche degli effetti negativi del suo processo e dei pericoli che esso stesso ha determinato, per la propria specie e per l’intero pianeta. Ma è proprio in questo che si riscopre umano: nella consapevolezza che la propria creazione, per quanto ingegnosa, per quanto innovativa, non è mai perfetta, né priva di pericoli. Per cui va rivista, rimodulata, riadattata.
Non dobbiamo temere il futuro come se fosse un destino che ci sovrasta, né celebrarlo come un mito redentivo. Il futuro, come sempre, sarà ciò che noi interpreteremo di esso. Anche la tecnologia, per quanto potente, non è un’idolatria o un assoluto, ma una narrazione che possiamo comprendere e orientare. E se l’umano cambierà — e cambierà, come sempre è cambiato — questo cambiamento non sarà una frattura, ma una traduzione: un modo per dire altrimenti ciò che siamo sempre stati.
Forse tra diecimila anni non ci saranno più Homo Sapiens come li conosciamo oggi, ma ci sarà ancora qualcosa che ricorda, che interpreta, che racconta. Perché l’umanità non è una struttura ontologica, ma un racconto che continua. E se continuerà, sarà perché avremo saputo riconoscere nel postumano non una negazione, ma una possibilità. Una possibilità fragile, incerta, e proprio per questo autenticamente umana.
Simone Digennaro
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale