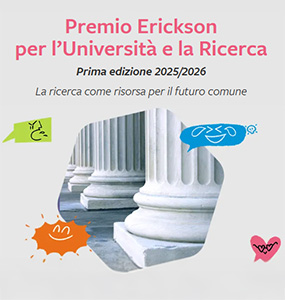Autobiografie giovanili. Marcare le proprie tracce
Lara Balleri
Testimoniare la propria presenza, lasciare un segno e dar forma ai propri ricordi. Sono molteplici le forme di espressione di sé, così come i linguaggi che ad esse si associano e che consentono di collegare l’uno a tanti, l’interno con l’esterno. Tra i generi letterari, la biografia è quella che più si concentra sull’individuo configurando una disciplina che ispira e sfida costantemente chi cerca e coltiva la consapevolezza della pluralità delle dimensioni umane (Palumbo e Garbarino, 2006). Scrivere la propria autobiografia, in particolare, permette all’autore di collegare pensato e scritto, passando attraverso il riflettuto; questa facoltà, propria di una scrittura riflessiva (Schön, 1993; Dewey, 2019), rende il genere letterario dell’autobiografia squisitamente orientato alla cura della persona (Cambi, 2005) e mette a disposizione di ogni lettore un ampio catalogo di storie di vita, da leggere in ottica di formazione di sé. Raccontare la propria storia e accedere alle autobiografie degli altri fa sì che si costruiscano sia identità che appartenenza, ma anche si impari a tenere insieme i diversi contesti nei quali ci si racconta. In questa sede s’intende proporre una strategia che attraverso l’autobiografia possa supportare i giovani nella costruzione di sé e nella comprensione delle specificità valoriali del trinomio privato-pubblico-condiviso; rientra tra le premesse la volontà di rispettare la funzione identitaria dei loro linguaggi e tra gli obiettivi quello di supportare i giovani nella costruzione di un filo che consenta loro di trovarsi e ritrovarsi, pluridimensionali come sono, tra dimensione online e offline.
Keywords
Autobiografia, fotografia, generazione Z, onlife.