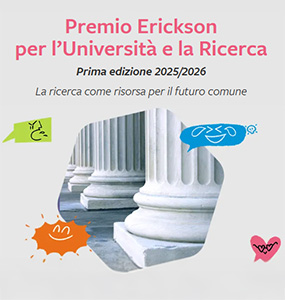Vol. 2, n. 2, ottobre 2025
Strategie educative per l’era onlife: una nuova frontiera educativa
Giulia Fiorese1
Sommario
Nell’era onlife, caratterizzata dalla crescente integrazione tra dimensione digitale e fisica, il contesto educativo sta subendo trasformazioni profonde. Questo articolo esamina come le tecnologie digitali, diventate parte integrante della vita quotidiana, stiano non solo rimodellando le metodologie didattiche, ma anche ridefinendo le competenze necessarie per affrontare le sfide della società contemporanea. Partendo dal concetto di onlife, che sfuma le tradizionali distinzioni tra online e offline, si esplora l’impatto di questa trasformazione sull’educazione. Vengono analizzate le implicazioni sociali ed etiche dell’uso pervasivo delle tecnologie, sottolineando l’importanza di sviluppare una consapevolezza critica tra gli studenti. L’articolo propone strategie pedagogiche innovative per l’integrazione efficace delle tecnologie digitali, come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, nel processo educativo. Inoltre, si evidenzia la necessità di un approccio educativo che promuova non solo competenze tecniche, ma anche un pensiero critico e una riflessione etica, al fine di preparare gli studenti a navigare con successo in un mondo sempre più interconnesso. L’articolo si conclude con una riflessione sulle prospettive future dell’educazione nell’era onlife, sottolineando l’importanza di un’educazione inclusiva e consapevole.
Parole chiave
Cittadinanza onlife, innovazione pedagogica, multimodalità, cybercultura, consapevolezza digitale.
Educational strategies for the onlife era: A new educational frontier
Giulia Fiorese2
Abstract
In the onlife era, characterized by the growing integration between digital and physical dimensions, the educational landscape is undergoing profound transformations. This article examines how digital technologies, which have become an integral part of daily life, are not only reshaping teaching methodologies but also redefining the skills needed to face the challenges of contemporary society. Starting from the concept of onlife, which blurs traditional distinctions between online and offline, the impact of this transformation on education is explored. The social and ethical implications of the pervasive use of technologies are analyzed, emphasizing the importance of fostering critical awareness among students. The article proposes innovative pedagogical strategies for effectively integrating digital technologies, such as artificial intelligence and augmented reality, into the educational process. Furthermore, it highlights the need for an educational approach that promotes not only technical skills but also critical thinking and ethical reflection, in order to prepare students to navigate successfully in an increasingly interconnected world. The article concludes with a reflection on the future prospects of education in the onlife era, underscoring the importance of an inclusive and conscious education.
Keywords
Onlife Citizenship, pedagogical innovation, multimodality, cyberculture, digital awareness.
Introduzione
Nell’epoca contemporanea, siamo testimoni di una crescente compenetrazione tra le dimensioni online e offline, una trasformazione che ha radicalmente cambiato non solo il modo in cui interagiamo con il mondo, ma anche le strutture fondamentali della società, inclusa quella educativa. Il concetto di onlife, coniato da Luciano Floridi, rappresenta questa nuova realtà, in cui la fusione tra esperienze digitali e fisiche crea un continuum in cui le distinzioni tradizionali tra il mondo reale e quello virtuale diventano sempre più sfumate e difficili da definire (Floridi, 2020). In questo contesto, le esperienze digitali non sono più separate dalla vita quotidiana, ma ne diventano un’estensione integrata e inscindibile, influenzando profondamente ogni aspetto della nostra esistenza.
Questa trasformazione è particolarmente rilevante per il settore educativo, dove la digitalizzazione sta non solo rimodellando le metodologie didattiche e le dinamiche di interazione tra insegnanti e studenti, ma sta anche ridefinendo le competenze necessarie per navigare con successo nella società moderna. La digitalizzazione, infatti, non si limita a introdurre nuovi strumenti tecnologici nel processo educativo, ma richiede una vera e propria riformulazione dei paradigmi pedagogici tradizionali. Le istituzioni educative, di conseguenza, si trovano di fronte a una duplice sfida: da un lato, devono adattarsi rapidamente per fornire agli studenti le competenze digitali necessarie per prosperare in un mondo sempre più interconnesso; dall’altro, devono affrontare le complessità etiche e sociali derivanti dall’uso diffuso delle tecnologie.
Il contesto educativo attuale presenta, dunque, opportunità straordinarie, ma anche sfide senza precedenti. La pervasività della tecnologia nella vita quotidiana degli studenti impone una riconsiderazione non solo dei metodi di insegnamento e apprendimento, ma anche dei valori e delle competenze che l’educazione deve promuovere. Se da una parte le tecnologie digitali offrono strumenti potenti per personalizzare l’apprendimento e democratizzare l’accesso al sapere, dall’altra emergono questioni cruciali come l’inclusività digitale, lo sviluppo di una consapevolezza critica riguardo all’uso delle tecnologie, e la necessità di affrontare le implicazioni etiche e sociali dell’educazione digitale in modo sistematico e ponderato.
Questo articolo ha l’obiettivo di esplorare le strategie educative più efficaci per affrontare queste sfide e sfruttare le opportunità offerte dall’era onlife. In particolare, vengono esaminate le principali implicazioni sociali ed etiche dell’uso pervasivo della tecnologia nell’educazione, con un focus specifico sul ruolo cruciale degli educatori nello sviluppo di una consapevolezza critica tra gli studenti. Sono, inoltre, analizzate le strategie pedagogiche innovative che possono essere adottate per integrare efficacemente le tecnologie digitali nel processo educativo, riflettendo su come l’intelligenza artificiale possa arricchire l’esperienza di apprendimento e quali competenze siano necessarie per un uso responsabile e consapevole di queste tecnologie. Infine, l’articolo offre una panoramica sulle prospettive future dell’educazione nell’era onlife, sottolineando l’importanza di un approccio critico e riflessivo nell’adozione di nuove tecnologie.
Costruire consapevolezza critica nel mondo onlife
L’integrazione pervasiva della tecnologia nella vita quotidiana ha profonde implicazioni sociali ed etiche, soprattutto nel contesto educativo, dove gli effetti di tale integrazione sono avvertiti con particolare intensità. L’uso massiccio di strumenti digitali e piattaforme online ha il potenziale di ridurre le interazioni umane dirette, influenzando negativamente lo sviluppo delle abilità sociali e la capacità di empatia degli studenti (Turkle, 2016). Numerosi studi hanno evidenziato come la costante esposizione agli schermi e la comunicazione mediata dai dispositivi tecnologici possano portare a una diminuzione delle competenze interpersonali, poiché gli studenti possono trovare più facile interagire con i loro coetanei attraverso messaggi di testo piuttosto che in conversazioni faccia a faccia (Twenge, 2017; Przybylski e Weinstein, 2019). Questo cambiamento può avere ripercussioni a lungo termine sulla loro capacità di costruire relazioni autentiche e significative, mettendo a rischio lo sviluppo di competenze sociali essenziali per il loro futuro personale e professionale.
Tuttavia, l’integrazione della tecnologia offre anche numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a una vasta gamma di risorse educative, la personalizzazione dei percorsi di apprendimento e la possibilità di connettersi con una rete globale di conoscenza e di collaboratori (Anderson, 2010). Gli strumenti digitali permettono agli studenti di accedere a materiali didattici di alta qualità da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, eliminando le restrizioni geografiche e temporali dell’educazione tradizionale. Questo accesso ubiquo e democratico può favorire una maggiore equità educativa, permettendo anche agli studenti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati di accedere a risorse che altrimenti sarebbero loro precluse.
Gli strumenti digitali possono facilitare l’apprendimento personalizzato, consentendo agli studenti di avanzare secondo i propri ritmi e di esplorare argomenti di interesse personale in profondità. Le piattaforme educative online spesso includono funzionalità che monitorano i progressi degli studenti e adattano automaticamente i contenuti e le attività per rispondere alle loro esigenze individuali. Questo tipo di personalizzazione può aumentare l’engagement e la motivazione degli studenti, poiché vedono riconosciuti i loro progressi in tempo reale e ricevono feedback immediato e mirato sul loro lavoro (OECD, 2018).
La tecnologia può anche supportare l’apprendimento collaborativo, mettendo in contatto studenti di diverse parti del mondo e promuovendo scambi culturali e di conoscenze (Dede, 2009). Le piattaforme di collaborazione online e gli strumenti di comunicazione sincrona e asincrona consentono agli studenti di lavorare insieme su progetti comuni, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. Questo tipo di interazione non solo arricchisce l’esperienza educativa degli studenti, ampliando i loro orizzonti culturali e professionali, ma li prepara anche a lavorare in un mondo globalizzato dove le competenze di collaborazione interculturale sono sempre più valorizzate (Huang, Spector e Yang, 2019). Inoltre, le piattaforme online e le risorse digitali possono rendere l’educazione più accessibile, superando le barriere geografiche e socioeconomiche che tradizionalmente limitano l’accesso all’istruzione di qualità (Castells, 2014). Le università e le scuole possono offrire corsi online gratuiti o a basso costo, aprendo nuove opportunità di apprendimento per chiunque abbia accesso a una connessione internet. Questo fenomeno è evidente nel successo dei Massive Open Online Courses (MOOC),3 che hanno democratizzato l’accesso all’istruzione superiore a livello globale (Hollands e Tirthali, 2014).
Gli educatori, dunque, si trovano a dover affrontare la responsabilità di guidare gli studenti attraverso un panorama tecnologico complesso e in continua evoluzione. Essi devono promuovere una consapevolezza critica riguardo all’uso delle tecnologie digitali, incoraggiando gli studenti a riflettere sulle implicazioni delle loro interazioni online e sull’impatto delle tecnologie sulla loro vita personale e sociale (Selwyn, 2014; 2016). Questo richiede un approccio pedagogico che non solo trasmetta conoscenze tecniche, ma che sviluppi anche un senso di responsabilità e di etica digitale (Ribble, 2015). In questo senso, gli insegnanti non sono più solo trasmettitori di contenuti, ma veri e propri facilitatori di un pensiero critico che permette agli studenti di navigare consapevolmente tra le opportunità e i rischi dell’era digitale.
Per sviluppare una consapevolezza critica tra studenti e insegnanti è fondamentale adottare approcci educativi che promuovano la riflessione e l’analisi. Questo implica un approccio educativo integrato che consideri non solo le competenze tecniche, ma anche le competenze etiche e sociali. Questo può essere realizzato attraverso l’integrazione di tematiche etiche e sociali nei curricula scolastici, l’uso di metodologie didattiche partecipative, e l’incoraggiamento del pensiero critico (Freire, 2002). Gli studenti devono essere stimolati a interrogarsi sui motivi e sulle conseguenze delle loro scelte digitali, sviluppando la capacità di valutare le informazioni e di riconoscere i potenziali rischi associati all’uso delle tecnologie: un processo cruciale per formare cittadini digitali consapevoli, in grado di navigare con responsabilità nel mondo digitale (Buckingham, 2006).
Un primo passo per sviluppare questa consapevolezza critica è l’inclusione sistematica di moduli di educazione digitale che affrontino non solo gli aspetti tecnici dell’uso della tecnologia, ma anche le questioni etiche e sociali correlate. Questi moduli dovrebbero coprire argomenti come la privacy digitale, la sicurezza online, la gestione dell’identità digitale e l’analisi critica delle fonti di informazione. L’obiettivo è creare una didattica che non si limiti a fornire strumenti, ma che formi individui capaci di comprendere e gestire le implicazioni delle tecnologie nella loro vita quotidiana. La didattica deve quindi andare oltre l’insegnamento delle competenze tecniche per abbracciare una visione più olistica che consideri l’impatto della tecnologia sulla società e sugli individui (Rheingold, 2012).
Le metodologie didattiche partecipative, come il problem-based learning (PBL) e l’apprendimento cooperativo, sono particolarmente efficaci nel promuovere la consapevolezza critica. Il PBL, ad esempio, coinvolge gli studenti in progetti complessi che richiedono la risoluzione di problemi reali, favorendo così un apprendimento attivo e profondamente coinvolgente (Hmelo-Silver, 2004). Attraverso questi progetti, gli studenti imparano a identificare problemi, valutare diverse soluzioni, e riflettere criticamente sui risultati delle loro azioni, sviluppando una comprensione più profonda delle materie trattate e delle loro applicazioni pratiche. Questo tipo di apprendimento è essenziale per sviluppare la capacità di pensare in modo critico e di applicare le conoscenze acquisite in contesti pratici.
Un altro elemento fondamentale è la formazione continua degli insegnanti. Essi devono essere preparati non solo a utilizzare le tecnologie digitali, ma anche a promuovere un utilizzo critico e consapevole di queste tecnologie da parte degli studenti. La formazione degli insegnanti dovrebbe includere moduli specifici sull’educazione digitale, che forniscano competenze pratiche e strumenti didattici per affrontare le sfide dell’era onlife (Mishra e Koehler, 2006). Inoltre, gli insegnanti devono essere aggiornati sulle ultime novità tecnologiche e pedagogiche, partecipando a corsi di aggiornamento professionale e a comunità di pratica che facilitino lo scambio di esperienze e buone pratiche (Vrasidas e Glass, 2007). Questo aggiornamento continuo è cruciale per garantire che gli educatori siano sempre pronti ad affrontare le sfide di un panorama tecnologico in rapida evoluzione.
Innovazione pedagogica e alfabetizzazione digitale
L’innovazione pedagogica è diventata un elemento cruciale nell’educazione contemporanea, soprattutto in risposta alla rapida evoluzione delle tecnologie digitali. Le strategie pedagogiche innovative non solo rispondono alle esigenze degli studenti del XXI secolo, ma trasformano anche il modo in cui l’insegnamento e l’apprendimento vengono percepiti e implementati. In particolare, esse mirano a rendere l’apprendimento più dinamico, interattivo e pertinente al contesto globale e digitale in cui gli studenti operano oggi.
Un aspetto chiave di questa trasformazione è la multimodalità, che si riferisce all’uso di diverse modalità di comunicazione e rappresentazione per facilitare l’apprendimento. La multimodalità include l’uso integrato di testi, immagini, audio, video e altri media digitali per creare esperienze di apprendimento più ricche e coinvolgenti. Questo approccio non solo cattura l’attenzione degli studenti, ma supporta anche vari stili di apprendimento, permettendo a ogni studente di accedere al contenuto nel modo più efficace per loro: mentre alcuni studenti possono apprendere meglio attraverso letture e testi scritti, altri possono trovare i video o le simulazioni interattive più utili (Jewitt, 2008).
Per implementare efficacemente la multimodalità in aula, gli insegnanti possono utilizzare una varietà di strumenti digitali. Una possibilità è data dalle presentazioni multimediali, le quali possono combinare testo, immagini, video e audio per spiegare concetti complessi in modo più chiaro e coinvolgente. Piattaforme come Prezi, Microsoft PowerPoint e Canva consentono di creare presentazioni dinamiche che possono includere animazioni e interattività, rendendo le lezioni più vivaci e stimolanti. Un secondo esempio concreto di attuazione della multimodalità è l’uso di video educativi per illustrare concetti scientifici complessi. Un insegnante di fisica potrebbe utilizzare video che mostrano esperimenti di laboratorio o simulazioni di fenomeni fisici come l’elettromagnetismo o la relatività. Questi video possono essere integrati con spiegazioni testuali, discussioni ed esperimenti in classe per garantire una comprensione approfondita dei concetti trattati.
Le tecnologie digitali consentono inoltre di creare ambienti di apprendimento immersivi, come realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR),4 che offrono esperienze educative uniche e profondamente coinvolgenti. Questi strumenti possono trasportare gli studenti in mondi virtuali dove possono esplorare concetti complessi in modo pratico e interattivo, facilitando una comprensione più profonda e duratura dei contenuti (Dede, 2009). L’integrazione di VR e AR nella didattica può avvenire attraverso diversi approcci. In un corso di biologia gli studenti potrebbero utilizzare la realtà virtuale per esplorare il corpo umano in tre dimensioni, osservando direttamente l’interazione tra organi e sistemi. In un altro contesto, una lezione di storia potrebbe includere un tour virtuale di antiche civiltà, permettendo agli studenti di camminare tra le rovine di Pompei o esplorare le piramidi d’Egitto. Questo tipo di immersione non solo rende l’apprendimento più coinvolgente, ma aiuta anche gli studenti a comprendere il contesto storico e culturale in modo più tangibile e concreto: un vero e proprio viaggio nella storia. In un corso di geografia, invece, gli studenti potrebbero utilizzare la realtà aumentata per visualizzare mappe in 3D che mostrano cambiamenti climatici o fenomeni geologici in tempo reale, arricchendo la loro comprensione del pianeta.
Le piattaforme di collaborazione online sono un altro strumento potente per l’implementazione della multimodalità. Strumenti come Google Classroom, Microsoft Teams e Moodle permettono agli studenti di lavorare insieme su progetti comuni, scambiare idee e fornire feedback reciproci, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. Questo non solo promuove competenze di collaborazione e comunicazione, ma prepara anche gli studenti a lavorare in un ambiente di lavoro globalizzato e interconnesso (Redecker et al., 2009). Ad esempio, in un progetto di scienze, gli studenti possono utilizzare Google Docs per co-scrivere un rapporto, incorporando grafici e dati raccolti da vari esperimenti. Possono discutere i loro progressi in tempo reale utilizzando Google Meet, Zoom o Microsoft Teams, condividendo le loro schermate per mostrare risultati e risolvere problemi insieme. Questo tipo di collaborazione digitale simula le dinamiche del lavoro di squadra in ambito professionale, preparando gli studenti per le sfide del mondo del lavoro.
Inoltre, l’uso di blog5 e vlog6 come strumenti educativi può ampliare ulteriormente le opportunità di apprendimento multimodale. Gli studenti possono creare blog per riflettere sui loro apprendimenti, condividere risorse e discutere di temi rilevanti con i loro coetanei. Un blog potrebbe essere utilizzato per un corso di letteratura, all’interno del quale gli studenti pubblicano recensioni di libri, analisi di testi e riflessioni personali sui temi trattati in classe. Questo non solo sviluppa le loro competenze di scrittura, ma promuove anche la condivisione di idee e la costruzione di una comunità di apprendimento.
I vlog permettono agli studenti di sviluppare competenze di comunicazione verbale e audiovisiva, creando contenuti video per presentare progetti, spiegare concetti o condividere esperienze di apprendimento. In un corso di matematica, gli studenti potrebbero creare un vlog in cui spiegano e dimostrano la risoluzione di problemi complessi come l’applicazione del teorema di Pitagora o la risoluzione di equazioni quadratiche utilizzando esempi reali e grafici interattivi. Questo tipo di attività non solo aiuta a consolidare le loro competenze matematiche, ma li incoraggia anche a comunicare concetti astratti in modo chiaro e accessibile.
Un ruolo simile viene assunto anche dalla creazione di contenuti da parte degli studenti: Progetti che coinvolgono la produzione di brevi video, podcast, infografiche o siti web permettono agli studenti di esprimere la loro creatività e di applicare le loro conoscenze in modi pratici, tangibili e differenziati. In un corso di arte, gli studenti potrebbero essere incaricati di creare un portfolio digitale delle loro opere, corredato da video in timelapse7 in cui spiegano il processo creativo dietro ciascun pezzo, analizzano le tecniche utilizzate e riflettono sulle influenze artistiche che hanno ispirato il loro lavoro. Questo non solo permette di documentare e condividere il proprio sviluppo artistico, ma incoraggia anche una riflessione critica e una presentazione professionale delle proprie competenze. In un progetto di scienze, gli studenti potrebbero essere incaricati di creare un video documentario su un tema scientifico di loro scelta, presentando le loro scoperte attraverso interviste, esperimenti filmati e grafici animati. Questo tipo di attività non solo sviluppa competenze tecniche, ma incoraggia anche il pensiero critico e la comunicazione efficace.
Infine, la gamification8 è un altro approccio innovativo che può essere integrato nell’apprendimento multimodale. Utilizzare elementi di gioco, come punteggi, badge9 e classifiche, può aumentare l’engagement degli studenti e motivarli a raggiungere i loro obiettivi di apprendimento. Piattaforme come Kahoot! e Classcraft offrono strumenti per creare quiz interattivi e avventure educative che trasformano l’apprendimento in un’esperienza ludica e coinvolgente (Kapp, 2012). Ad esempio, in un corso di matematica, un insegnante potrebbe utilizzare Kahoot! per creare quiz che permettono agli studenti di competere in modo amichevole, rendendo l’apprendimento di tabelline o formule matematiche più divertente e meno intimidatorio. In un corso di storia, Classcraft potrebbe essere utilizzato per creare missioni basate su eventi storici, dove gli studenti devono completare attività di ricerca e presentazioni per guadagnare punti e avanzare nel gioco.
L’innovazione pedagogica e la multimodalità offrono numerose opportunità per trasformare l’educazione e renderla più adatta alle esigenze degli studenti del XXI secolo. Attraverso l’uso di tecnologie digitali e metodologie innovative, gli educatori possono creare esperienze di apprendimento più ricche, coinvolgenti e personalizzate, preparando gli studenti a diventare cittadini digitali competenti e critici.
Nell’era dell’onlife, la padronanza delle competenze digitali è divenuta non solo auspicabile, ma essenziale per garantire una piena cittadinanza attiva. Le competenze digitali, intese come l’insieme delle abilità necessarie per utilizzare le tecnologie in modo efficace, critico e sicuro, rappresentano un pilastro fondamentale dell’educazione contemporanea (Ferrari, 2013). Oggi, più che mai, è fondamentale che il curriculum scolastico integri l’alfabetizzazione digitale come parte centrale del processo formativo, non più come semplice appendice, ma come elemento essenziale in grado di preparare gli studenti ad affrontare le sfide della società digitale (Calvani, Fini e Ranieri, 2010). La digitalizzazione ha cambiato radicalmente il modo in cui le informazioni vengono create, diffuse e consumate, ponendo nuove sfide ma anche enormi opportunità per l’apprendimento. Di conseguenza, non è sufficiente che gli studenti sappiano semplicemente usare gli strumenti tecnologici; devono essere capaci di farlo in modo critico, creativo e consapevole, diventando cittadini digitali a pieno titolo.
Il concetto di alfabetizzazione digitale si è evoluto significativamente negli ultimi anni. Inizialmente limitato alla capacità di utilizzare strumenti informatici di base, oggi comprende una gamma più ampia di competenze, tra cui il pensiero critico, il problem solving, il pensiero computazionale e il pensiero divergente (Voogt e Roblin, 2012). Queste competenze permettono agli studenti non solo di essere fruitori passivi di tecnologie, ma di comprendere e modellare attivamente il mondo digitale che li circonda (Prensky, 2001). In questo contesto, il pensiero critico emerge come una delle competenze fondamentali per affrontare le sfide dell’era digitale. Esso consiste nella capacità di analizzare, valutare e sintetizzare informazioni in modo logico e sistematico, al fine di formare un giudizio ben fondato. Il pensiero critico è particolarmente importante nel contesto online, dove l’accesso a un’enorme quantità di informazioni richiede la capacità di discernere tra fonti attendibili e meno attendibili, distinguendo fatti, opinioni e disinformazione. Per esempio, un’attività scolastica volta a sviluppare questa competenza potrebbe consistere nell’analisi comparativa di diverse fonti di informazione su un medesimo argomento, incoraggiando gli studenti a identificare eventuali bias e a valutare la credibilità delle fonti (Facione, 2015). Un approccio metodologico che può essere utilizzato per sviluppare il pensiero critico è il debate, una pratica in cui gli studenti devono argomentare a favore o contro una determinata posizione, utilizzando fonti documentate e dimostrando la capacità di analizzare criticamente le argomentazioni contrarie.
Il problem solving, invece, implica la capacità di identificare, analizzare e risolvere problemi in modo efficiente e creativo. Questa competenza è particolarmente rilevante nel contesto digitale, dove gli studenti si trovano spesso a dover affrontare ostacoli tecnici o a dover elaborare soluzioni innovative per problemi complessi. Nel campo dell’educazione, il problem solving può essere coltivato attraverso attività pratiche che simulano scenari reali. Un esempio può essere rappresentato dai progetti di robotica educativa mediante l’utilizzo di Bee-Bot,10 dove gli studenti devono progettare, costruire e programmare percorsi per i robot, imparando così a risolvere compiti specifici e a gestire in modo diretto la complessità di un progetto tecnologico. Questo tipo di attività non solo rafforza la loro capacità di risolvere problemi tecnici, ma incoraggia anche l’adozione di un approccio sistematico e metodico nella risoluzione dei problemi (Jonassen, 2011).
Il pensiero computazionale, d’altro canto, è un processo mentale che permette di affrontare problemi in modo strutturato e sistematico, tipicamente attraverso la scomposizione di problemi complessi in parti più semplici e la definizione di soluzioni algoritmiche. Questa competenza è fondamentale nell’apprendimento della programmazione e nell’interazione con le tecnologie digitali. Un’attività scolastica tipica per sviluppare il pensiero computazionale potrebbe essere la creazione di semplici programmi utilizzando linguaggi di programmazione adatti ai principianti, come Scratch o Python (Wing, 2006). Attraverso queste attività, gli studenti imparano a pensare in modo logico e sequenziale, a scomporre i problemi in unità gestibili e a sviluppare soluzioni algoritmiche. Il pensiero computazionale, tuttavia, non si limita alla programmazione. Esso comprende anche la capacità di rappresentare dati in modo astratto e di capire come le diverse tecnologie possono essere utilizzate per risolvere problemi complessi. Ad esempio, una lezione sul pensiero computazionale potrebbe prevedere la simulazione di un processo decisionale complesso, come la progettazione del giardino scolastico, in cui gli studenti devono considerare molteplici variabili e sviluppare modelli per prevedere l’impatto delle loro decisioni.
Infine, il pensiero divergente si riferisce alla capacità di generare idee creative e originali, esplorando molteplici possibili soluzioni a un problema. Questa competenza è essenziale per l’innovazione e il problem solving creativo, in quanto incoraggia gli studenti a pensare fuori dagli schemi e a non limitarsi alle soluzioni più ovvie. Un esempio di attività scolastica potrebbe essere un progetto di brainstorming collaborativo, dove gli studenti sono incoraggiati a proporre diverse soluzioni innovative per un problema comune, come il miglioramento delle pratiche sostenibili nella scuola (Runco e Acar, 2012). Il pensiero divergente è particolarmente utile nei contesti in cui è necessario affrontare problemi complessi e aperti, per i quali non esiste una soluzione unica e predeterminata. In questi casi, incoraggiare gli studenti a guardare i problemi da diverse angolazioni, a esplorare soluzioni multiple e a valutare le loro implicazioni può portare a risultati innovativi e creativi.
Queste competenze, se sviluppate efficacemente, preparano gli studenti non solo ad affrontare le sfide del mondo digitale, ma anche a diventare cittadini critici, creativi e responsabili. Gli educatori hanno quindi la responsabilità di fornire agli studenti gli strumenti necessari per sviluppare una visione critica e consapevole delle tecnologie digitali, contribuendo così alla formazione di cittadini informati e responsabili (Ferrari, 2013). In questo senso, l’integrazione di queste competenze nel curriculum scolastico non rappresenta soltanto un’opportunità per migliorare l’apprendimento degli studenti, ma anche una necessità per prepararli adeguatamente al futuro.
Intelligenza artificiale nel contesto scolastico
L’intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle innovazioni tecnologiche più significative del XXI secolo, con impatti profondi su vari settori, tra cui l’educazione. La sua applicazione nel contesto scolastico offre nuove opportunità per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, consentendo lo sviluppo di approcci educativi più personalizzati, inclusivi ed efficaci. Tuttavia, l’implementazione dell’IA in ambito educativo solleva anche interrogativi di natura etica, sociale e pedagogica che richiedono un’attenta considerazione.
Uno degli ambiti più promettenti dell’IA nell’educazione è rappresentato dai sistemi di tutoraggio intelligente (Intelligent Tutoring Systems, ITS). Questi sistemi sfruttano algoritmi avanzati per analizzare il comportamento degli studenti e adattare il contenuto didattico alle loro esigenze specifiche. Gli ITS sono in grado di fornire feedback immediato e personalizzato, supportando gli studenti nel processo di apprendimento attraverso esercizi adattivi che rispondono in tempo reale alle loro prestazioni. Woolf ha evidenziato come gli ITS possano ridurre significativamente il divario di apprendimento, consentendo un’istruzione su misura che tiene conto delle capacità individuali e dei ritmi di apprendimento degli studenti (Woolf, 2010). Studi recenti hanno inoltre dimostrato che l’utilizzo degli ITS può aumentare la motivazione degli studenti, poiché essi percepiscono un sostegno costante e personalizzato nel loro percorso educativo (VanLehn, 2011). Un esempio pratico di utilizzo degli ITS è rappresentato dal sistema Cognitive Tutor, sviluppato per l’insegnamento della matematica. Questo sistema utilizza modelli cognitivi per seguire le azioni degli studenti mentre risolvono problemi, offrendo suggerimenti personalizzati e feedback immediato quando rileva errori o difficoltà. Gli studenti che utilizzano Cognitive Tutor hanno mostrato un miglioramento significativo nelle loro abilità matematiche rispetto a quelli che seguono i metodi tradizionali di insegnamento (Koedinger et al., 1997). Il sistema non solo personalizza l’insegnamento in base al livello di competenza dello studente, ma lo aiuta anche a sviluppare una comprensione più profonda dei concetti matematici attraverso esercizi interattivi e adattivi.
Parallelamente, l’IA ha aperto nuove prospettive nell’analisi predittiva applicata al contesto educativo. L’analisi dei big data11 raccolti attraverso piattaforme educative digitali consente di identificare precocemente le difficoltà di apprendimento e di intervenire in modo tempestivo. Ad esempio, Baker e Yacef descrivono come l’analisi predittiva possa essere utilizzata per monitorare il progresso degli studenti e prevedere i potenziali rischi di abbandono scolastico (Baker e Yacef, 2009). Questo approccio proattivo permette agli educatori di sviluppare strategie di intervento mirate, migliorando così la retention scolastica12 e promuovendo un’educazione più equa e inclusiva. L’analisi predittiva non solo facilita la personalizzazione dell’insegnamento, ma contribuisce anche a una migliore allocazione delle risorse educative, garantendo che gli interventi siano diretti verso gli studenti che ne hanno più bisogno (Siemens, 2013). Un esempio di analisi predittiva in ambito scolastico è l’utilizzo dei Learning Management Systems (LMS), come Blackboard, che raccolgono dati sulle attività degli studenti, come il tempo speso su specifiche lezioni, la frequenza di accesso al sistema e le interazioni nei forum di discussione. Questi dati vengono analizzati per prevedere quali studenti potrebbero essere a rischio di fallimento o abbandono. Ad esempio, uno studente che accede raramente al sistema e trascorre poco tempo sulle lezioni può essere identificato come a rischio, consentendo agli insegnanti o ai tutor di intervenire tempestivamente con supporti aggiuntivi o consigli personalizzati (Arnold e Pistilli, 2012).
Inoltre, l’IA sta trasformando il modo in cui gli studenti con bisogni educativi speciali interagiscono con l’istruzione. Le tecnologie assistive basate sull’IA, come i lettori di schermo avanzati, i software di riconoscimento vocale e i sistemi di sintesi vocale, stanno diventando strumenti indispensabili per supportare l’apprendimento di questi studenti. Okolo e Diedrich descrivono l’impatto significativo della tecnologia sull’educazione degli studenti con disabilità, evidenziando come strumenti tecnologici avanzati possano promuovere l’inclusione e l’autonomia (Okolo e Diedrich, 2014). Queste tecnologie consentono di superare le barriere fisiche e cognitive, offrendo un ambiente di apprendimento che risponde meglio alle esigenze individuali e riducendo il senso di esclusione spesso sperimentato da questi studenti (Hersh e Johnson, 2008).
L’intelligenza artificiale si è rivelata particolarmente efficace anche nel supportare il design di ambienti di apprendimento personalizzati. Gli ambienti di apprendimento adattivi, alimentati dall’IA, sono in grado di modulare i percorsi educativi in base alle preferenze e alle competenze di ciascun studente, offrendo esperienze didattiche che si adattano dinamicamente alle loro esigenze. Un esempio di ambiente di apprendimento supportato dall’IA è rappresentato dalle aule intelligenti (smart classrooms), come quelle implementate nell’Università di Tampere in Finlandia. Questi spazi di apprendimento sono dotati di sensori, telecamere e microfoni, collegati a sistemi di intelligenza artificiale che monitorano in tempo reale le attività degli studenti e le condizioni dell’ambiente, come l’illuminazione e la temperatura. L’IA analizza i dati raccolti per ottimizzare il comfort e la concentrazione degli studenti, regolando automaticamente questi parametri. Inoltre, il sistema può adattare l’ambiente in base alle esigenze didattiche specifiche, come ridurre le distrazioni durante i momenti di concentrazione intensa o cambiare l’illuminazione per facilitare la lettura e la scrittura. Questi spazi offrono un ambiente che non solo supporta, ma anche migliora l’esperienza di apprendimento, creando condizioni ottimali per l’assimilazione dei contenuti (Muñoz-Organero, Muñoz-Merino e Delgado Kloos, 2010).
Un’altra applicazione innovativa dell’IA nell’educazione è rappresentata dalla valutazione stealth, una metodologia che utilizza ambienti digitali, come i videogiochi educativi, per monitorare e valutare continuamente l’apprendimento degli studenti senza interrompere il loro processo educativo. Questo approccio, descritto da Shute e Ventura, permette agli educatori di ottenere dati accurati sulle competenze e sui progressi degli studenti in modo integrato e naturale (Shute e Ventura, 2013). Ad esempio, in un ambiente di apprendimento basato su IA, le azioni degli studenti all’interno di un gioco educativo possono essere analizzate in tempo reale per valutare la loro comprensione dei concetti trattati, fornendo allo stesso tempo un feedback immediato e personalizzato. Questo tipo di valutazione, che avviene «dietro le quinte», offre una visione approfondita delle capacità degli studenti, migliorando la personalizzazione dell’insegnamento e l’efficacia delle strategie pedagogiche adottate (Shute e Ventura, 2013).
Holmes, Bialik e Fadel hanno evidenziato che questi ambienti non solo migliorano l’efficacia dell’insegnamento, ma contribuiscono anche a mantenere alta la motivazione degli studenti, riducendo il rischio di demotivazione e abbandono (Holmes, Bialik e Fadel, 2019). Inoltre, la possibilità di personalizzare il ritmo e il contenuto dell’apprendimento consente agli studenti di sviluppare un maggiore senso di controllo sul proprio percorso educativo, favorendo così una maggiore autodeterminazione (Anderson e Dron, 2011).
Un ulteriore campo in cui l’IA sta apportando significativi cambiamenti è quello della valutazione automatizzata. I sistemi di intelligenza artificiale sono oggi in grado di valutare non solo risposte chiuse, come i test a scelta multipla, ma anche elaborati complessi, come saggi scritti e progetti, con un’accuratezza che si avvicina a quella umana. Tuttavia, l’affidabilità di tali sistemi dipende dalla qualità degli algoritmi e dalla trasparenza dei criteri di valutazione utilizzati. Questo solleva importanti questioni etiche, poiché un’eventuale mancanza di equità o trasparenza potrebbe portare a discriminazioni non intenzionali (Williamson, 2017).
Oltre agli aspetti più tecnici, l’introduzione dell’IA in ambito educativo ha sollevato un dibattito intenso riguardo alle implicazioni etiche e sociali. L’utilizzo di algoritmi di machine learning13 per l’analisi e la gestione dei dati degli studenti solleva preoccupazioni significative riguardo alla privacy e alla protezione dei dati personali. Luckin e colleghi hanno sottolineato la necessità di sviluppare una governance etica per l’uso dell’IA nelle scuole, al fine di garantire che queste tecnologie siano utilizzate in modo trasparente e responsabile (Luckin et al., 2016). Le decisioni prese dagli algoritmi di IA possono avere un impatto duraturo sulla vita degli studenti, rendendo cruciale l’adozione di misure che garantiscano l’equità e la giustizia nei processi decisionali automatizzati (Eubanks, 2018).
In questo contesto, emerge anche la questione della disuguaglianza digitale. L’accesso alle tecnologie basate sull’IA non è uniforme, e le disparità esistenti in termini di accesso a risorse tecnologiche potrebbero esacerbare le disuguaglianze educative. Come sottolineato da Ferrari, è essenziale che le politiche educative mirino a garantire un accesso equo alle tecnologie digitali, al fine di evitare che l’IA diventi un fattore di esclusione piuttosto che uno strumento di inclusione (Ferrari, 2012). Inoltre, è importante che gli educatori siano formati adeguatamente per integrare queste tecnologie nei loro metodi didattici in modo efficace e sensibile alle diverse esigenze degli studenti (Selwyn, 2016).
Un aspetto particolarmente, infatti, rilevante riguarda la formazione degli insegnanti nell’uso delle tecnologie basate sull’IA. Molti docenti si trovano impreparati ad affrontare le sfide poste dall’integrazione dell’IA nelle loro pratiche didattiche. Formare gli insegnanti a utilizzare l’IA in modo efficace richiede non solo competenze tecniche, ma anche una comprensione profonda delle implicazioni pedagogiche, etiche e sociali di queste tecnologie. Luckin e colleghi esplorano come l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per rivoluzionare l’educazione, enfatizzando la necessità di un’integrazione consapevole e critica di queste tecnologie nelle pratiche didattiche (Luckin et al., 2016).
Infine, è cruciale considerare le prospettive future dell’IA nel contesto scolastico. L’evoluzione delle tecnologie di IA e la loro crescente integrazione nelle pratiche educative suggeriscono che siamo solo all’inizio di una trasformazione profonda del sistema educativo. La ricerca in questo campo deve continuare a esplorare nuove applicazioni dell’IA che possano arricchire l’esperienza educativa, promuovere l’equità e migliorare i risultati degli studenti. Tuttavia, è altrettanto importante mantenere un approccio critico e riflessivo, valutando costantemente l’impatto di queste tecnologie e adattando le pratiche educative in modo da massimizzare i benefici per tutti gli studenti (Miao et al., 2021).
L’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA) nel sistema educativo non può prescindere dallo sviluppo di competenze specifiche sia per gli insegnanti che per gli studenti. Gli insegnanti devono acquisire una conoscenza approfondita dei concetti chiave dell’IA, come il machine learning, l’elaborazione del linguaggio naturale14 e l’analisi dei big data, che sono fondamentali per comprendere come le tecnologie basate sull’IA possono essere applicate in ambito didattico. Un insegnante che utilizza un sistema di tutoraggio intelligente come Knewton15 deve essere in grado di interpretare i dati raccolti dal sistema per identificare le aree di difficoltà degli studenti e intervenire tempestivamente con strategie didattiche personalizzate. La comprensione di come l’algoritmo personalizza l’apprendimento in base ai dati degli studenti è essenziale per garantire che l’uso di queste tecnologie migliori realmente l’esperienza educativa e non lasci indietro nessuno studente (Luckin et al., 2016).
Oltre alla comprensione tecnica, gli insegnanti devono sviluppare competenze pedagogiche che permettano loro di integrare l’IA in modo significativo nelle pratiche didattiche. Non si tratta solo di automatizzare compiti ripetitivi, ma di usare l’IA per promuovere l’apprendimento collaborativo, critico e creativo. In un contesto di apprendimento in cui gli studenti utilizzano strumenti di IA per esplorare problemi complessi, gli insegnanti devono essere in grado di guidare gli studenti nell’uso di questi strumenti, aiutandoli a sviluppare competenze di problem solving e pensiero critico. Questi strumenti possono essere potenti alleati nell’aiutare gli studenti a sviluppare nuove conoscenze in modo autonomo e creativo (Holmes, Bialik e Fadel, 2019).
Accanto alle competenze tecniche e pedagogiche, è fondamentale che gli insegnanti acquisiscano una solida base di conoscenze sulle implicazioni etiche e sociali dell’uso dell’IA nell’educazione. La gestione della privacy e della sicurezza dei dati, ad esempio, è un aspetto cruciale quando si utilizzano piattaforme che raccolgono informazioni personali degli studenti. Un insegnante deve essere in grado di comprendere e spiegare come i dati vengono raccolti, utilizzati e protetti, garantendo la trasparenza necessaria per mantenere la fiducia degli studenti e delle loro famiglie e assicurando che gli studenti comprendano non solo l’importanza dell’integrità accademica, ma anche il funzionamento degli strumenti che monitorano il loro lavoro (Selwyn, 2016; Williamson, 2017).
Data la complessità e la rapidità con cui le tecnologie basate sull’IA evolvono, la formazione continua degli insegnanti diventa una componente essenziale del loro sviluppo professionale. Le istituzioni educative devono garantire l’accesso a programmi di aggiornamento che consentano agli insegnanti di rimanere al passo con le nuove tecnologie e di sviluppare le competenze necessarie per utilizzarle in modo efficace ed etico. Il progetto europeo AI4Teachers,16 ad esempio, offre corsi online progettati per insegnanti di materie STEM su come integrare l’IA nelle loro lezioni. Questi corsi non si limitano a fornire conoscenze tecniche, ma incoraggiano anche una riflessione critica sulle implicazioni pedagogiche e sociali dell’IA nell’educazione (Ferrari, 2012).
Conclusioni
L’analisi condotta in questo articolo ha messo in luce come l’avvento dell’era onlife abbia portato a una ridefinizione profonda delle dinamiche educative, obbligando i professionisti del settore a ripensare le tradizionali metodologie pedagogiche. In un contesto in cui le esperienze digitali e fisiche si sovrappongono e influenzano reciprocamente, è essenziale che l’educazione non si limiti più alla semplice trasmissione di conoscenze tecniche, ma si impegni attivamente nello sviluppo di una consapevolezza critica e di competenze trasversali che permettano agli studenti di navigare con successo in un mondo sempre più connesso.
Una delle sfide più urgenti nell’era onlife è la necessità di promuovere una competenza digitale che vada oltre l’alfabetizzazione tecnologica di base. Come sottolineato da Rivoltella, l’educazione digitale deve essere intesa come un processo integrato che coinvolge non solo l’acquisizione di abilità tecniche, ma anche lo sviluppo di capacità critiche e riflessive (Rivoltella, 2020). Gli studenti devono essere in grado di analizzare e valutare criticamente le informazioni che incontrano online, di risolvere problemi complessi in contesti digitali e di comprendere le logiche sottostanti alle tecnologie che utilizzano. Questo approccio è in linea con la crescente importanza del pensiero computazionale, una competenza che non riguarda solo la programmazione, ma anche la capacità di pensare in modo logico e strutturato, come evidenziato da Wing (Wing, 2006).
L’integrazione di tecnologie avanzate nell’ambito educativo, come la realtà aumentata e virtuale, i social media e l’intelligenza artificiale, rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione di un ambiente di apprendimento che sia al tempo stesso immersivo e rilevante per le nuove generazioni. Tuttavia, come indicato da Sancassani, è fondamentale che l’adozione di tali tecnologie non sia fine a se stessa, ma sia accompagnata da una riflessione critica sui loro potenziali impatti sociali ed etici (Sancassani, 2019). L’obiettivo non è solo quello di rendere l’apprendimento più accattivante, ma anche di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere e gestire le complesse dinamiche della società digitale.
Un aspetto cruciale che emerge da questa riflessione è la necessità di affrontare il divario digitale, che rischia di ampliare le disuguaglianze esistenti e di escludere una parte significativa della popolazione dalle opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Come sottolineato dall’OECD, garantire un accesso equo alle tecnologie è una priorità che richiede investimenti mirati sia nelle infrastrutture che nella formazione (OECD, 2024). Solo attraverso un impegno sistemico sarà possibile creare un sistema educativo inclusivo, capace di offrire a tutti gli studenti le competenze necessarie per vivere e lavorare in un mondo sempre più interconnesso.
L’era onlife rappresenta una sfida ma anche un’opportunità per il settore educativo. Le strategie educative devono evolversi per rispondere alle esigenze di un mondo in rapida trasformazione, promuovendo un’educazione che non solo fornisca competenze tecniche, ma che sviluppi anche una consapevolezza critica e una comprensione profonda delle implicazioni sociali, etiche e culturali della tecnologia. Solo così sarà possibile preparare le nuove generazioni a vivere in un mondo in cui il confine tra reale e virtuale è sempre più sottile, e in cui la capacità di navigare con successo tra questi due mondi diventa essenziale.
Bibliografia
Anderson C. (2010), La coda lunga. Da un mercato di massa a una massa di mercati, Torino, Codice Edizioni. https://www.codiceedizioni.it/libri/la-coda-lunga-edizione-2010/
Anderson T. e Dron J. (2011), Three generations of distance education pedagogy, «The International Review of Research in Open and Distributed Learning», vol. 12 n. 3, pp. 80-97.
Arnold K.E. e Pistilli, M.D. (2012), Course signals at Purdue: Using learning analytics to increase student success. In S. Buckingham Shum, D. Gasevic e R. Ferguson (a cura di), LAK ‘12: Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge, New York, NY, Association for Computing Machinery.
Baker R.S. e Yacef K. (2009), The state of educational data mining in 2009: A review and future visions, «Journal of Educational Data Mining», vol. 1, n. 1, pp. 3-17.
Buckingham D. (2006), Media education. Alfabetizzazione, apprendimento, e cultura contemporanea, Trento, Erickson.
Calvani A., Fini A. e Ranieri, M. (2010), La competenza digitale nella scuola. Modelli e strumenti per valutarla e svilupparla, Trento, Erickson.
Castells M. (2014), La nascita della società in rete, Milano, EGEA.
Dede C. (2009), Immersive interfaces for engagement and learning, «Science», vol. 323, n. 5910, pp. 66-69.
Dede C. (2010), Comparing frameworks for 21st century skills. In J. Bellance e R. Brandt (a cura di), 21st century skills: Rethinking how students learn, Bloomington, IN, Solution Tree Press, pp. 51-76.
Eubanks V. (2018), Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor, New York, NY, St. Martin’s Press.
Facione P.A. (2015), Critical thinking: What it is and why it counts, Millbrae, CA, The California Academic Press.
Ferrari A. (2012), Digital competence in practice: An analysis of frameworks, Lussemburgo, Publications Office of the European Union.
Ferrari A. (2013), DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital competence in Europe, Lussemburgo, Publications Office of the European Union.
Floridi L. (2020), La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Freire P. (2002). La pedagogia degli oppressi, Torino, EGA Editore.
Hersh M.A., Johnson M.A. (2008), Assistive technology for visually impaired and blind people, London, Springer.
Hmelo-Silver C.E. (2004), Problem-based learning: What and how do students learn?, «Educational Psychology Review», vol. 16 n.3, pp. 235-266.
Hollands F.M. e Tirthali D. (2014), MOOCs: Expectations and reality. Full report, New York, NY, Center for Benefit-Cost Studies of Education, Teachers College, Columbia University.
Holmes W., Bialik M. e Fadel C. (2019), Artificial Intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning, Boston, MA, Center for Curriculum Redesign.
Huang R., Spector J. M. e Yang J. (2019), Educational technology: A primer for the 21st century, Singapore, Springer.
Istat (2021), Rapporto Annuale 2021. La situazione del Paese, Roma, Istat.
Jewitt C. (2008), Multimodality and literacy in school classrooms, «Review of Research in Education», vol. 32, n. 1, pp. 241-267.
Jonassen D.H. (2011), Learning to solve problems: A handbook for designing problem-solving learning environments, New York, Routledge.
Kapp K.M. (2012), The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education, San Francisco, Pfeiffer.
Koedinger K.R., Anderson J.R., Hadley W.H. e Mark M.A. (1997), Intelligent tutoring goes to school in the big city, «International Journal of Artificial Intelligence in Education», vol. 8, pp. 30-43.
Lankshear C. e Knobel M. (2008), Digital literacies: Concepts, policies and practices, New York, NY, Peter Lang.
Luckin R., Holmes W., Griffiths M. e Forcier L. B. (2016), Intelligence unleashed: An argument for AI in education, London, Pearson Education.
Mangione G.R.J., De Santis F. e Garzia M. (2023), Le tecnologie per una scuola di comunità aperta e inclusiva, «I Quaderni della Ricerca», vol. 72, Torino, Loescher Editore.
Miao F., Holmes W., Huang R. e Zhang H. (2021), AI and education: Guidance for policy-makers. Parigi, UNESCO Publishing.
Mishra P. e Koehler M. J. (2006), Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge, «Teachers College Record», vol. 108, n. 6, pp. 1017-1054.
Muñoz-Organero M., Muñoz-Merino P. J. e Delgado Kloos C. (2010), Student behavior and interaction patterns with an LMS as motivation predictors in E-Learning settings, «Education, IEEE Transactions», vol. 53, n. 3, pp. 463-470.
OECD (2018), Teaching for the future: Effective classroom practices to transform education, Parigi, OECD Publishing.
OECD (2024), Reimagining education, realising potential, Parigi, OECD Publishing.
Okolo C.M., Diedrich J. (2014), Twenty-five years later: How is technology used in the education of students with disabilities? Results of a statewide study, «Journal of Special Education Technology», vol. 29 n. 1, pp. 1-20.
Prensky M. (2001), Digital natives, digital immigrants, «On the Horizon», vol. 9 n. 5.
Przybylski A.K. e Weinstein N. (2019), Digital screen time limits and young children’s psychological well-being: Evidence from a population-based study, «Child Development», vol. 90 n. 1, pp. e56-e65.
Redecker C., Ala-Mutka K., Bacigalupo M., Ferrari A. e Punie Y. (2009), Learning 2.0: The impact of web 2.0 innovations on education and training in Europe, Lussemburgo, Publications Office of the European Union.
Rheingold H. (2012), Net smart: How to thrive online, Cambridge, MIT Press.
Ribble M. (2015), Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know, Arlington, VA, International Society for Technology in Education.
Rivoltella P.C. (2020), Nuovi alfabeti. Educazione e culture nella società post-mediale, Brescia, Editrice Morcelliana.
Runco, M.A. e Acar S. (2012), Divergent thinking as an indicator of creative potential, «Creativity Research Journal», vol. 24, n. 1, pp. 66-75.
Sancassani S. (2019), Insegnare nel XXI secolo. Progettare l’innovazione didattica, Milano, Pearson.
Selwyn, N. (2014), Digital technology and the contemporary university: Degrees of digitization, Londra, Routledge.
Selwyn N. (2016a), Education and technology: Key issues and debates, London, Bloomsbury Academic.
Selwyn N. (2016b), Is technology good for education?, Cambridge, Polity Press.
Shute V.J. e Ventura M. (2013), Stealth Assessment: Measuring and supporting learning in video games, Cambridge: MIT Press.
Siemens G. (2013), Learning analytics: The emergence of a discipline, «American Behavioral Scientist», vol. 57, n. 10, pp. 1380-1400.
Turkle S. (2016), La conversazione necessaria. La forza del dialogo nell’era digitale, Torino, Einaudi.
Twenge J.M. (2017), iGen: Why today’s super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy — and completely unprepared for adulthood — and what that means for the rest of us, New York, NY, Atria Books.
VanLehn K. (2011), The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems, «Educational Psychologist», vol. 46 n.4, pp. 197-221.
Voogt J. e Roblin N.P. (2012), A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies, «Journal of Curriculum Studies», vol. 44, n. 3, pp. 299-321.
Vrasidas C. e Glass G.V. (2007), Teacher professional development and ICT: Strategies and models, «Yearbook of the National Society for the Study of Education», vol. 106, n. 2, pp. 87-102.
Williamson B. (2017), Big data in education: The digital future of learning, policy and practice, Londra, Sage.
Wing J.M. (2006), Computational thinking, «Communications of the ACM», vol. 49, n. 3, pp. 33-35.
Woolf B.P. (2010), Building intelligent interactive tutors: Student-centered strategies for revolutionizing E-Learning, Burlington, MA, Morgan Kaufmann.
Dede C. (2010), Comparing frameworks for 21st century skills. In J. Bellance e R. Brandt (a cura di), 21st century skills: Rethinking how students learn, Bloomington, IN, Solution Tree Press, pp. 51-76.
-
1 Dott.ssa in Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi di Padova.
-
2 Dott.ssa in Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi di Padova.
-
3 I Massive Open Online Courses (MOOC) sono corsi online aperti a un vasto pubblico, accessibili via Internet, spesso gratuiti o a basso costo. Sono progettati per consentire a chiunque, ovunque si trovi, di partecipare senza limiti di numero di iscritti. I MOOC sono strutturati in lezioni video, letture e valutazioni interattive, e sono spesso offerti da università e istituzioni educative di prestigio.
-
4 La realtà virtuale (VR) è una tecnologia che immerge completamente l’utente in un ambiente digitale simulato. Indossando un visore VR, l’utente può esplorare e interagire con un mondo completamente virtuale e creato al computer. La realtà aumentata (AR), invece, sovrappone elementi digitali al mondo reale. Utilizzando uno smartphone, un tablet o occhiali AR, l’utente può vedere oggetti virtuali, informazioni o immagini proiettate nel proprio ambiente reale. La AR non sostituisce il mondo reale come la VR, ma lo «aumenta» aggiungendo livelli di informazione digitale.
-
5 Un blog è un sito web o una sezione di un sito web dove vengono pubblicati contenuti scritti (post o articoli) su una vasta gamma di argomenti. Questi post possono includere testo, immagini, link ad altre risorse e talvolta commenti dei lettori.
-
6 Un vlog (abbreviazione di «video blog») è una forma di blog che utilizza principalmente contenuti video invece di testi scritti. I vlogger (le persone che creano vlog) parlano direttamente alla telecamera, raccontando storie, offrendo recensioni, tutorial o semplicemente condividendo momenti della loro vita quotidiana.
-
7 Il timelapse è una tecnica di ripresa video in cui le immagini vengono catturate a intervalli di tempo regolari. Quando queste immagini vengono riprodotte a velocità normale, il tempo sembra scorrere molto più rapidamente, creando un effetto accelerato. Questa tecnica è spesso utilizzata per mostrare processi lenti come il movimento delle nuvole, il tramonto, o la crescita delle piante in un breve periodo di tempo.
-
8 La gamification in ambito scolastico si riferisce all’applicazione di elementi tipici del design dei giochi, come sistemi di punteggio, classifiche, badge e sfide, per migliorare il coinvolgimento, la motivazione e i risultati degli studenti. Integrando questi elementi nelle lezioni e nelle attività didattiche, gli insegnanti possono creare un ambiente di apprendimento più interattivo e piacevole. L’obiettivo è rendere l’apprendimento simile a un gioco, in cui gli studenti sono motivati a raggiungere obiettivi, guadagnare ricompense e progredire attraverso diversi livelli. Questo approccio può rendere le materie difficili più accessibili e aiutare gli studenti a sviluppare un senso di realizzazione man mano che avanzano nel loro percorso di apprendimento.
-
9 I badge sono simboli o icone che vengono assegnati agli studenti per il raggiungimento di determinati obiettivi o competenze. Ad esempio, uno studente potrebbe ricevere un badge per aver completato con successo un compito particolarmente difficile o per aver raggiunto un certo livello di competenza in una materia. I badge servono come ricompense visive che gli studenti possono collezionare, aumentando la loro motivazione e il senso di realizzazione.
-
10 I Bee-Bot sono piccoli robot educativi progettati per insegnare ai bambini concetti base di programmazione, matematica e logica. Hanno la forma di un’ape e possono essere programmati per muoversi in diverse direzioni tramite semplici comandi. Sono spesso utilizzati in contesti scolastici per introdurre i più piccoli al coding in modo divertente e interattivo.
-
11 I big data sono enormi quantità di dati che vengono raccolti da varie fonti, come internet, dispositivi elettronici o sensori, e che sono così grandi e complessi da richiedere strumenti avanzati per essere analizzati e utilizzati. Questi dati possono essere sfruttati per scoprire tendenze, fare previsioni e prendere decisioni più informate.
-
12 La retention scolastica si riferisce alla capacità di un’istituzione educativa di mantenere i propri studenti all’interno del sistema scolastico fino al completamento del percorso di studi. In altre parole, è una misura della percentuale di studenti che continuano a frequentare la scuola fino alla conclusione dei loro studi, senza abbandonare o ritirarsi prematuramente.
-
13 Il machine learning è una tecnologia che permette ai computer di imparare dai dati e migliorare le loro prestazioni senza essere programmati direttamente. In pratica, il computer analizza esempi passati e, grazie a questi, impara a fare previsioni o prendere decisioni autonomamente.
-
14 L’elaborazione del linguaggio naturale è una tecnologia che permette ai computer di comprendere e interagire con il linguaggio umano. In pratica, consente ai computer di interpretare, analizzare e rispondere a testi e discorsi, come facciamo noi quando parliamo o leggiamo.
-
15 Il sistema di tutoraggio intelligente Knewton è una piattaforma educativa basata sull’intelligenza artificiale progettata per personalizzare l’apprendimento degli studenti. Sviluppato originariamente negli Stati Uniti, Knewton utilizza algoritmi per analizzare il comportamento e le risposte degli studenti in tempo reale, adattando il contenuto e il livello di difficoltà delle lezioni in base alle esigenze individuali. Questo approccio mira a ottimizzare il processo di apprendimento, fornendo a ciascun studente un percorso didattico su misura.
-
16 Il progetto europeo AI4Teachers (o AI4T) è un’iniziativa lanciata nel 2021 con l’obiettivo di supportare e formare gli insegnanti nell’uso dell’intelligenza artificiale (AI) nell’educazione secondaria. Fa parte del programma Erasmus+ e mira a integrare l’AI nel contesto scolastico, sia per migliorare l’insegnamento sia per preparare meglio gli studenti alle sfide future legate a questa tecnologia. L’obiettivo principale del progetto è quello di fornire strumenti e conoscenze agli insegnanti, affinché possano comprendere e utilizzare l’AI nelle loro pratiche didattiche quotidiane. Il progetto ha anche una forte componente di ricerca e collaborazione tra diversi paesi europei, per assicurare che le competenze digitali degli insegnanti siano aggiornate e in linea con le esigenze della società contemporanea. https://www.ai4t.eu (consultato il 29 ottobre 2025).
Vol. 2, Issue 2, October 2025