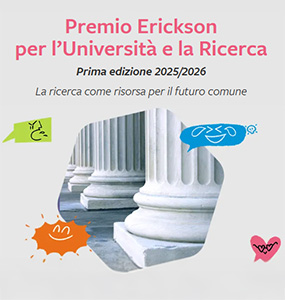Vol. 2, n. 2, ottobre 2025
Tra traiettorie bioeducative e transizioni tecnologiche
Ricerche interdisciplinari per una contaminazione eco-logica
Katiuscia Vitagliano1
Sommario
Nel panorama di una pedagogia elettrica (D’Ambrosio, 2016) l’esperienza, in tutte le sue forme, agisce direttamente e indirettamente sulla formazione umana, ovvero tutto educa indipendentemente dalla correttezza del contenuto. Il paradigma onlife conferma che le vite umane sono sempre più intrecciate con il non reale (Han, 2022), al tal punto da vivere un contesto ibrido nel quale la vita reale è assorbita pienamente dalla vita digitale, a discapito dell’identità personale e delle relazioni umane. Oggi si vive per raccontare, o si racconta per vivere? Nello Stato digitale (Torchia, 2023) aumenta il rischio di distorsione e manipolazione delle informazioni veicolate. La nuova sfida educativa è proprio quella di accompagnare la comunità verso lo sviluppo del senso critico, non per demonizzare una potenziale risorsa, ma per riconoscere il confine tra virtuale e reale in un’ottica di fruizione consapevole. Già negli anni Novanta, con l’opera Cattiva maestra televisione (Popper, 1994), si denunciavano le complicazioni della sovraesposizione dei bambini ai programmi televisivi e dopo trenta anni risulta ancora attuale, benché si sia moltiplicata la varietà dei dispositivi maneggiati fin dalle più tenere età. Facendo eco a Popper, una grande risorsa per ritrovare il senso del reale potrebbe essere la Buona maestra natura, se integrata in percorsi formativi progettati con l’obiettivo di produrre esperienze di qualità (Dewey, 2014) che plasmino positivamente la struttura del cervello incarnato (Siegel, 2021). Di grande riferimento sono gli studi sulle metodologie embodied,2 dall’ampio respiro disciplinare, che legittimano il corpo come dispositivo recettivo, nelle pratiche educative.
Parole chiave
Esperienza, corpo, natura, neuroscienze, tecnologia.
Between bioeducational trajectories and technological transition
Interdisciplinary research for eco-logical contamination
Katiuscia Vitagliano3
Abstract
In the panorama of an electric pedagogy (D’Ambrosio, 2016) experience, in all its forms, acts directly and indirectly on human education, that is everything educates, regardless of the correctness of the content. The onlife paradigm confirms that human lives are increasingly intertwined with the non-real (Han, 2022), to the point of experiencing a hybrid context in which real life is fully absorbed by digital life, to the detriment of personal identity and human relationships. Today do we live to tell, or do we tell to live? In the digital state (Torchia, 2023) the risk of distortion and manipulation of the information conveyed increases. The new educational challenge is precisely that of accompanying the community towards the development of a critical sense, not to demonize a potential resource, but to recognize the boundary between virtual and real with a view to conscious use. Already in the Nineties years, with the work Bad Teacher Television (Popper, 1994), the complications of children’s overexposure to television programs were denounced and after thirty years it is still relevant, although the variety of devices handled by the youngest children has multiplied. Echoing Popper, a great resource for rediscovering the sense of reality could be Good Teacher Nature, if integrated into training courses designed with the aim of producing quality experiences (Dewey, 2014) that positively shape the structure of the embodied brain (Siegel, 2021). Of great reference are the studies on embodied methodologies,4 with a broad disciplinary scope, which legitimize the body as a receptive device in educational practices.
Keywords
Experience, body, nature, neuroscience, technology.
Introduzione
La necessità di fare ricerca per esplorare le dinamiche sociali alla luce del paradigma elettrico5 ha lo scopo di riconoscere il potenziale offerto dalle nuove tecnologie sostenendo, tuttavia, il bisogno di rinnovate strategie educative per una digital literacy (Scarcelli e Stella, 2017), ovvero un’alfabetizzazione digitale, consapevole. Accompagnare all’utilizzo vuol dire educare alla fruizione delle risorse con consapevolezza e criticità per ridurre la perdita di equilibrio tra vita reale e vita digitale e ciò presuppone una certa maturità nel soggetto che entra in contatto con il dispositivo e le sue potenzialità. La varietà del bacino d’utenza della rete consente di poter ipotizzare una rieducazione all’uso del digitale in senso più ampio, che indaghi trasversalmente anche la capacità a relazionarsi con l’altro. Il fenomeno della dipendenza dal virtuale sembra essere l’esito di una società iperconnessa che, paradossalmente, rende i propri individui sempre più isolati. L’esperienza rincorre l’urgenza della sua condivisione online, la percezione personale è barattata con emoticon e commenti, una visualizzazione mancata o il malfunzionamento del dispositivo digitale sembrano essere elementi sufficienti a scatenare reazioni di rabbia e malumore. Ecco come l’esperienza online impatta sulla vita reale generando un nuovo scenario, un effetto collaterale di un progresso digitale mal gestito. Onlife è il neologismo coniato da Floridi nel suo Manifesto (Floridi, 2015) per descrivere la scomparsa del confine tra online e life, tra virtuale e reale, digitale e analogico per una riflessione del rapporto tra le intelligenze artificiali e le democrazie. Persuasione e consenso sono aspetti che attraverso la manipolazione dell’infosfera6 (Floridi, 2017) orientano le scelte di vita di coloro che pensano di essere liberi. L’emergenza educativa rispetto al paradigma dell’onlife e della necessità di una pedagogia democratica richiama ulteriori tematiche in termini di disuguaglianze e nuove opportunità, dalle quali il mondo dell’educazione non può sottrarsi; alcune tra queste: il divario generazionale, economico e sociale, ma anche la necessità di ripensare le pratiche educative. Le dinamiche all’interno di uno Stato che digitalizza l’accesso ai suoi servizi trascinano tutti i cittadini verso l’utilizzo delle piattaforme, amplificando le distanze tra Apocalittici, Integrati (Eco, 1964) e Nativi digitali. Nessuno è immune al digitale. Chi vive privo di connessione sperimenta un mondo altro, quello dell’offlife, nel senso che chi è privo di accesso alla rete delle informazioni è tagliato automaticamente fuori da una sfera sociale che ha compiuto la sua migrazione in internet. Come può sopravvivere una società divisa in due? Quale buon compromesso potrebbe essere messo in atto? Sarebbe saggio investire esclusivamente in processi di alfabetizzazione digitale? L’educazione che ruolo ha rispetto all’innovazione tecnologica?
Traiettorie di ricerca tra scienze umane e innovazioni tecnologiche
Per raggiungere l’equilibrio bisogna ripensare le prassi per risvegliare l’essere umano, o meglio l’umanità dell’essere, per tracciare nuove traiettorie che tengano conto sia dell’attaccamento con la realtà che della tecnologia e delle sue sfumature d’applicazione: dallo svago all’esigenza. L’integrazione tra scienze umane e tecnologie per lo sviluppo di conoscenze innovative può essere considerata come possibile approccio proporzionato a una realtà in continua trasformazione. Agire secondo una duplice direzione intrecciando la necessità di mantenere il contatto con il reale e accogliere l’innovazione tecnologica nella sua effettiva utilità. In termini bioeducativi bisogna agire recuperando quella dimensione sensoriale del fare e del sentire repressa negli ultimi anni, in particolare a causa della recente Pandemia7 che ha limitato i corpi in confini poveri di incontro umano. Le metodologie embodied, che mettono in relazione arte, scienza, digitale e nuova robotica, privilegiando proprio quell’insieme corpo-cervello come dispositivo attivo, si configurano come canale di comunicazione con il sé e con il mondo circostante. Su tali premesse, la ricerca pedagogica deve interrogarsi sui possibili vantaggi di una risposta saggiamente bilanciata, che possa potenziare i valori umani e l’innovazione digitale per una contaminazione eco-logica dei saperi. Il contributo non esprime contrarietà verso i dispositivi digitali e la rete, ma ne indaga l’impatto sulla percezione umana e la ricaduta in termini di capacità relazionali. Già nel 1994, il filosofo austriaco Karl Popper fornì prova di quanto i mass media riuscissero a esercitare influenza sul pubblico denunciando i danni provocati da un’eccessiva esposizione dei bambini ai programmi televisivi. Attuale e lungimirante, propose una sorta di patente per l’uso della televisione. Necessità che si ripresenta con la diffusione dei dispositivi mobili, peraltro dotati di connessione internet spesso senza limitazioni d’uso e opportuno controllo. Il compito di chi opera in nome delle scienze pedagogiche è anche quello di rendere noti gli effetti di un’esposizione scorretta e prolungata ai contenuti digitali. Se trenta anni fa l’emergenza educativa era percepita rispetto al bambino in quanto tale, attualmente la minaccia si è estesa a un pubblico più vasto, per cui anche l’adulto si aliena rendendosi indisponibile emotivamente. Gli smartphone sono degni eredi della televisione, con la differenza di poter essere trasportati e utilizzati praticamente in ogni ambiente possibile. L’intimità della vita è oscurata dal dispositivo come un’ombra costante. Mentre la realtà aumenta progressivamente la sua complessità apparendo offuscata e qualche volta dolorosa, ci si rifugia in dimensioni digitali per anestetizzare la sofferenza e l’incertezza (Han, 2021). Si occupa il tempo riempiendolo con qualsiasi intrattenimento pur di evitare il contatto con la realtà. L’utilità delle connessioni perde valore in una società che non ne riesce a trarne il massimo vantaggio, ma resta intrappolato nella rete. Sufficiente pensare a un tipico pranzo in famiglia durante il quale ognuno rivolge gli occhi verso il proprio schermo. Come si costruisce una relazione se non si riesce a dedicare la giusta attenzione alle persone che si hanno intorno? Non si può negare il valore di un mezzo che consente di ridurre le distanze, facilitare in alcuni particolari casi la comunicazione, accedere a community con interessi condivisi, avere il sapere a portata di click, strutturare interventi educativi e didattici inclusivi per gli studenti con bisogni educativi speciali attraverso l’ausilio digitale.8 D’altro canto, la questione del confine tra i due mondi è ridondante. Saper riconoscere l’adeguatezza dei momenti e ritornare al mondo reale è una competenza necessaria. Occorre educare la criticità dello spirito e l’uso del virtuale affinché si possa sviluppare anche la capacità di filtraggio delle informazioni diffuse riducendo l’effetto delle ondate emotive causate dal terrorismo mediatico, dall’emergere di visioni distorte della realtà e dalla percezione dell’obbligo di creare situazioni da raccontare, piuttosto che vivere esperienze da, eventualmente, raccontare. Non sono rari fenomeni di eco-ansia legati all’eccessivo bombardamento di notizie relative all’emergenza climatica e al destino dell’uomo sul pianeta Terra. Conoscere gli strumenti digitali e il funzionamento della mente è una strategia che gli addetti ai lavori9 devono allenare per poter comprendere la motivazione di determinate scelte comportamentali. Educare alla navigazione della rete è importante anche per prevenire l’insorgere di psicopatologie legate alla distorsione dell’immagine del sé, disturbi del comportamento alimentare, ansia sociale, dismorfofobia dettate dal costante confronto con modelli irreali proposti dalla rete e per il contrasto di fenomeni con il cyberbullismo o crimini come la pedopornografia e l’adescamento di minori. L’incidenza dei flussi di informazione e la povertà di strumenti interpretativi possono avere una grande influenza sulla sicurezza personale e sulla costruzione della personalità, soprattutto in fasi cruciali come l’adolescenza. Si crea così un vuoto tra l’identità raccontata creata ad hoc e quella effettiva che si sgretola progressivamente. La formazione della persona è un processo che dura per tutta la vita, ma l’adolescenza rappresenta il periodo più critico e decisivo data la sua varietà di cambiamenti cognitivi, sociali e biologici affrontati in un periodo relativamente breve. Proprio in questo processo l’ambiente ricopre un ruolo fondamentale. Secondo Floridi, l’habitat del paradigma onlife è internet. Sulla base di tale premessa occorre ricordare quale sia l’habitat originario dell’uomo, restituendo a esso la sua natura umana e relazionale attraverso un sentire autentico. Solo recuperando il senso dell’umano si potrà arrivare all’equilibrio tra le due vite del paradigma onlife ripristinando quel confine invalicabile (Floridi, 2015). Attualmente ogni singolo individuo corrisponde a un grande numero di informazioni descrivibili attraverso dati, che per loro natura possono essere registrati, controllati, catalogati, confrontati e manipolati. La ricerca educativa può far luce sulle modalità che possono orientare, soprattutto le future generazioni, alla riflessione critica necessaria per un’azione ragionata e consapevole.
Sguardi pedagogici sulle dinamiche onlife e offlife
La rapidità di un mondo altamente globalizzato (McLuhan, 1996) e la complessità (Morin, 2017) che caratterizza la società odierna generano un flusso consistente di informazioni che viene costantemente alimentato, smentito, distorto. Problematizzare l’impatto del virtuale sul reale per valutarne rischi e benefici apre una finestra di riflessione che lascia entrare luce rendendo indispensabile considerare molteplici aspetti. Rievocare l’umanità dell’essere piuttosto che il semplice essere umano diventa necessario per contrastare gli effetti dell’annullamento totale del confine onlife. Affermare che tutto educa indipendentemente dalla correttezza del contenuto equivale a riconoscere la presenza di un educatore terzo, ovvero il dispositivo digitale. Se il dispositivo trova spazio nella sfera educativa personale c’è da chiedersi quale posizione occupino le reali agenzie educative, riconoscendo l’errore di un sistema che delega l’educazione al digitale. L’esposizione al dispositivo è un evento precoce, già dai primi mesi di vita si registra la proposta di contenuti animati, successivamente impiegati come mezzo di controllo e ricatto rispetto all’irruenza comportamentale del bambino, quasi a voler reprimere la sua natura giocosa. Il primo sintomo del danno è il rovescio del ricatto, ovvero il momento in cui il bambino comprende di avere potere di negoziazione e rinforza il suo comportamento negativo per poter ottenere il dispositivo anche quando il genitore è contrario. Oltre alla solida convinzione di poter ottenere ciò che si desidera, si è innescato un processo di svalorizzazione dell’autorevolezza genitoriale. Il nativo digitale, forte del suo potere, chiederà presto un dispositivo tutto per sé e il genitore, stanco di dover condividere, cederà. Uno sguardo su questa dinamica descritta è necessario per comprendere come sia diventato socialmente accettabile e frequente l’utilizzo precoce del digitale. Il grave fattore che emerge rende noto che l’uso del dispositivo preceda l’educazione all’uso della ragione e del discernimento tra giusto e sbagliato, sicuro e pericoloso, reale e immaginario. Crescere con una protesi del sé, con quel prolungamento della propria mano e del proprio pensiero autonomo, comporta la perdita di possibilità di scoperta e maturazione. Se l’orizzonte limite è rappresentato da uno schermo portatile e la quantità dei legami affettivi corrisponde al numero di seguaci, non solo si riducono notevolmente le capacità ad apprendere, ma cala drasticamente la qualità della presenza umana. Nel vortice delle informazioni, spesso corredate da immagini forti e scene non adatte a un pubblico la cui personalità è ancora acerba, si innesca un meccanismo di abituazione al dolore, che produce una normalizzazione della violenza e il richiamo verso il fascino del male in alcuni e un terrorismo psicologico che descrive il mondo e l’altro da sé come una fonte di pericolo in altri. In una realtà estremamente amplificata anche le abitudini, i consumi e i comportamenti finisco per essere ispirati da modelli veicolati virtualmente che prevalgono sull’identità individuale. Le piattaforme si pongono come vetrine nelle quali ognuno decide cosa mettere in mostra, scartando ciò che non fa tendenza. Nonostante ciò, sembra essere ancora vivo il bisogno di raccontarsi, ma ancora una volta si delega alla condivisione di contenuti di breve durata accompagnati da passaggi di tracce musicali. Risulta più semplice condividere, perdendo l’intimità del dolore, piuttosto che cercare l’abbraccio di un amico. La quotidianità del gesto risulta essere più spontanea della ricerca di contatto con l’altro, reprimendo ciclicamente l’espressione dei sentimenti e la capacità di mettersi in ascolto con sé stessi e con il mondo circostante. La necessità di essere visti da un vasto pubblico sottolinea la solitudine extra-digitale, la fragilità di un’autostima mai allenata al vero. Controllare caselle di posta elettronica, trasmettere in tempo reale e visualizzare le notifiche dei social network è un impegno fisso, inderogabile, giornaliero, purtroppo praticato senza sosta né coscienza; ad esempio, durante la guida dell’automobile. Esprimere considerazioni, anche poco piacevoli, verso gli utenti è considerato pieno diritto del navigante che con un semplice tocco ferisce, discrimina, minaccia, per poi tornare alla propria vita senza avvertire il peso delle sue responsabilità e il duplice danno: l’affievolirsi della sensibilità umana da un lato, l’offesa tagliente ricevuta dall’altro. Tutto a riprova del fatto che l’attività portata avanti nella vita online ha un riscontro tragicamente concreto nella vita reale. L’individuo cresciuto con la privazione dell’esposizione al bello e delle pratiche di cura ha il potere di trasformare ogni risorsa in orrore, sprecando l’occasione di beneficiare della grandiosità delle innovazioni. Con lungimiranza assoluta, già due decenni orsono, il filosofo ed economista francese Serge Latouche propose una pratica10 del rifiuto dell’eccesso in risposta a un aumento vertiginoso della disponibilità di beni e servizi e un’irrazionalità nel potere d’acquisto mosso spesso da un superficiale desiderio di apparire e possedere, piuttosto che dal reale bisogno di accesso al bene/servizio. La teoria di stampo economico-sociale può essere direttamente applicabile a un sistema di valori educativi che deve essere necessariamente ripensato affinché possa rispondere e contrastare le crescenti fragilità umane. Latouche si fa portavoce del bisogno di riscoprire la centralità umana per invertire la rotta, orientandola, verso una nuova concezione di benessere delle relazioni, fondata su una discontinuità radicale dalle frenetiche logiche dominanti nel mondo post-moderno, auspicando a una felicità sociale che si erge sulla piena realizzazione del bene comune, in relazione anche alla natura e all’economia sostenibile. In una società in cui tutto diventa merce anche le relazioni perdono solidità, la libertà viene barattata, l’informazione è amplificata e l’emotività necessariamente repressa in favore di un’ottica di infallibilità a cui non è possibile venir meno. Ciò che non trova cura si evolve in crisi e lo dimostra l’illuminante lavoro intellettuale di Zygmunt Bauman, che attraverso le sue opere del secondo Novecento, ha sollevato importanti riflessioni rispetto a una vita precaria caratterizzata dalla liquidità dei legami e dall’alta probabilità di alienazione. Il filosofo e sociologo polacco, destabilizza il pianeta con il concetto di liquidità, riferendosi a una vita in cui tutto è mutevole e prioritaria è la velocità degli avvenimenti piuttosto che la loro effettiva durata. Complici della crescente liquidità sono la recente emergenza sanitaria e l’esplosione dei processi mediatici e di informatizzazione. In tale scenario occorre ritrovare il contatto con il reale ed il concreto, per utilizzare l’espressione del filosofo sudcoreano contemporaneo Byung-chul Han, auspicando a una nuova educazione alla libertà declinata in tutte le sue forme, una libertà che, come ricorda la pedagogista italiana Maria Montessori, trova le sue buone radici, promosse in famiglia e poi dalla scuola, fin dalla prima infanzia. Nel pensiero montessoriano sulla capacità di apprendimento nella prima infanzia emerge il concetto di mente assorbente come inconsapevole processo di rielaborazione degli stimoli sensoriali. Rispetto all’interazione umana con l’ambiente in cui avviene l’apprendimento vi è una rivoluzione degli spazi e degli arredi che sono costruiti a misura di bambino predisponendo uno scenario favorevole e ricco di stimoli per aumentare la qualità dell’esperienza educativa vissuta in una totale spontaneità e coscienza del proprio schema senso-motorio. L’educazione autentica è quella che si adatta alle necessità del bambino e che si realizza progressivamente nella misura in cui la fase di sviluppo cognitivo è pronta a accogliere, in altri termini nella misura in cui la mente è pronta ad assorbire in un dato momento. Per un focus sulla relazione uomo-società si ricorre a Merleau-Ponty che afferma: «Dopo il mondo naturale, dobbiamo quindi riscoprire il mondo sociale, non come oggetto somma di oggetti, ma come campo permanente o dimensione di esistenza. La nostra relazione con il sociale è più profonda di ogni percezione espressa o di ogni giudizio. Dobbiamo ritornare al sociale, con il quale siamo in contatto solo per il fatto di esistere e che portiamo aderente a noi prima di ogni oggettivazione» (Cavagna, 2022, p. 147).
Ripensare l’insegnamento per allenare lo spirito critico
Le agenzie educative, chiamate a rispondere alle nuove necessità formative della società elettrica, possono attingere a nuovi modi di strutturare i contenuti attraverso il dialogo tra le scienze umane e l’innovazione tecnologica per un approccio integrato applicabile alla didattica viva, basata sull’esperienza del fare e del sentire. Ripartire dal contesto scolastico per orientare le nuove generazioni ricercando metodologie educative che possano rendere più efficace l’apprendimento migliorando anche la permanenza a scuola e agendo indirettamente su fenomeni sociali come la dispersione scolastica11 e la devianza minorile, incrementando il numero di studenti che riescono a conseguire un titolo di studio e a incanalarsi verso un settore professionale gratificante. Le possibilità digitali offerte dalle nuove transizioni tecnologiche risultano essere una risorsa didattica che non si sostituisce all’esperienza diretta, ma che ne consente un’estensione aumentata, documentabile e condivisibile rendendo possibile una continuazione dello studio sul campo anche successivamente la rilevazione come prolungamento dell’esperienza (un esempio possono essere le attività svolte all’aperto, in natura). Con Dewey si iniziò a pensare la scuola come una comunità di pratica educante centrata sull’esperienza capace di orientare il rapporto educativo, di organizzare la comunità della scuola nei suoi spazi e tempi e di rendere efficace la didattica e all’esperienza educativa come esperienza di qualità (Dewey, 1938). L’apertura dell’ambiente scolastico verso altre possibilità è rintracciabile attraverso il filone pedagogico del Novecento con Don Milani che rese la scuola una palestra di vita aperta a tutti senza distinzioni, con Montessori e la sua scuola a misura di bambino, McLuhan che propose un’aula senza muri e nei più recenti modelli di asilo nel bosco (sarebbe opportuna una riflessione sull’eccessiva cementificazione delle città che non lascia spazio a simili progettualità) e scuola senza zaino. Modelli di successo come quelli del secolo scorso dimostrano che l’evoluzione dell’ambiente di apprendimento è funzionale all’apprendimento stesso. Attraverso gli studi di Massa e il testo Cambiare la scuola (Massa, 2000) si pone attenzione verso il setting scolastico completamente privato di qualsiasi personalizzazione a discapito dell’educazione intesa come dispositivo che necessita di spazio vivo, in quanto prevale la sola disposizione di banchi e sedie rendendo gli spazi dell’esperienza tutti uguali e rigidamente organizzati. Ci si ritrova in contesti preconfezionati, allestiti per un unico destino che prevede lo studente privato della sua mobilità e confinato nel suo posto assegnato. Allo stesso modo, gli argomenti oggetto di studio vengono ampiamente filtrati e rielaborati così da essere pronti da somministrare agli studenti privandoli della scoperta progressiva e logicamente organizzata dei contenuti, che oltre ad essere frammentati in numerose discipline, finiscono per diventare un cumulo di informazioni percepite come molto lontane dal mondo reale. Occorre, allora, strutturare un’educazione che sia viva, pratica e che custodisca il senso più ampio dei processi formativi: quello di preparare e formare alla vita. Si avverte la necessità di ripensare la didattica ripartendo da un setting scolastico che possa suscitare il desiderio di apprendere attraverso quel processo socratico che sostiene che il sapere non si trasmette, ma richiede un processo di ricerca e scoperta. Indispensabile tener conto della forte relazione tra ambiente, mente-corpo e apprendimento. Lo sviluppo dei nativi digitali è molto più rapido degli studenti di venti anni fa (Lucangeli, 2019), tuttavia la discrepanza tra cambiamento sociale ed evoluzione delle istituzioni può produrre malessere nella popolazione scolastica. Il dialogo tra pedagogia e biologia sostiene che la portata delle stimolazioni può, a lungo termine, influire sull’espressione del genoma alterando la biologia umana e di conseguenza anche la potenzialità dell’apprendimento (Frauenfelder e Santoianni, 1994; 2002). In questa cornice epistemologica, in cui sono centrali le neuroscienze, si collocano anche gli studi di Rivoltella e il nuovo modello neuro-didattico EAS, Didattica per Episodi di Apprendimento Situato, che vede nell’insegnamento un processo non lineare, ripensato e riprogettato e fa eco al rispetto dei tempi d’apprendimento attraverso una metodologia inclusiva. Per un connubio tra le aree tematiche percorse e il recupero di una tattilità del fare e del sentire si fa riferimento alle pratiche dell’embodied education, privilegiando la dimensione cinetica dei corpi attraverso pratiche come la mindfulness, il forest bathing,12 environmental, l’outdoor education, le pratiche artistiche e performative. Dimensione cognitiva e corporea, pensiero e azione (D’Ambrosio 2013) s’intrecciano con la prospettiva bioeducativa (Marturana e Varela, 2001) e con l’idea di attuare percorsi formativi capaci di far emergere una profonda consapevolezza ripartendo dalla conoscenza del proprio corpo, nel suo sentire, nel suo muoversi, nel suo comunicare (Spada, 2020). Ripensare l’insegnamento vuol dire anche ripensare la relazione. Non si tratta solo di fattori ambientali e programmi didattici, ma di rinforzare l’impalcatura educativa sulla quale andranno a consolidarsi le abilità dello studente. Il processo di scaffolding si costruisce attraverso un supporto solido e sempre meno necessario nel tempo, per questo efficace. Le comunità di apprendimento e l’apprendimento cooperativo sono esempi pratici per poter sperimentare l’importanza vantaggiosa dell’incontro con l’altro, che produce confronto e crescita. I casi di good practies attivati nelle comunità di apprendimento in Spagna e riportati nello studio di Scotton rimarcano la descolarizzazione ipotizzata da Illich e Freire analizzando benefici e limiti di proposte alternative al classico modo di fare scuola (Scotton, 2020). L’aspetto emergente di tale riflessione è la possibilità di lavorare con gruppi disomogenei coinvolgendo studenti, genitori e insegnanti in un clima educativo atto a tramettere soprattutto valori e competenze umane. L’educazione diffusa e le opportunità di condivisione delle riflessioni individuali mettono in relazione i mondi interiori promuovendo ascolto e rispetto verso l’intero gruppo, migliorando al contempo il processo di apprendimento. L’idea di un progetto educativo che intrecci indispensabilmente la società e i suoi bisogni attraverso una scuola che riconosca la centralità dell’esperienza collettiva come opportunità di apprendimento e sviluppo morale umano rimanda, in alcune sfumature, alla pedagogia collaborativa di Makarenko (Sarracino, 2018).
Il corpo come dispositivo multidirezionale nell’esperienza
La società della fretta è creatrice e vittima della fugacità delle cose. Le non cose (Han, 2022), ovvero i flussi di informazione, sono dematerializzazioni inafferrabili del concreto. L’abitudine alla nebbia mentale ed emotiva, la rapidità dell’informazione mutevole e gli stili di vita rendono insopportabili le attese. Le professioni pedagogiche possono intervenire in questo processo, apparentemente inarrestabile, operando con cura, riflessione e dialogo. La strategia educativa è per sua peculiarità aperta alla messa in discussione e orientata alla risoluzione delle problematiche attraverso l’ex-ducere,13 il portare fuori ciò che è già nella natura più intima delle persone. L’intento di operare offrendo nuove esperienze incentrate sulla suggestione del bello e sul piacere dell’anima predilige il corpo come dispositivo multidirezionale che capta e trasmette attivamente informazioni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (da qui OMS) definisce il concetto di salute come una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale e non esclusivamente l’assenza malattia o di infermità, legittimando, involontariamente, l’agire educativo come garanzia per una tutela mirata al miglioramento della dimensione sociale. Se la salute è determinata anche dal benessere sociale e la socialità passa per la relazione, che a sua volta passa attraverso il corporeo, allora educazione e salute sono collegate da un filo diretto il cui punto d’incontro comune è il corpo. Dal momento in cui si inizia a considerare il paziente nella sua globalità si innesca un processo per il quale alla medicalizzazione si affianca la storia soggettiva e l’intervento sulla sua salute è di stampo olistico. Il riferimento al campo medico spiega, in termini di prevenzione e cura, come la pedagogia si avventuri in dinamiche biologiche e neuroscientifiche14 per comprendere i processi di formazione e apprendimento (Crispiani, 2020). Montessori, medico e pedagogista, descrive il processo di scoperta del bambino attraverso le mani considerandole come le principali fonti di informazioni per il cervello umano. La mano quale organo dell’intelligenza umana è l’estensione di una mente che interagisce con il mondo e invia segnali alla mente. L’arte come esperienza è già stata ampiamente validata nelle partiche di arteterapia15 e la sua efficacia è riscontrabile anche nei processi educativi. Un esempio pratico. L’esperienza della lavorazione dell’argilla è una pratica artistica nella quale chiunque può sperimentarsi, non necessariamente ai fini professionali, ma in un’elaborazione della materia che può rappresentare l’espressione del sé plasmato da una manipolazione guidata dall’inconscio. Proporre esperienze basate sui sensi e sull’attivazione del corpo come dispositivo multidirezionale, che riceve e invia informazioni, può essere una pratica educativa in grado di emozionare, dal latino emovere, trasportare fuori, scuotere. In Arte come esperienza Dewey fa riferimento alle emozioni come legate eventi e oggetti nel loro movimento e in un particolare passaggio scrive: «L’emozione è la forza che muove e cementa. Essa seleziona ciò che è congruo e tinge ciò che è selezionato con il suo colore, conferendo così unità qualitativa a materiali all’apparenza eterogenei e dissimili» (Dewey, 2020, p. 67). Essere scossi in positivo aprendosi e aprendo alle proprie emozioni attiva la produzione di sostanze nei circuiti cerebrali. I neurotrasmettitori come la dopamina e la serotonina sono risposte molecolari positive del cervello all’esperienza vissuta. Bisogna dunque domandarsi quali potrebbero essere gli effetti della vita iperconnessa sulla creatività intesa come prodotto dell’immaginario. Quando i processi dell’immaginazione si impoveriscono e lo sforzo ideativo smette di esistere l’emozione muore e l’umanità si spegne, nulla scuote, non si avverte più motivazione verso le pratiche del fare. La qualità dell’esperienza produce effetti biologici e il tatto può essere un ottimo mediatore nel ricucire il rapporto con il proprio mondo interiore. Il contatto con la natura ha un’azione simile. La moltitudine di stimoli degli ambienti naturali attiva i cinque sensi, migliora le funzioni cognitive, la sfera emotiva e relazionale e le funzioni motorie. Rispetto alla relazione tra mente e corpo l’embodiment rifiuta la separazione tra mente e corpo restituendo la visione di un cervello incarnato che è abitato dalla mente, nello specifico dai processi mentali. Il rapporto tra mentale e corporeo funziona in maniera bidirezionale attraverso un ciclo di continuo scambio di informazioni e influenze. Il rapporto mente-corpo-ambiente è alla base delle prospettive di ricerca e delle pratiche embodied cognition secondo le quali la cognizione si configura come l’esito dell’interazione dell’organismo con l’ambiente (Siegel, 2021). La metodologia embodied ripensa i territori dell’esperienza sperimentando nuove possibilità di apprendere attraverso il senso-motorio secondo una visione bioeducativa (Carpenzano et al., 2017). L’esistenza del corpo è la prova fenomenologica dell’esistenza umana. Senza la presenza del corpo non sussiste la percezione della realtà. In questo discorso si inserisce la riflessione di Floridi sull’interazione uomo-macchina-ambiente e il mutamento ontologico che produce. La macchina inventata dall’uomo possiede una grande quantità di dati che in tempi brevi possono creare un prodotto strategicamente corretto sulla base di algoritmi sofisticati, ma la differenza fondamentale tra intelligenza artificiale e intelligenza umana è l’istintività della sfera emotiva umana. Tutto viene ripensato a misura di macchina, anche l’ambiente perde la misura umana delle cose che lo costituiscono. Se si delega qualunque attività a un sistema che supera le capacità del suo creatore chi potrà controllarne la correttezza? Se dal digitale come arma di distrazione di massa si ha la trasformazione del digitale come arma per poter manipolare e distruggere le vite chi avrà la competenza per poter contrastare l’oscuro oblio degli attacchi informatici? Assurdo pensare che un’intera Nazione potrebbe essere messa in ginocchio da un hackeraggio dei sistemi bancari o sanitari. Se la gestione dell’intelligenza artificiale è capacità e potere di pochi, si potrà ancora parlare di democrazia? L’adeguatezza del sistema d’interazione tra uomo e macchina consiste nel supporto che il sistema può apportare alla funzione umana, non viceversa. La centralità del corpo all’interno dei processi creativi è propria dell’attività umana e condizione necessaria allo sviluppo biologico e alla percezione di avere un ruolo attivo in un mondo di artifici (Arendt, 2017). Costruire con le mani e l’intelletto nel segno di una vita activa implica il recupero dell’homo faber, l’uomo fabbricatore che crea mettendo in relazione pensiero e azione, mente e corpo. Senza azione si ha un prodotto privo di processo. La performance è invece necessaria per lo sviluppo biologico della persona in quanto attiva l’azione del corpo e della mente nella partica. Nella metodologia embodied la cognizione rinnovata del corpo vede una trasformazione della corporeità che si muove nell’ambiente in accordo con il pensiero e in un’ottica di influenza ciclica e circolare. La pratica performativa implica che l’opera si realizzi attraverso il moto del corpo mentre coordinazione motoria, intellettiva ed emozionale si allineano. La performance è necessaria per favorire l’incontro interpersonale, promuovere fiducia all’interno dei gruppi, stabilire una connessione con sé stessi e con il contesto circostante, liberare la mente da sentimenti negativi per facilitare il flusso delle idee, stabilire confidenza con gli ambienti fino a sentirsi parte integrante degli stessi. Mettersi in ascolto facendosi guidare dall’energia cognitiva e permettere al corpo di rappresentare questo potenziale ancora inespresso è una pratica che si rivela utile non solo nella relazione con l’altro, ma anche per la consapevolezza di ogni scelta o azione compiuta quotidianamente. Per poter stabilire una connessione nella vita reale occorre che lo stato mentale (Arendt, 2017) di ciascun attore coinvolto in questo processo risulti aperto all’interazione e venga alterato seppur temporaneamente dai messaggi recepiti affinché possa trasformarli in esperienza ed elaborare opportune risposte da esternalizzare. Realizzare questo stile relazionale richiede molta empatia, si tratta di un’interazione emozionale che consente di porsi all’altro come se ci si trovasse davanti a uno specchio pronti a condividere e donare una parte di sé stessi ritrovando il contatto. Nelle intelligenze multiple definite da Gardner vi è anche l’intelligenza corporeo-cinestetica descritta come capacità di usare il corpo in modi differenziati e abili per fini espressivi e concreti (Gardner, 1983; 1985). Il collegamento diretto tra cognitivo e corporeo è un’ulteriore conferma del dualismo mente-corpo a lungo considerati come entità separate. Il ruolo della decodifica emozionale in reazioni psicosomatiche e l’efficacia dell’apprendimento quando l’azione è coinvolta sono ulteriori esempi di come il corpo sia un dispositivo multidirezionale nell’esperienza.
Conclusione
Il contributo umano al mondo è lo specchio della natura più intima delle persone. Per comprendere l’andamento di una società bisogna osservare le sue azioni, il suo funzionamento. Le crisi, le guerre, il senso di sfiducia, l’incertezza invalidante sono tutte figlie di un funzionamento tossico e malsano. Occorre una presa di coscienza generale. Ognuno dovrebbe apportare al mondo ciò che desidera trovarci, con responsabilità e cura. La proposta di una pedagogia lenta presuppone un cambiamento culturale basato su un differente sistema di valori ottenuto da una nuova visione del mondo che il ricongiungimento con la natura può rendere possibile. L’affermarsi di singoli e gruppi che promuovono realtà alternative sono la sana espressione di una civiltà non del tutto perduta. Il mezzo più efficace è l’agire riflessivo che presuppone un ampio processo di ragionamento critico affiancato contestualmente dalle azioni concrete, anche dette azioni meditate. È possibile praticare una rivoluzione culturale dolce, in cui i rapporti umani, la dimensione spirituale e il rapporto con l’ambiente ritrovino il loro naturale equilibrio. La fretta dettata dalla società dell’efficienza a tutti i costi scaturisce modelli dannosi che promuovono eccessi irrazionali: abuso delle risorse del pianeta, stili competitivi, prevaricazione, allontanamento sociale, diffidenza, instabilità, sofferenza, alienazione, tutti elementi che disintegrano il concetto di società. «L’essere umano è un animale sociale», così Aristotele (nel IV sec. a. C.) definiva la nostra natura e la nostra identità, che si realizza costantemente attraverso l’incontro con l’altro. Dunque, siamo esseri sociali immersi in un ambiente di vita intensamente contaminato dalla tecnologia e dalle rapide evoluzioni che comportano ampi flussi di informazioni mutevoli. Per destreggiarsi in una realtà iperconnessa occorre sviluppare competenze in un processo di educazione permanente del sé che dura per tutta la vita. Attraverso la messa in discussione di questioni educative di attualità si è tentato di raccontare e criticare alcune dinamiche sociali per ipotizzare, in conclusione, possibili alternative pedagogicamente orientante e realizzabili in contrapposizione a sviluppi futuri paradossali, ma non per questo improbabili. È necessario superare la sola teorizzazione per avvicinarsi all’esperienza concreta, sperimentarla e farne apprendimento permanente, quindi cambiamento. A sostegno di una condizione emergenziale gli studi interdisciplinari forniscono possibili traiettorie di ricerca che trovano forza in un dialogo tra le discipline nel quale ogni sapere chiarifica e integra l’altro. Orientare per indicare la direzione sarà l’esito di un dialogo multidisciplinare che potrà aprire strade di ricerca utili per l’educazione del futuro, di un futuro vicino. Nella dimensione di un agire eco-logico è indispensabile concepire un’interazione mente-corpo-ambiente che riesca a stabilire una relazione con dimensioni come l’ecosistema naturale inteso come fonte di valori e insegnante di abilità. Per sua natura l’essere umano nasce da un contatto corporeo e si sviluppa sulla base delle interazioni con l’ambiente, non esiste organismo che non sia in contatto con l’ambiente (Cavagna, 2022) e di conseguenza non esiste organismo che non entri in relazione. La prospettiva del recupero (Augelli, 2023) solleva la necessità di ripensare l’interazione tra soggetto e ambiente individuando nell’apertura verso le divergenze nuove possibilità di recupero incentrate sull’essenzialità del bene comune, in un contesto di liquidità che oscilla tra il desiderio di apertura al sentimento verso l’altro e il timore di stringere legami (Bauman, 2006). Il percorso naturale del progresso comporta la perdita di abilità in favore di nuove acquisizioni, ma se il nuovo progresso dipende da una rete elettrica quanto si può effettivamente delegare alle sue forme? La sovraesposizione tra vita reale e vita digitale è oggetto delle scienze dell’educazione in quanto influenza lo sviluppo, individuale e collettivo, di una società umana che per sua natura si evolve attraverso l’incontro con l’altro. Le considerazioni e gli interrogativi che emergono dal consolidarsi del paradigma onlife fanno luce sulla necessità di un dibattito scientifico attuale e necessario che sottolinei l’importanza dell’integrazione tra l’umano e il tecnologico in modo tale da evitare l’alienazione causata dall’eccesso di virtualità. L’attenzione crescente di pratiche che riportano il corpo al centro delle attività considerandolo come dispositivo provvisto di recettori capaci di interagire con l’ambiente per migliorare il benessere e l’apprendimento è un forte segnale. La predisposizione degli ambienti e le pratiche come la mindfulness applicate nei contesti scolastici o negli ambienti lavorativi particolarmente sensibili al dipendente ne sono un esempio. Ripensare le pratiche educative sulla base delle conoscenze neuroscientifiche e del funzionamento della mente relazionale (Siegel, 2021) privilegiando la dimensione umana della formazione per preparare lo studente all’uso ragionato delle nuove tecnologie è l’obiettivo da perseguire. Attraverso la descrizione di scenari attuali si è tentato di indagare quali fossero gli effetti di una vita iperconnessa per comprendere a fondo le conseguenze che la vita virtuale esercita sulla vita reale. L’incontro umano e il benessere della dimensione sociale della persona, come definito dall’OMS, sarebbero il primo tassello per ricucire la piaga di un mondo iperconnesso ma sempre più distaccato. Le questioni che ruotano attorno all’iper-digitalizzazione sono molte e l’educazione ha un ruolo fondamentale nell’aiutare le persone ad essere capaci di porsi sani dubbi rispetto alla fruizione dei contenuti. Le professioni pedagogiche devono indispensabilmente lavorare per la promozione della democrazia come forma di tutela contro l’oppressione della libertà individuale. Ma come nasce il sentimento verso la democrazia? Discutere di sentimento, scienza e tecnologia in un contributo che aspira a un’adeguatezza delle sue fonti e della linearità del suo ragionamento non è semplice. Per rispondere al quesito e concludere si riportano le profonde parole della giornalista, autrice e attivista Maria Shiver (per ricordare che l’amore è molto più esteso di ciò che intendiamo comunemente quando ci riferiamo alla persona amata e può andare verso significati ampi, come il senso di democrazia): «L’amore è universale. È primario. È umano. È ciò che muove i singoli mondi e i grandi ordini globali. Sono convinta che sia la nostra più grande speranza per un mondo migliore. La più grande speranza se vogliamo amarci l’un l’altro, amare il nostro Paese e noi stessi. […] Ciascuno di noi è nato fra le braccia di qualcuno e, se siamo fortunati, sarà così anche quando moriremo. Tutto ciò che avviene nel mezzo è la ricerca della nostra comune umanità. Le sue radici sono soltanto nell’amore» (Siegel, 2021, p. 643).16
Bibliografia
Arendt A. (2017), Vita Activa. La condizione umana, Milano, Bompiani.
Augelli A. (2023), Dello scarto e del recupero. Per una pedagogia della sostenibilità, Milano, FrancoAngeli.
Bauman Z. (2003), Amore liquido, Roma-Bari, Laterza.
Bauman Z. (2005), Vita Liquida, Roma-Bari, Laterza.
Bauman Z. (2012), Conversazioni sull’educazione, Trento, Erickson.
Bauman Z. (2014), La scienza della libertà, Trento, Erickson.
Biesta J.J.G. (2023), Oltre l’apprendimento. Un’educazione democratica per umanità future, Milano, FrancoAngeli.
Candreva L. (2021), La scuola digitale. Il senso dell’educazione e le sfide della tecnologia, Trieste, Asterios.
Caputo M. e Pinelli G. (2019), Pedagogia dell’espressione artistica, Milano, FrancoAngeli.
Carioli S. (2022), Connessioni, Milano, FrancoAngeli.
Carpenzano O., D’Ambrosio M. e Latour L. (2017), E-learning. Electric extended embodied, Pisa, Edizioni ETS.
Cavagna P.P. (2022), Paradigma. Per una pedagogia fenomenologica interrelazionale, Ghilarza, OR, Edizioni Scientifiche Cavagna.
Cavalli N., Ferri P. e Moriggi S. (2023), A scuola con le tecnologie, Milano, Mondadori Libri.
Chistolini S. (2021), L’asilo nel bosco. La scuola aperta alla comunicazione sul territorio tra arte e comunità, Milano, FrancoAngeli.
Chistolini S. (2022), Outdoor education. Muoversi nello spazio mondo tra creatività, avventura, responsabilità, Milano, FrancoAngeli.
Ciasullo A. (2015), Armonie bioeducative, Milano, FrancoAngeli.
Coco D. (2023), Pedagogia della corporeità e sviluppo morale, Roma, Anicia Edizioni.
D’Ambrosio M. (2006), Media corpi e saperi, Milano, FrancoAngeli.
Dal Zovo S. (2020), Mindfulness e benessere a scuola, Trento, Erickson.
Del Corno F. (2023), Ripartiamo dai genitori, Milano, FrancoAngeli.
Dewey J. (2014), Esperienza e educazione, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Dewey J. (2015), Esperienza, natura e arte, Milano, Mimesis Edizioni.
Dewey J. (2018), Scuola e società, Roma, Edizioni Conoscenza.
Dewey J. (2020), Arte come esperienza, Milano, Aesthetica Edizioni.
Digennaro S. (2021), Non sanno neanche fare la capovolta. Il corpo dei giovani e i loro disagi, Trento, Erickson.
Digennaro S. (2022), Io-corpo. Perché occorre ripensare il pensiero pedagogico e il modo in cui educhiamo, Trento, Erickson.
Eco U. (1997), Apocalittici e integrati: Comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa, Milano, Bompiani.
Elia G. (2015), La complessità del sapere pedagogico tra tradizione e innovazione, Milano, FrancoAngeli.
Emili E.A. (a cura di) (2023), Costruire ambienti inclusivi con le tecnologie, Trento, Erickson.
Ferrante A. (2017), Che cos’è un dispositivo pedagogico?, Milano, FrancoAngeli.
Filograsso N., Travaglini R. (2009), La mente, Milano, FrancoAngeli.
Floridi L. (2017), La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Frauenfelder E. e Santoianni F. (1997), Nuove frontiere della ricerca pedagogica. Tra bioscienze e cibernetica, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
Frauenfelder E. e Santoianni F. (a cura di) (2002), Le scienze bioeducative. Prospettive di ricerca, Napoli, Liguori editore.
Freire P. (2018), Pedagogia degli oppressi, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
Gardner H. (2013), Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Milano, Feltrinelli.
Gentili G. (2011), Intelligenze multiple in classe, Trento, Erickson.
Guarcello E. (2020), Scuola, carattere e skills, Milano, FrancoAngeli.
Habermas J. (a cura di) (1997), Teoria dell’agire comunicativo. Razionalità nell’azione e razionalizzazione sociale, Roma-Bari, Laterza.
Han B. (2015), Nello sciame, Milano, Nottetempo.
Han B. (2022), La società senza dolore. Perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite, Torino, Einaudi.
Han B. (2023), Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete, Torino, Einaudi.
Han B. (2023), Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale, Torino, Einaudi.
Illich I. (2019), Descolarizzare la società, Milano, Mimesis Edizioni.
Latouche S. (a cura di) (2021), Breve storia della decrescita, Torino, Bollati Boringhieri.
Lucangeli D. (2020), Cinque lezioni leggere sull’emozione di apprendere, Trento, Erickson.
Lucangeli D. (2021), La mente che sente, Trento, Erickson.
Marturana H. e Varela F. (2001), Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, Venezia, Marsilio.
Massa R. (2023), Educare o istruire?, Milano, FrancoAngeli.
McLuhan M. e Powers B. (1996), Il villaggio globale. XXI secolo: trasformazioni nella vita e nei media, Milano, Sugarco Edizioni.
Milana M., Perillo P. e Muscarà M. (2023), Agrusti F., Il lavoro educativo per affrontare le fragilità individuali, istituzionali e sociali, Milano, FrancoAngeli.
Milani L. e Scuola di Barbiana (2023), Lettera a una professoressa, Milano, Mondadori Libri.
Montessori M. (2007), Come educare il potenziale umano, Milano, Grazianti.
Montessori M. (2008), Educare alla libertà, Milano, Arnoldo Mondadori Editore.
Morin E. (a cura di) (2017), La sfida della complessità, Firenze, Le Lettere.
Olivieri D. (2014), Le radici neurocognitive dell’apprendimento scolastico, Milano, FrancoAngeli.
Orsenigo J. (2022), Esperienza clinica. Alle radici della professionalità in pedagogia, Milano, FrancoAngeli.
Perez J.F. e Caserta F. (2010), La costruzione della mente tra neurologia e pedagogia, Milano, FrancoAngeli.
Perla L. e Riva M.G. (2016), L’agire educativo, Brescia, La Scuola.
Petti L. e Triacca S. (2015), Insegnare con le tecnologie, Bergamo, Edizioni Junior.
Pierdicca R., Fontoni E. e Puggioni M. (2024), Educare con le nuove tecnologie, Rimini, Maggioli Editore.
Poce A. (a cura di) (2015), Tecnologia critica, creatività e didattica della scienza, Milano, FrancoAngeli.
Popper K. (2019), Cattiva maestra televisione, Venezia, Marsilio.
Postman N. (2014), La scomparsa dell’infanzia, Roma, Armando Editore.
Rivoltella P.C., Villa A. e Bruni F. (2023), Curricoli digitali. Nuove intelligenze, nuovi diritti, Milano, FrancoAngeli.
Sadin E. (2018), Critica della ragione artificiale. Una difesa dell’umanità, Roma, LUISS.
Sarracino V. (2018), Il poema pedagogico di Anton Semënovič Makarenko. L’educazione per una società futura, Barletta, Cafagna editore.
Scarcelli C.M. e Stella R. (a cura di) (2017), Digital literacy e giovani, Milano, FrancoAngeli.
Scarinci A. (2022), Tecnologie digitali per la didattica, Bari, Progedit.
Schon D.A. (1993), Il professionista riflessivo, Bari, Dedalo.
Siegel D. (2021), La mente relazionale, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Stella G. (2016), Tutta un’altra scuola, Firenze, Giunti.
Strollo M.R. (a cura di) (2007), Scienze cognitive e aperture pedagogiche, Milano, FrancoAngeli.
Tarsi P.P. (2024), La prospettiva autopoietica-enattiva. Vita, cognizione, educazione nel solco di Maturana e Varela, Milano, FrancoAngeli.
Tomarchio M., D’aprile G. e La Rosa V. (2018), Natura cultura. Paesaggi oltreconfine dell’innovazione educativo-didattica, Milano, FrancoAngeli.
Torchia L. (2023), Lo Stato digitale. Una introduzione, Bologna, il Mulino.
Zavalloni G. (2012), La pedagogia della lumaca, Verona, Emi.
Sitografia (tutti i siti sono stati consultati il 22 ottobre 2025)
Cesaretti L. (2021), Intelligenza artificiale e educazione: un incontro tra due mondi. Rischi e opportunità, «Rivista di Scienze dell’Educazione», vol. 59, n. 1, pp. 81-98, https://rivista.pfse-auxilium.org/it/riv_abstract.cfm?PUBRIVISTA_ID=1635&tab=8
Crispiani P. (2020), La frontiera della biopedagogia, «L’Integrazione Scolastica e Sociale», vol. 19, n. 4, pp. 59-72, https://rivistedigitali.erickson.it/integrazione-scolastica-sociale/archivio/vol-19-n-4/la-frontiera-della-biopedagogia
Floridi L. (a cura di) (2015), The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era, Berlin, Springer, https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/28025/1/1001971.pdf#page=29
Iaquinta R. (2023), Didattica immersiva e fragilità: dalla cornice teorica alla sperimentazione in classe, «Esperienze, strumenti e ambienti per la didattica immersiva», vol. 4, n. 7, pp. 349-358, https://iulresearch.iuline.it/index.php/IUL-RES/article/view/412
Maggi D. (2020), Un flusso di apprendimento: il corpo, «Mizar. Costellazione di pensieri», vol. luglio-dicembre 2020 n. 13, pp. 29-39, http://siba-ese.unisalento.it/index.php/mizar/article/viewFile/23285/19521
McLuhan M. (1964), Understanding Media. The extensions of man, https://designopendata.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/05/understanding-media-mcluhan.pdf
Piva M (2023), Virtual tour e didattica immersiva: creazione di un museo virtuale-interattivo nella scuola primaria, «Esperienze, strumenti e ambienti per la didattica immersiva», vol. 4, n. 7, pp. 313-328, https://iulresearch.iuline.it/index.php/IUL-RES/article/view/489/245
Scotton P. (2020), Le comunità di apprendimento in Spagna. Un affascinante progetto educativo, «Pedagogia più Didattica», vol. 6, n. 2, pp. 24-36, https://rivistedigitali.erickson.it/pedagogia-piu-didattica/archivio/vol-6-n-2/le-comunita-di-apprendimento-in-spagna
Spada E. (2020), Educare corpi pensanti. Per una pedagogia del corpo in movimento, https://www.academia.edu/75884822/Educare_corpi_pensanti_Per_una_pedagogia_del_corpo_in_movimento
-
1 Pedagogista laureata in scienze dell’educazione e consulenza pedagogica. Attualmente Dottoranda di ricerca in Humanities and Technologies (curriculum «Didattica e pedagogia») presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.
-
2 Strategie educative sviluppate a partire dal concetto per il quale mente e corpo non siano due dimensioni distinte, ma il cervello incarnato e il corpo determinino entrambi i processi mentali.
-
3 Pedagogista laureata in scienze dell’educazione e consulenza pedagogica. Attualmente Dottoranda di ricerca in Humanities and Technologies (curriculum «Didattica e pedagogia») presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.
-
4 Educational strategies developed starting from the concept that the mind and body are not two distinct dimensions, but the embodied brain and the body determine both mental processes.
-
5 Modello che si riferisce all’inversione di paradigma per il quale la conoscenza e l’apprendimento siano profondamente influenzati e mutati dall’evoluzione tecnologica e dalla sua accessibilità.
-
6 Ambiente informazionale all’interno del quale vivono organismi iperconnessi che condividono e recepiscono informazioni.
-
7 La Pandemia da Covid-19 è stata dichiarata emergenza sanitaria globale nel 2020. Per ridurre il rischio di contagio si è ricorso a un isolamento di massa. Si ritiene indispensabile questa nota per i lettori futuri che non hanno vissuto quel periodo.
-
8 Le applicazioni per l’apprendimento assistito e i dispositivi per la sintesi vocale sono esempi concreti dell’utilità del digitale all’interno dei processi formativi, soprattutto in caso di disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, per rendere accessibili i contenuti.
-
9 Per addetti ai lavori ci si riferisce a tutti coloro che operano a vario titolo nei contesti educativi e formativi e che hanno il compito di orientare alla criticità come processo ragionato delle decisioni.
-
10 Decrescita serena è la provocazione che propone una logica sociale sostenibile respingendo gli eccessi.
-
11 Si riporta una ricerca consultata, condotta in un’area ad alto rischio: https://iulresearch.iuline.it/index.php/IUL-RES/article/view/412 (consultato il 22 ottobre 2025).
-
12 Pratica che trova le proprie origini nell’arte orientale di trarre benessere ed energia dal contatto con la natura.
-
13 Dal latino ex-ducere, educere, «condurre fuori». In questo caso educare vuol dire far emergere ciò che è già insito nelle persone attraverso la relazione educativa.
-
14 https://rivistedigitali.erickson.it/integrazione-scolastica-sociale/archivio/vol-19-n-4/la-frontiera-della-biopedagogia/ (consultato il 22 ottobre 2025).
-
15 L’arteterapia non è una cura e non si sostituisce a essa. Le pratiche dell’arteterapia si affiancano alle cure terapeutiche mediche offrendo un’integrazione del percorso che promuove la salute psicofisica attraverso la stimolazione delle risorse espressive del paziente.
-
16 Il contributo originale è pubblicato in data 8 dicembre 2019 nel Sunday paper online dell’autrice Maria Shiver. Si è ritenuto di concludere con un messaggio di amore, fiducia e speranza per l’umanità e per la democrazia.
Vol. 2, Issue 2, October 2025