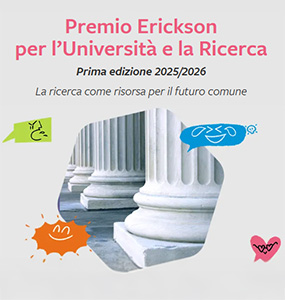Vol. 2, n. 2, ottobre 2025
Una macchina metaforica chiamata corpo
Spunti per una semiosi del corpo e della corporeità dal mondo greco alla contemporaneità dell’intelligenza artificiale
Dorella Cianci1
Sommario
Il corpo si «muove» nel tempo, nella società e nell’abito, declinando il suo uso metaforico. In questo senso, la paideia del corpo, nel mondo greco, è diventata un caso emblematico: i Greci, per primi, hanno elaborato i corpi con la parola. L’uso metaforico del corpo è stato, dunque, la chiave interpretativa di ieri e di oggi. E domani? Siamo davvero alle soglie di un cambio di scenario? L’era digitale chiede ai corpi di ridefinire il proprio uso? O il corpo è l’unico discrimine, che renderà sempre parziale le nuove tecnologie? Ciò che è digitale sarà sempre prima corporeo?
Parole chiave
Corporeità, ekphrasis, metafora, Intelligenza Artificiale, paideia, società.
A Metaphorical machine called the body
Notes towards a semiosis of the body and corporeality from the greek world to the age of Artificial Intelligence
Dorella Cianci2
Abstract
The body «acts» in time, in society and in dress, declining its metaphorical use. In this sense, the paideia of the body, in the Greek world, has become an emblematic case: the Greeks were the first to elaborate bodies with words. The metaphorical use of the body has therefore been the interpretative key of yesterday and today. And tomorrow? Are we really on the threshold of a change of perspective? Does the digital age ask bodies to redefine their use? Or is the body the only dividing line, which will always make new technologies partial? Will what is digital always be corporeal first?
Keywords
Corporeality, ekphrasis, metaphor, Artificial Intelligence, paideia, society.
Una robotica d’antan
Forse il primo a occuparsi di umanoidi è stato Omero… Proprio lui (o chi per lui) nell’Iliade, al canto XVIII (vv. 414-422), si è espresso così: «[…] si mise il chitone, prese lo scettro massiccio e venne fuori / zoppicando; due ancelle dorate, simili a delle vere ragazzine / sostenevano il loro creatore».3 Possibile che questo passo stia parlando proprio di macchine dalle «sembianze umane»? Possibile che queste ragazze, simili a corpi viventi, siano creazioni del mitico fabbro Efesto? È decisamente curioso questo aneddoto, perché sono proprio queste «finte» fanciulle a sostenere il loro celebre creatore claudicante, il quale (come si precisa, poco prima, nel libro XI dell’Odissea, vv. 85-94) aveva creato anche «cani d’oro e d’argento […] con mente ingegnosa». E allora? Siamo agli albori della robotica, che peraltro si prestava, immaginariamente, ad aiutare corpi mutilati, in vera carne e ossa? Questo non è solo un gustoso dettaglio proveniente dai poemi omerici, ma è anche la concreta rassicurazione del fatto che gli umanoidi son stati sempre immaginati dalla fantasia umana, ma mai hanno potuto sostituirsi alle molteplici caratteristiche dell’uomo, non costituito, ovviamente, nella sua essenza, di sole abilità e funzioni. Se proprio, però, vogliamo parlare di abilità e funzioni allora qui si potrà convenire con il gesuita Ong che la vera rivoluzione tecnologica del corpo e della mente dell’uomo si è avuta con la tecnologia della scrittura: niente sarà mai più così grandioso come quel passaggio. Ong, da collaboratore di McLuhan e insieme a Havelock e Innis, ha fatto parte della «scuola di Toronto», che è alla base della nascita dei Communication Studies negli USA. Nel suo libro Oralità e Scrittura (traduzione di Orality and Literacy: the Technologizing of the word) afferma che «la scrittura ha trasformato la mente umana più di qualsiasi altra invenzione» e analizza le obiezioni che sono state mosse nei confronti della scrittura da Platone, nel Fedro, paragonandole a quelle che oggi si fanno nei confronti delle nuove tecnologie (Ong, 1986).4 Ong arrivò a sostenere che la scrittura è una tecnologia completamente artificiale, al contrario del linguaggio naturale, cioè quello orale; in questo senso, però, egli non ha voluto dar seguito alla condanna platonica, al contrario ha visto questa tecnologia come fondamentale per lo sviluppo dei potenziali umani interiori. Le tecnologie, in tal senso, stando all’intera opera di Ong, non sono semplici strumenti esterni di supporto, ma comportano trasformazioni delle strutture mentali, soprattutto quando hanno a che vedere con la parola. Con Ong possiamo dire, a introduzione del nostro discorso, che la tecnologia, se efficacemente interiorizzata, non degrada la vita umana, ma al contrario la migliora.
I corpi d’oggi: fra uso e cura
Partendo da qui, dunque, si può riflettere su quel che l’era digitale (definizione spesso generica e sommaria) chiede, in questo momento, ai corpi: devono tentare di ridefinirsi o sono il solo (e unico) discrimine, che renderà sempre parziali le nuove tecnologie? I corpi ostacoleranno l’intelligenza artificiale, rendendola meramente al servizio della complessa corporeità? L’era digitale potrà mai riprodurre, nella sua totalità, quella macchina portatrice di metafore e senso, che è il complesso (e per certi versi ancora misterioso) corpo umano? Tanti gli interrogativi. L’intelligenza artificiale, che qui non vogliamo affatto giudicare negativamente, ma solo segnalarne dei limiti inevitabili, ci pone dinanzi a una questione di grande rilievo etico e di spiccata attualità: abbiamo bisogno di dare un corpo alla robotica o abbiamo la necessità di definire, con maggiore profondità storica, il corpo (lungo le vie delle sue asperità), per eliminare ogni timore di perdita di centralità dell’umano rispetto alla robotica e ai suoi derivati più recenti? Con l’IA,5 il corpo deve sentirsi un’assenza contemporanea o, per meglio dire, il corpo è forse l’unica presenza, che rende l’umano insostituibile? In tal senso ci aiutano nella riflessione, a vario titolo, moltissimi pensatori come Agamben, Bauman, Benanti, Deleuze, De Kerckhove, Ong, Tognon e altri ancora.6 Possiamo dunque, in merito a tale questione, definire la centralità dei corpi per ogni tempo e ogni società? O il corpo è un concetto autenticamente mobile, che si muove e si modella nelle diverse metafore della società in cui vive?7 Sia Agamben che Tognon hanno sviluppato l’intuizione di Foucault, secondo cui agli albori della soggettività c’era la distinzione greca fra uso e cura del corpo, come se essi sapessero riconoscere che il corpo (che si usa come una macchina) non appartiene mai a se stesso, ma a un altro sé (Agamben, 2014; Tognon in Cianci, 2014; Tognon, 2014). In tal senso Tognon ha utilizzato un’espressione puntuale e significativa: il corpo non appartiene mai al corpo (Tognon in Cianci, 2014). Usare i corpi, infatti, vuol dire stabilire una relazione fra soggetto e oggetto. I corpi così diventano la palestra della relazione, ma anche la macchina più precisa di questa estensione, continuamente ricercata (per un ulteriore approfondimento si consiglia il volume di Popper ed Eccles, 1981).
L’ipertrofia delle macchine e il senso dei corpi
Éric Sadin,8 scrittore esperto di questi temi, ha proposto, in varie occasioni pubbliche (che qui sintetizzo), due interessanti e articolate osservazioni a proposito del rapporto macchina-corpo, in particolare al fine di comprendere quanto il corpo sia presente (o, in alcuni casi, assente) e quali siano i limiti della sua autonomia. La prima riflessione è che queste cosiddette «architetture computazionali» alla base della struttura dell’IA sono prive di corpo; esse, cioè, non sono altro che delle macchine calcolatrici, la cui funzione si limita alla semplice elaborazione di flussi informativi astratti. E, nel caso in cui esse si trovino collegate a dei sensori (per esempio il caso della cibernetica), non fanno altro che ridurre certi elementi del reale a dei codici binari, trovandosi escluse da un’infinità di dimensioni, che invece la nostra sensibilità, ospitata nel corpo, coglie e che sfuggono ai principi di un modello matematico. La seconda ragione, da lui espressa, è che non esiste intelligenza che viva isolata, chiusa nelle proprie possibilità logico-matematiche: non esiste una mente fuori dal corpo, né un’intelligenza che non sia prima azione performativa di un corpo che pensa e agisce. Sadin si riferisce a un meccanismo di progressione, che consiste nell’esercitarsi «contro sé stessi» come in una bolla, cercando, invano, di affermare un’intelligenza solitaria; invece, l’intelligenza è indissociabile da rapporti aperti e indeterminati con gli altri e con le cose dell’ambiente. Per cui il corpo è un sistema composito, destinato, per sempre, a distinguersi lontano dall’idea computazionale di vivere per se stesso, lontano da interazioni, da legami, da rapporti solidali. Dinanzi a queste considerazioni, si può ben comprendere come, a oggi, sia necessario tornare a riflettere sulla presenza e sull’assenza eventuale del corpo, sulla sua elaborazione all’interno del tempo e della società, per cercare di analizzare quanto l’orizzonte computazionale del nostro tempo possa fare a meno (o no) del corpo e della categoria a esso collegata, la corporeità.
Il corpo, le parole e la società: il caso greco
Per far questo, tuttavia, occorre tornare, ancora una volta, ad analizzare criticamente e storicamente un protagonista ineludibile: il nostro corpo. C’è stato un momento, nella storia delle idee, in cui si è iniziato a definire il corpo e la sua concettualizzazione? Innanzitutto, occorre precisare che non è solo la dimensione temporale a definire un corpo, ma esiste una naturale elaborazione metaforica di una società pronta a plasmarlo e a far sì che esso diventi un parametro di giudizio, un limite o una sfida per il futuro, un mezzo, se non addirittura, una possibilità di uso e abuso. Quando si è iniziato a ragionare davvero sul corpo come denominazione del pensiero e sul suo «movimento» all’interno della società? Già in Corpi di parole (Cianci, 2014) si è inteso dire che il caso greco è stato emblematico nell’elaborazione dei corpi, poiché i Greci hanno esaltato sia la forza dell’esteriorità, con un’analisi specifica nel gusto dei dettagli (ekphrasis), sia hanno saputo menzionare la fragilità e la caducità dei corpi, arrivando a intravedere (anzi a inventare) un elemento extra-fenomenico dirompente come l’anima. Il corpo non vive solo per sé, ma è chiamato a collegarsi; dunque, proprio per la sua vocazione e necessità all’interazione, ha subìto, durante il corso della storia antica, un processo politico ineludibile di generalizzazione, legato originariamente all’organizzazione sociale. La metafora per eccellenza associata al corpo come organismo vitale e vivente è quella del «corpo politico», cioè uno spazio di corpi, che si muovono nella realtà quotidiana, restando collegati all’interno dell’astrazione, sia in senso orizzontale (con gli altri) sia in senso verticale (in rapporto alla gerarchia). Il corpo come metafora politica, in senso ampio, viene così a rappresentare un orientamento delle tracce del sé lasciate nella società, secondo un’idea ben strutturata e, teoricamente, con caratteristiche armoniche. La migliore definizione di corpo metaforico politico è quella relazione utilizzata fra la tripartizione dello Stato e quella dell’anima, che si legge nella Repubblica di Platone (534 a-b). Non solo. La metafora fra la vitalità del corpo umano e la metaforizzazione politica potrebbe risalire fino al noto favolista Esopo (in particolare nelle favole 206 e 286 della sua opera). L’organicismo è stato anche chiaramente ripreso da Aristotele nella Politica (1253a), anche se questa citazione è meno considerata rispetto a quella platonica: «[…] infatti il tutto precede necessariamente la parte, perché tolto il tutto, non ci sarà più né piede né mano». Qual è, però, la metaforizzazione più celebre del corpo se quella riconducibile all’esempio di Menenio Agrippa, il quale, secondo quanto raccontato da Tito Livio in Storia di Roma aveva proposto una pacificazione fra la testa (cioè il senato romano) e le membra (vale a dire il popolo)? Alcuni studiosi (Cavavero, 2003; Caserta, 2009; Le Goff, 2007) hanno osservato da vicino la metaforologia politico-corporea nelle sue diverse sfaccettature. Ne emerge soprattutto un interrogativo. Qual è, in tal senso, il trait d’union fra l’elemento corporeo e la politica nel suo senso più generale? E perché nell’orizzonte della nostra contemporaneità è quasi un’urgenza definire il tema, per poter comprendere se siamo davvero in momento epocale di cambio d’orizzonte, rispetto al binomio naturale-artificiale, o se il corpo è, in buona sostanza, l’unico elemento ostativo, che non permetterà mai alla dimensione artificiale di aver un possibile primato d’azione rispetto all’ambito naturale? Questi gli interrogativi essenziali del nostro ragionamento. Per analizzare, dunque, la metaforizzazione del corpo occorre fare un passo indietro, per porre la questione su un piano ad ampio spettro.
Corpo naturale e intelligenza artificiale: physis e techne
L’uomo, e il suo corpo, in che relazione si trovano con l’ambiente circostante? La semiosi collegata all’uomo, con la sua corporeità, si ritrova all’interno di una speciale polarità, racchiusa nel concetto di «cittadino», sintesi di physis (natura), nomos (legge) e ambiente. Si ritiene utile, proprio per questa impostazione semiotica del rapporto corpo naturale e intelligenza artificiale, concentrarsi sul concetto di «cittadino», un termine di evidente matrice concettuale greca, anche se non strettamente dal punto di vista etimologico. Il cittadino, iscritto nelle prescrizioni del nomos, nella sua essenza, è, in primis, «corpo politico», stando all’impianto pedagogico e filosofico platonico (mirabili in tal senso gli scritti di Vegetti, 2023 e Reale, 1999): il «corpo politico» è un’ accezione che guarda all’idea perfetta di città, nello stesso modo in cui il falegname costruisce la spola e guarda, pensando a un oggetto possibile da realizzare, che sia conforme a un progetto possibile e a un conseguente fine (Platone, Cratilo). La metafora, perlopiù platonica, del «corpo politico» scinde, in maniera totalmente implicita, fra la vita quotidiana della carne (nell’uomo) e la vita complessiva (del cittadino), come un soggetto dotato di un corpo naturale presente all’interno della techne politica. L’uomo è inevitabilmente materia fatta di carne vivente (ed è fin troppo ovvio ribadirlo), ma è anche necessario precisare che l’umano dell’uomo, per usare il poetico lessico di Edda Ducci, è una struttura idealmente complessa, capace di alleggerirsi, a tratti, dalla sua complessità solo con l’incardinarsi nelle varie technai, che gli consentono il passaggio dall’astrazione a un ruolo feriale di cittadino (calato, in un preciso momento storico, nel funzionamento della polis) (Ducci e Costa, 2021). Anche se il caso greco è decisamente emblematico e centrale nella definizione del rapporto fra la natura e la techne, va detto che il passaggio dal corpo biologico a quello sociale appare più chiaro soltanto con il Cristianesimo, che ha reso profonda la simbolicità dell’elemento corporeo.9 Il corpo è il punto di contatto con le relazioni, ma soprattutto è, per il credente, l’incontro con Dio, Dio stesso rivelato e incarnato nella storia. Paolo, per primo, ha paragonato la Chiesa a un «corpo in cui nessun membro può fare a meno degli altri» (I Cor 12, 12-27). Anche il passaggio dal particolare, il «corpo», in carne e ossa, alla categoria generale di «corporeità» è un concetto profondamente cristiano: un modo di conoscere attraverso la carne, perché la fede cristiana si esprime con il corpo che ama, con il corpo che si mangia per la salvezza, con il corpo che prega fino a astrarlo a categoria divina, cioè a pane incarnato (Manicardi, 2005). Louis-Marie Chauvet, illustre teologo, ha precisato che il soggetto del corpo individuale, in cui vengono ad articolarsi simbolicamente in modo altrettanto singolare per ciascuno quanto lo è la storia del suo desiderio, è anche un corpo ancestrale di tradizione, un corpo sociale di cultura e un corpo cosmico di natura. È proprio in quanto intessuto in questo modo originale — a partire dalla sua prima infanzia, dalla sua stessa formazione di matrice materna, che, come è noto, è altrettanto culturale e biologica, tramite questo triplice corpo di storia, di società e di mondo — che il soggetto avviene in ciò che egli è di più spirituale. «Corporeità» designa, in tale senso, il soggetto umano come corpo significante o come corpo di parola: corpo parlante in quanto da sempre già parlante nel ventre materno. Il più «spirituale» non avviene dunque altrimenti che nella mediazione del più «corporeo». Stando all’analisi di Chavet, si può ben intuire che la relazione Stato e corpo s’impossesserà, dal mondo antico a quello cristiano, di tutto il pensiero medievale, come, in seguito, ha ben chiarito lo storico Le Goff (Chavet, 1995; Le Goff, 2007). A titolo d’esempio, basterà citare Giovanni di Salisbury (1159), nel Policraticus,10 il quale dà una definizione esemplare, a giudizio dello stesso Le Goff, della relazione fra il corpo e lo Stato:
Lo Stato è un corpo. Il principe occupa nello Stato il posto della testa, è sottomesso al Dio unico e a coloro che sono i suoi vicari in terra […] Il senato occupa il posto del cuore […] La funzione degli occhi, delle orecchie e della lingua son svolte dai giudici e dai governanti delle province. Gli ufficiali e i soldati possono essere paragonati alle mani. I consiglieri del principe sono i fianchi. I questori e i cancellieri […] ricordano il ventre […] I piedi costantemente aderenti al terreno sono i contadini (Le Goff, 2007).
Accenni di paideia greca del corpo: un caso emblematico
Analizzare metaforicamente il corpo, come si è tentato qui di proporre, pur nella brevità, aiuta a impostare un ragionamento sull’essenzialità della presenza del corpo umano anche al tempo dell’artificiosità. Appare evidente che anche la contemporaneità non potrà mai fare a meno della paideia corporea, cioè di quella specifica dimensione paidetica che è stato il modello educativo greco e che ha influenzato, da quel momento in poi, un determinato atteggiamento educativo occidentale. Dai greci in avanti, passando per il medioevo occidentale, possiamo consapevolmente dire che il corpo, in quanto macchina semantica e metaforica, non è solo circoscritto all’interno e all’esterno della propria epidermide, ma è un trasmettitore di senso ben oltre i propri limiti visibili, come precisato in più contesti, da Paolo Benanti, fra i più noti esperti italiani di IA. L’incorporazione, dunque, non vuol dire avere scarso interesse per l’IA simbolica, come, ad esempio, ipotizzato da Margareth A. Boden, nel suo volumetto Intelligenza artificiale (Boden, 2019), ma vuol dire avere consapevolezza che la macchina corporea è così intrinsecamente e naturalmente portatrice di tecnologie e simboli, che nessuna artificiosità aggiuntiva o nessun algoritmo potranno mai sostituire quella rilevanza dotata di autonomia, di autorganizzazione, di adattamento e di evoluzione, di riproduzione e, soprattutto, di coscienza. Qui il discorso non è di stampo morale e non si ritiene neanche urgente procedere con la definizione dell’interazione corpo, mente e cervello; bensì mettendo la corporeità al centro del nostro ragionamento si può ben dire che essa è un’oggettiva presa di consapevolezza su come il corpo, pedagogicamente inteso, sia un congegno sofisticatissimo di metaforizzazioni create nel tempo, nello spazio e (non da ultimo) perfino nell’abito. Le vesti sono il terzo elemento, accanto al binomio spazio-temporale, che concorre alla definizione di corpo come macchina portatrice di senso e di metafore. L’abito, infatti, è chiamato a difendere il corpo dal mondo, ma anche a esporlo e a soddisfare il senso della vanità o del pudore: «Ciò che il pudore difende non è lo spirito dalla volgarità del corpo, ma la vita del corpo dall’inerzia della carne, la soggettività di un corpo vivente dalla penosa oggettivazione di una carne posseduta» (Galimberti, 2010). La società contemporanea, nel suo orizzonte liquido, ha alterato ogni simbologia e l’abito si è trovato a essere una delle tante componenti di uniformità e appiattimento, perdendo la specificità del suo ruolo all’interno di «un’avventura etnica» (Leroi-Gourhan, 1977). Eppure, nonostante la perdita di specificità, l’abito ha mantenuto il suo ruolo identitario nell’erotismo, ulteriore elemento centrale nella definizione corpo come macchina metaforica. L’erotismo, richiamando alla memoria sensazioni archetipiche date dall’aderenza degli abiti al corpo, produce, per esempio, un centro di gravità narrativa che è ben al di là del processo binario dell’IA. Potrà questa spiegarne i meccanismi? Forse sì, ma non sarà in grado di incorporarli. Nel rapporto abito-eros si ritrova quella dimensione ludica di cui parla Sartre, dove si ritiene che l’abito modifichi le singole identità biopsichiche,11 in un processo paragonabile a un possibile Giano bifronte, che crea e, al tempo stesso, modifica l’io nel corpo (Sartre, 1963). Siamo dunque, ancora una volta, dinanzi alla stessa ineludibile domanda: la macchina corporea ci tutela o ci lascia in balia del rischio che l’IA trasformi il nostro mondo, al punto di diventare insostituibile come l’abito lo è per il corpo? Dobbiamo bandire l’IA o renderla uno strumento essenziale per «muoversi» nella vita? Una giusta moderazione può salvarci tanto dagli apocalittici quanto dagli integrati. È evidente che essere moderati, in questo campo, significa anche sapersi difendere dall’illusione che gli aspetti umanoidi siano presenze umane: Siri o Alexa sono due esempi notevoli per capire che in questi strumenti non è di troppo soltanto il corpo, ma perfino l’io è spodestato. In conclusione, si potrebbe ritenere giusto, prima di fare ogni ragionamento sul corpo in relazione all’IA, definire che cos’è «corpo», che cos’è «intelligenza» e se questo binomio si presta alla sovrapposizione fra naturale e artificiale. Fin qui, intanto, si è tentato di racchiudere il corpo in definizioni, per l’intelligenza, invece, si sono censite una settantina di definizione, grazie al lavoro di Shane Legg e Marcus Hunter. Eppure, la definizione sembra ancora opaca. Un dato potrebbe ritenersi utile da sottolineare: all’intelligenza non chiediamo solo di sviluppare un pensiero astratto, ma ci aspettiamo anche saggezza. Questa richiesta non può essere rivolta all’IA senza la considerazione del corpo, della sua interazione con l’ambiente e la società, senza la collaborazione della mente (Legg e Hutter, 2007).
Bibliografia
Agamben G. (2019), L’uso dei corpi, Vicenza-Milano, Neri Pozza.
Arendt A. (2009), La vita della mente, Bologna, il Mulino.
Barthes R. (1991), Il sistema della moda, Torino, Einaudi.
Bauman Z. (2002), Il disagio della post-modernità, Milano, Arnoldo Mondadori Editore.
Benanti P. (2016), La condizione tecno-umana. Domande di senso nell’era della tecnologia, Milano, EDB.
Benanti P. (2018), Le macchine sapienti. Intelligenze artificiali e decisioni umane, Torino, Marietti.
Boden M. (2019), L’intelligenza artificiale, Bologna, il Mulino.
Cavavero A. (1995), Corpo in figure. Filosofia e politica della corporeità, Milano, Feltrinelli.
Caserta A, Il corpo politico. Corpo, Dike. Comunicazione fra Agamennone e Pericle, Bologna, Emil.
Cerri G. (a cura di) (1999), Iliade, Milano, Rizzoli.
Chauvet L.M. (1995), La liturgia e il corpo, «Concilium», vol. 3.
Cianci D. (2014), Corpi di parole. Descrizione e fisiognomica nella cultura greca, prefazione a cura di G. Tognon, Pisa, Edizioni ETS.
De Kerckhove D. (2011), Il sapere digitale, Napoli, Liguori.
Deleuze G. e Guattari, F. (2012), Macchine desideranti. Capitalismo e schizofrenia, Verona, Ombre Corte.
Ducci E. e Costa C. (2021), Sui temi dell’umano. Il concreto umanarsi per una filosofia dell’educazione, Roma, Anicia.
Galimberti U. (2010), Il corpo, Milano, Feltrinelli.
Goertzel B, e Wang P. (2007), Advances in Artificial General Intelligence. Concept, architectures and algorithms, Amsterdam, IOS Press.
Legg S. e Hutter M. (2007), A collection of definition of intelligence. In B. Goertzel, e P. Wang (a cura di), Advances in Artificial General Intelligence, Amsterdam, IOS Press, pp. 17-24.
Leroy Gourahan A. (1977), Il gesto e la parola, Torino, Einaudi.
Le Goff J. (2007), Il corpo nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza.
Manicardi L. (2005), Il corpo, Magnano, BI, Edizioni Qiqajon.
Ong W.J. (1986), Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Bologna, il Mulino.
Popper K. ed Eccles J. (1981), L’io e il suo cervello. Strutture cerebrali, Roma, Armando Editore.
Reale G. (1999), Corpo, anima, salute. Il concetto di uomo da Omero a Platone, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Sartre J.P. (1963), Critica della ragione dialettica, Milano, Il Saggiatore.
Schmitt J.C. (2001), Le corps, le rites, le reves, le temps. Essais d’antropologie médiéval, Parigi, Gallimard.
Settis S. (1997), I Greci. Storia cultura arte e società. Vol. 1 Noi e i Greci, Torino, Einaudi.
Tognon G. (2014), Est-etica. Filosofia dell’educare, Editrice la Scuola, Brescia.
Vegetti M. (2023), L’io, l’anima, il soggetto, Pistoia, Petite Plaisance.
-
1 Libera Università Maria SS. Assunta, Roma.
-
2 Libera Università Maria SS. Assunta, Roma.
-
3 La traduzione è in parte personale, in parte riprende quella del celebre grecista Giovanni Cerri (Cerri, 1999).
-
4 La scrittura veniva definita, dal filosofo, disumana, solo perché ricreava fuori dalla mente quello che poteva esistere solo al suo interno: era accusata, soprattutto, di distruggere la memoria, perché chi la usava avrebbe smesso di ricordare. Lo stesso scetticismo ci fu con l’avvento della stampa, poi con i computer e le nuove tecnologie e oggi con l’IA.
-
5 Da qui in avanti, nel testo, si indicherà, in maniera abbreviata, l’intelligenza artificiale.
-
6 La bibliografia sulla relazione corpo e intelligenza artificiale è già abbastanza corposa, ma qui intendiamo, invece, avvalerci di pochi testi, necessari per iniziare a impostare il discorso sulla centralità eterna dei corpi, partendo dal disagio degli stessi vissuto ai tempi della post-modernità (Bauman, 2022) per poi risalire fino al mondo antico, in particolare quello greco, che aveva individuato nel corpo un parametro essenziale per la presentazione della loro stessa società. In un precedente lavoro di ricerca, condotto con la guida scientifica di Giuseppe Tognon (Cianci, 2014), si è inteso precisare come la società greca abbia avuto il merito di aver intuito la rappresentazione (ekphrasis) dei corpi e il relativo principio della visibilità, facendo di questi due elementi, legati al corpo, un vero e proprio centro di potere. La poietica legata ai corpi e il loro ritratto ecfrastico-descrittivo rendono, in questo senso, eternamente inespungibile il corpo e la categoria della corporeità, ben al di là della sofisticazione digitale. Per ulteriori approfondimenti si segnala la prefazione al testo di Cianci a cura di Tognon (Cianci, 2014, pp. 9-15): «Giorgio Agamben nel suo saggio L’uso dei corpi ha analizzato molto bene la sopravvivenza della concezione aristotelica dei corpi animati e inanimati che, in relazione con l’idea di schiavitù, consentiva ai Greci di usare del proprio corpo e di quello degli altri in maniera molto più articolata di quanto noi oggi si faccia, una volta malamente ridotta la corporeità a una sorta di residuo non smaltibile della soggettività o a specchio del narcisismo» (Tognon in Cianci, 2014, p. 13).
-
7 Per comprendere la relazione fra la metafora e il corpo, si rimanda a un’analisi introduttiva fornita in Cianci 2014, dove si specifica come la metafora derivi da un processo psichico e linguistico di associazione mentale di due differenti realtà accomunate da una base simbolica. Arendt, partendo dal mondo greco, ha posto in evidenza ancora una volta come la metafora sia il fondamento del pensiero, capace di rendere visibile l’invisibile ed essa è divenuta un’immagine mentale, nel senso che siamo capaci di usarla per dare dei contorni anche a cose che non esistono. La principale simbolizzazione e metaforizzazione del corpo è la sua relazione con la scrittura ed è stata studiata anche in Variazioni sulla scrittura da Barthes, il quale intuisce come il corpo che scrive è già un corpo autonomo che è stato inscritto in un sistema di segni che tentano di conferire un senso e un’unità alla frammentarietà (Barthes, 1999). In Grecia la scrittura determina l’avvento di una nuova forma corporea, il testo e il corpus di testi, un patrimonio che appartiene solo all’uomo pensante (infatti gli dei e gli eroi, con i loro corpi ultraterreni, non scrivono nulla!): dal momento che la scrittura prolunga il corpo è soggetta a un’etica. Il corpo, con la sua visibilità, scrivente o meno, si declina in un ruolo traslato e mediato da una profonda concettualizzazione, pronta a rivelare aspetti non immediatamente comprensibili che si manifestano nella dimensione del tempo, nella società e nel compito assegnato all’abito, prima ancora che nella scrittura.
-
8 https://www.vita.it/eric-sadin-stiamo-in-guardia-dalla-tecnologia-antiumana-e-dalla-data-driven-society/ (consultato il 27 ottobre 2025).
-
9 Qui il discorso andrebbe notevolmente approfondito, ma ci porterebbe lontano dalla nostra riflessione sul corpo come macchina metaforica.
-
10 Per ulteriori approfondimenti si veda Schmitt (2001).
-
11 Termine qui riformulato e distante, invece, dal biopsichismo, termine forgiato nel 1982 da Ernst Haeckel, ritiene che ogni organismo sia capace di provare dolore, piacere ed emozioni.
Vol. 2, Issue 2, October 2025