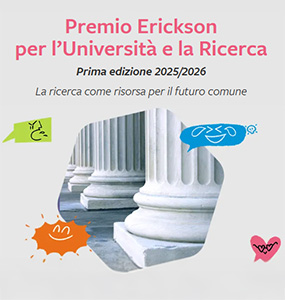Vol. 2, n. 1, aprile 2025
Autobiografie giovanili. Marcare le proprie tracce
Lara Balleri1
Sommario
Testimoniare la propria presenza, lasciare un segno e dar forma ai propri ricordi. Sono molteplici le forme di espressione di sé, così come i linguaggi che ad esse si associano e che consentono di collegare l’uno a tanti, l’interno con l’esterno. Tra i generi letterari, la biografia è quella che più si concentra sull’individuo configurando una disciplina che ispira e sfida costantemente chi cerca e coltiva la consapevolezza della pluralità delle dimensioni umane (Palumbo e Garbarino, 2006). Scrivere la propria autobiografia, in particolare, permette all’autore di collegare pensato e scritto, passando attraverso il riflettuto; questa facoltà, propria di una scrittura riflessiva (Schön, 1993; Dewey, 2019), rende il genere letterario dell’autobiografia squisitamente orientato alla cura della persona (Cambi, 2005) e mette a disposizione di ogni lettore un ampio catalogo di storie di vita, da leggere in ottica di formazione di sé. Raccontare la propria storia e accedere alle autobiografie degli altri fa sì che si costruiscano sia identità che appartenenza, ma anche si impari a tenere insieme i diversi contesti nei quali ci si racconta. In questa sede s’intende proporre una strategia che attraverso l’autobiografia possa supportare i giovani nella costruzione di sé e nella comprensione delle specificità valoriali del trinomio privato-pubblico-condiviso; rientra tra le premesse la volontà di rispettare la funzione identitaria dei loro linguaggi e tra gli obiettivi quello di supportare i giovani nella costruzione di un filo che consenta loro di trovarsi e ritrovarsi, pluridimensionali come sono, tra dimensione online e offline.
Parole chiave
Autobiografia, fotografia, generazione Z, onlife.
Youth autobiographies. Marking one’s own path
Lara Balleri2
Abstract
Testifying to one’s presence, leaving a mark, and shaping one’s memories. There are numerous forms of self-expression, each accompanied by languages that facilitate the connection of the individual to the collective, the internal to the external. Among literary genres, biography is the one most focused on the individual, establishing a discipline that continually inspires and challenges those who seek to cultivate an awareness of the plurality of human dimensions (Palumbo & Garbarino, 2006). Writing one’s autobiography, in particular, allows the author to link thought and writing through reflection; this capability, characteristic of reflective writing (Schön, 1993; Dewey, 2019), renders the genre of autobiography particularly suited to the care of the self (Cambi, 2005). It provides readers with a vast repository of life stories, available for their own self-development. Narrating one’s story and accessing the autobiographies of others enables the construction of both identity and belonging, while also fostering the ability to reconcile the diverse contexts in which one narrates oneself. This paper proposes a strategy that, through autobiography, can support young people in their self-construction and in understanding the specific value dimensions of the private-public-shared triad. The underlying premise is the intent to respect the identity-forming function of their languages, with the objective of aiding young people in weaving a thread that allows them to discover and rediscover themselves, in all their multidimensionality, across both online and offline realms.
Keywords
Autobiography, photography, Generation Z, onlife.
Introduzione
Nel presente contributo si intende esplorare come le pratiche autobiografiche, con particolare attenzione all’uso della fotografia, possano supportare i giovani nella costruzione di sé e nella comprensione delle specificità valoriali del trinomio privato-pubblico-condiviso. Si vedrà come i linguaggi della contemporaneità, influenzati dalla digitalizzazione e dall’interconnessione costante, plasmino le interazioni e le modalità con cui gli individui esprimono e percepiscono sé stessi. Si cercherà di proporre strategie educative che rispettino la funzione identitaria dei linguaggi giovanili, favorendo la costruzione di un’identità coesa tra dimensione online e offline. Grazie al contributo di diversi autori e studi, si affronterà il tema della narrazione autobiografica come strumento di cura della persona e formazione di sé, evidenziando il ruolo della fotografia e delle nuove tecnologie in questo processo.
Nuove forme di espressione di sé
I linguaggi della contemporaneità plasmano le interazioni e influenzano profondamente le modalità con cui gli individui esprimono e percepiscono sé stessi. Queste forme di espressione non si limitano a veicolare contenuti, ma modellano le relazioni sociali e le identità personali. Luciano Floridi (2017) ha parlato di «quarta rivoluzione», in cui la digitalizzazione e l’interconnessione costante trasformano l’esperienza umana alterando il modo in cui le persone interagiscono con il mondo e tra loro. Tale rivoluzione porta con sé una ristrutturazione delle dinamiche sociali e culturali, dove il confine tra realtà fisica e digitale si fa sempre più labile.
I social network, interpretati da giovanissimi, giovani e meno giovani, mostrano chiaramente come i linguaggi della contemporaneità plasmino le interazioni, con una targettizzazione sempre più precisa che trova conferma nei comportamenti degli utenti. Marshall McLuhan evidenziava già negli anni ’60 come il medium influenzi non solo il messaggio, ma anche la percezione e le relazioni tra le persone; questo concetto è ancora più rilevante oggi, in un’epoca dominata dai social network. Sarà anche per questo motivo che i legami che si formano sui social network sfuggono spesso alla piena comprensione della generazione precedente, che ha memoria di vissuti in cui la presenza, i segni e i ricordi trovavano altri spazi per raccontarsi e farsi conoscere: in quel tempo, il muretto era la home e il cortile il gruppo privato. La mancanza di comprensione intergenerazionale, amplificata dall’evoluzione tecnologica, genera preoccupazione e senso di perdita, come rilevato da Cambi (2005), il quale sottolinea come la digitalizzazione ridefinisca non solo le dinamiche sociali, ma anche i rapporti tra le generazioni. Questo cambiamento genera nostalgia e preoccupazione, specialmente tra i genitori, che si sentono incapaci di proteggere i propri figli in questo nuovo mondo, accentuando così la distanza generazionale e rischiando di alimentare un’evasione dalla realtà fisica (Galimberti, 2018). Le piattaforme di socializzazione accolgono per fasce di età, così caratterizzate come sono nelle grammatiche che sottostanno la loro grafica, lo stile di comunicazione, le possibilità di interazione, le sollecitazioni della piattaforma agli utenti e, non ultima, la generale risonanza che deve instaurarsi tra utente e rete sociale che lo accoglie e a cui partecipa. Appartiene ai giovanissimi l’abitudine di ignorare i limiti di età di accesso mentendo sulla data di nascita, una bugia bisbigliata tra una tastiera retroilluminata e una home, ma che già si è fatta patto, tra rapide flag e parole di benvenuto. L’evasione dal mondo adulto, come notato da Demetrio (1996), coincide spesso con l’evasione dal mondo offline, una tendenza che si osserva nei più giovani, i quali trovano nei social network spazi di aggregazione che sfuggono al controllo e alla supervisione degli adulti. Si viene così a creare un ambiente di massima esposizione per i giovani, nel quale l’agenzia educativa familiare fatica a inserirsi, complice la nuova gerarchia che in adolescenza vede il gruppo sociale delle amicizie prevalere sulla famiglia nel dettare norme comportamentali e priorità valoriali. Come evidenziato da Floridi (2017), i social network diventano luoghi privilegiati per la costruzione dell’identità e della narrazione di sé, dove i giovani non solo si esprimono ma cercano anche riconoscimento e appartenenza. La partecipazione ai social media, quindi, si configura non solo come un’attività ricreativa, ma come una vera e propria dimensione esistenziale, dove si costruiscono e si mantengono relazioni sociali, si condividono esperienze e si definisce la propria identità.
La complessità di questa partecipazione richiede una specifica alfabetizzazione digitale, che non si limiti certo all’uso tecnico degli strumenti includendo piuttosto la capacità di navigare criticamente e responsabilmente nelle dinamiche sociali online. Come evidenziato dalle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 2018, è essenziale sviluppare competenze nuove e più evolute, come testimonia il passaggio da competenza informatica (2006) a competenza digitale (2018). Il Consiglio d’Europa ha così ratificato una più complessa configurazione della figura di utilizzatore di internet, che deve conoscere le dinamiche sottese alle piattaforme in cui si muove e alle quali partecipa, fino a concepire un diverso concetto di «partecipazione». Vediamo infatti che la partecipazione di cui si parlava nel 2006 indicava l’uso di strumenti online per scambiare informazioni, collaborare e socializzare online attraverso e-mail, forum e documenti condivisi, oltreché accedere alle informazioni e ai contenuti del web grazie all’impiego dei motori di ricerca, mentre nel 2018 è stato introdotto il concetto di «cittadinanza digitale attiva» come movimento a cui partecipa ogni utente del mondo digitale, chiamato a collaborare attivamente non più solo utilizzando strumenti collaborativi online, ma creando contenuti guidato da pensiero critico ed etico. In aggiunta si parla di responsabilità personale e sociale che deve riguardare l’utente di reti sociali, nella consapevolezza di come queste piattaforme influenzino le dinamiche sociali e di come attraverso esse si possa promuovere il cambiamento sociale.
Raccontare con la fotografia
La fotografia non è solo un mezzo per catturare immagini, ma una potente forma di espressione capace di conservare e riflettere la realtà, le esperienze e i ricordi. Questo medium può facilitare un dialogo profondo con il passato, contribuendo alla formazione di un’identità coesa e aiutando gli individui ad affrontare i cambiamenti e le sfide della vita e facilitando un processo di autocomprensione e crescita personale. Roland Barthes nel suo lavoro sulla fotografia sottolinea come ogni immagine fotografica porti con sé una presenza del passato (1980), un legame tra il tempo dell’immagine e quello dell’osservatore; questo punctum, il dettaglio che colpisce e tocca l’osservatore in modo personale, rende la fotografia un potente strumento di connessione emotiva e riflessiva con il proprio passato e con quello degli altri. La fotografia, quindi, non solo cattura un momento, ma stabilisce un ponte tra il presente e il passato, facilitando una continuità narrativa essenziale per la costruzione dell’identità.
Un esempio emblematico di come la fotografia possa consentire l’interazione con il tempo passato e presente è il progetto artistico fotografico intitolato 20.12.53-10.08.04 dell’artista toscana Moira Ricci. Nato dalla volontà di creare un dialogo intergenerazionale visivamente potente tra il passato e il presente, questo progetto le ha permesso di interagire con la madre deceduta anni prima, inserendo sé stessa nelle fotografie che ritraggono la madre negli anni della gioventù, anche precedenti la nascita dell’artista. Questo approccio non si basa sulla produzione di nuove immagini, ma sulla selezione e modificazione di scatti esistenti in post produzione per consentire all’artista di esplorare la propria identità e la storia familiare. La fotografia mostra qui il suo potenziale nel permettere un dialogo continuo con i vissuti propri e altrui, e nel consentire alla persona di ricoprire un ruolo attivo nella loro rielaborazione (Valtorta, 2023).
La fotografia apre anche alla possibilità che la storia di vita di un singolo ne faccia risuonare molte altre, per un particolare o l’intero soggetto; questo aspetto è riconducibile al potere evocativo della fotografia, che sostiene Salati essere in grado di attivare processi riflessivi significativi, che risultano particolarmente utili nei contesti formativi (2021). Di sicuro interesse è il caso di Vivian Maier che visse fino al 2009 tra New York e Chicago, dove lavorò come tata e governante dando vita a un insospettato archivio di tracce fotografiche; anni dopo la sua morte, infatti, si scoprirono migliaia di fotografie di vita quotidiana da lei scattate che oggi garantiscono l’accesso a uno straordinario reportage che si offre a molteplici letture. La raccolta documenta i cambiamenti sociali e culturali che hanno caratterizzato il periodo tra gli anni ’50 e ’90 del secolo scorso, ritraendo temi come la segregazione razziale, i movimenti per i diritti civili e le disuguaglianze sociali ed economiche. In termini educativi questo fornisce l’opportunità di immaginare le storie di vita testimoniate dalle tracce che lasciano; riflettere sulle storie degli altri, oltre ad avere un valore straordinario in sé, fatto di memoria, empatia e comprensione, può anche servire per costituire una crescente consapevolezza di quanto ciascuna traccia dica di noi e quanto si apra a interpretazioni molteplici, specie se non accompagnata da un testo esplicativo.
Il rapporto tra fotografia e cambiamento è esplorato e testimoniato dal Photovoice, una metodologia di ricerca partecipativa che combina la fotografia con la narrazione personale e la ricerca sociale permettendo alle persone di documentare e riflettere sulle proprie esperienze, specie in relazione a tematiche sociali o comunitarie (Santinello, Surian e Gaboardi, 2022). Sviluppato da Caroline Wang e Mary Ann Burris, poi ripreso in Italia, tra gli altri, da Elisabetta Ruspini, Andrea Galimberti e Federico Batini con progetti di taglio sociologico, psicologico e pedagogico, Photovoice prevede che le immagini scattate dai partecipanti siano poi utilizzate per stimolare discussioni e promuovere la consapevolezza sociale. Questa metodologia implica il coinvolgimento della comunità di riferimento che ha così un peso notevole sull’autenticità degli scatti fotografici raccolti (Santinello, Surian e Gaboardi, 2022). Con giovani protagonisti, l’uso di questo metodo potrebbe aprire la porta anche a discussioni sul ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e sul modo in cui essa influenzi la percezione di sé e degli altri; Photovoice, inoltre, prevede la realizzazione dell’intervento sociale attraverso il coinvolgimento dei decisori politici, affinché abbia luogo un concreto cambiamento a livello sociale: una preziosa opportunità di partecipazione attiva.
La fotografia nel suo essere strumento potente e versatile, come visto, facilita la riflessione sulle esperienze personali e collettive. La narrazione fotografica può così considerarsi un mezzo utile per tenere insieme i vissuti, siano essi online od offline, in contesti personali o sociali e può rappresentare una risorsa per navigare questa complessità.
Si capisce come il processo di narrazione attraverso la fotografia contribuisca alla formazione di un’identità integrata e complessa, capace di gestire le diverse sfaccettature dell’esistenza moderna. Duccio Demetrio sottolinea come la narrazione autobiografica aiuti a fare memoria del passato e permetta anche di ri-significare il presente e progettare il futuro, creando una continuità tra le diverse fasi della vita (Demetrio, 1996).
Raccontarsi social
Sappiamo che quello di raccontare è per l’individuo un istinto naturale e un bisogno nell’espressione del quale si è portatori di un proprio universo narrativo, linguistico e culturale. Jonathan Gottschall considera la narrazione un impulso innato, radicato nell’evoluzione della specie umana, che ci ha resi capaci di dare senso al mondo e alle nostre esperienze (2013). Siamo in grado di riconoscere che quelle che i giovani lasciano oggi sui social network sono tracce, impronte, segni del loro passaggio, espressione di loro stessi, manifesto del loro esistere; non soltanto si raccontano ma si tengono in contatto e, oggi molto più degli adolescenti di un tempo, comunicano la propria vita e ascoltano quelle degli altri. In questo contesto, emerge il concetto di «tribù digitale», derivato dalle teorie di Michel Maffesoli sul neo-tribalismo (1988), che descrive come i giovani si aggregano online in comunità basate su interessi, passioni e valori condivisi; queste tribù digitali offrono ai giovani un senso di appartenenza e identità, permettendo loro di esprimersi liberamente e di interagire con pari che condividono le stesse prospettive. Questa forma di comunicazione costante sui social media ha portato alla creazione di una «identità narrativa» (Pellizzoni, 2019), che si sviluppa e si evolve in tempo reale, influenzata dalle interazioni digitali; la preoccupazione delle famiglie, oggi, si è spostata dal far parlare i propri figli a far loro comprendere la responsabilità di raccontare sé stessi e venire in contatto con il racconto di tante altre storie. La narrazione di sé, come evidenziato da Bruner (1992), è centrale nella costruzione del significato personale e collettivo, poiché attraverso la narrazione gli individui non solo organizzano la loro esperienza, ma creano anche una struttura interpretativa che permette di dare senso al proprio vissuto e alle proprie interazioni sociali.
La questione appare articolata e richiede di soffermarsi sulle differenze che sostengono l’identità delle dimensioni pubblico, privato e condiviso che, nonostante siano disponibili in ogni post e profilo sui social network sotto forma di impostazioni, richiedono che ne siano compresi profondamente i fondamenti. Floridi (2017) parla della necessità di un’educazione digitale che permetta di navigare con consapevolezza tra le dimensioni pubblico e privato, particolarmente rilevante in un mondo sempre più interconnesso, nel quale i confini tra questi due spazi sono sempre più sfumati. Siamo di fronte a una concezione di «privato» che non rende un contenuto non-detto, come fosse un pensiero nella mente, ma prevede che questo, seppur in modalità celata, sia comunque pubblicato; occorre prendere consapevolezza del fatto che, in questo modo, i contenuti privati degli utenti finiscono su una piattaforma che di privato ha solo la proprietà, collocata com’è nel web, una rete globale di portata senza precedenti. La generazione Z, in particolare, ha sviluppato un approccio molto più fluido e dinamico alla privacy rispetto alle generazioni precedenti (Boyd, 2014); si tratta dei giovani nati dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso e il 2010 che, dal punto di vista delle loro caratteristiche digitali e comportamentali, sono tecnologicamente più evoluti ma non altrettanto preparati ad affrontare le sfide significative della vita adulta (Twenge, 2018). Le tribù digitali amplificano questo fenomeno, poiché i giovani condividono informazioni personali all’interno di queste comunità virtuali, spesso senza piena consapevolezza delle implicazioni sulla privacy e sull’identità personale. Le osservazioni che si sollevano sottolineano l’importanza di educare e supportare questa generazione affinché possa sviluppare le competenze necessarie per affrontare il futuro all’insegna di un uso più equilibrato della tecnologia (Twenge, 2018).
Attraverso i social e la selezione dei contenuti da rendere pubblici, infatti, si generano biografie personali che delineano un’immagine concreta del nostro sé da restituire ai nostri contatti online (Cava, Penna e Pizzimenti, 2021). Vivere online implica un’interazione costante con nuove forme di espressione di sé, come i selfie e la modalità reel, che trasformano il modo in cui lasciamo traccia del nostro passaggio nel mondo; queste nuove forme di narrazione, prevalentemente ma non esclusivamente visive, rafforzano la percezione di autenticità delle esperienze condivise amplificando anche la portata della costruzione identitaria. Abbiamo visto come la narrazione faciliti la costruzione di significati e l’attribuzione di senso agli eventi della vita permettendo alle persone di integrare le loro esperienze in un quadro coerente (Lagreca, 2017). Ciononostante la narrazione, per sua natura, non è intrinsecamente un gesto riflessivo, ma può diventarlo quando viene utilizzata come strumento per esaminare e comprendere le proprie esperienze (Mancino, 2012). La narrazione acquisisce una dimensione riflessiva nel momento in cui l’individuo, attraverso il racconto di sé, prende distanza dalle proprie esperienze, trasformandole in oggetto di riflessione; questo distanziamento permette di stabilire connessioni tra pensieri ed esperienze, mediando tra l’adesione emotiva e il necessario straniamento per una comprensione critica del vissuto. La narrazione personale può divenire mezzo potente per comprendere e gestire le identità multiple che caratterizzano la contemporaneità (Storti e Bitasi 2021), facilitando un’integrazione armoniosa tra le diverse sfaccettature dell’esistenza online e offline. Se i luoghi fisici sono costituiti dal territorio nel quale viviamo, i flussi elettronici consistono nella grande quantità di informazioni digitali che ci scambiamo quotidianamente grazie a un collegamento internet (Prunesti e Lalli, 2011). I social network, figli del web 2.0. e compresi nel più vasto ambito dei social media, devono il loro successo alla capacità di sviluppare community; risulta cioè sancita una nuova forma di socialità che tende a integrarsi e non a soppiantare le tradizionali forme di interazione sociale basate sulla possibilità fisica (De Kerckhove, 1999). Le tribù digitali rappresentano una manifestazione di questa nuova socialità, dove le relazioni si basano su affinità elettive piuttosto che su vicinanza geografica, e dove i giovani possono esplorare e costruire la propria identità in un contesto condiviso. Come evidenziato da Floridi (2017), la vita onlife richiede all’individuo di riconoscere come la tecnologia plasmi le sue interazioni quotidiane e influenzi profondamente la sua esistenza: i giovani, in special modo, vivono a pieno questa modalità onlife, dove la separazione tra queste dimensioni viene meno e i punti di contatto tra le due condizioni sono superati, favorita piuttosto la loro fusione dalla disponibilità e portabilità degli smartphone. Questo aperto passaggio tra i due mondi esige una gestione consapevole delle proprie identità multiple, poiché le esperienze vissute in entrambe le dimensioni contribuiscono alla costruzione di un’identità complessa e sfaccettata. Franco Cambi afferma che la complessità e la coerenza tra queste dimensioni aiutano a formare un’identità integrata e insieme permettono ai giovani di manifestarsi in tutte le loro sfaccettature, mantenendo però una visione d’insieme che li guida verso una comprensione completa e unitaria di sé stessi (2005). Ciò che si condivide traccia i vissuti ed è frutto di una selezione che merita attenzione e riflessione.
Narrazione autobiografica
Riflettere sulle proprie esperienze, specialmente attraverso la scrittura autobiografica, permette all’individuo di sviluppare una comprensione profonda di sé stesso e del proprio percorso di vita (Schön, 1993). La narrazione autobiografica, quindi, può ricoprire un ruolo cruciale nella costruzione del senso di appartenenza e di connessione con gli altri permettendo di consolidare l’identità personale attraverso un processo di riflessione continua e dialogo con sé stessi e con la comunità. Un racconto unitario delle proprie esperienze può consolidare l’identità e creare ponti di comprensione e appartenenza reciproche; raccontare e condividere storie personali diviene anche atto di connessione umana, che supera le barriere tecnologiche e favorisce un senso di comunità e di empatia. Come già sostenuto da Jedlowski (2009), la narrazione, in quanto pratica sociale, connette il personale con il collettivo, creando un tessuto di significati condivisi che arricchisce tanto l’esperienza individuale quanto quella comunitaria, promuovendo una comprensione reciproca e un senso di appartenenza. Si apre così anche una prospettiva educativa di accompagnamento e supporto che vede i giovani come destinatari, dal momento che gli educatori possono utilizzare la narrazione autobiografica come strumento pedagogico per aiutarli a riflettere sulle proprie esperienze, a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e a costruire una visione coerente della propria identità.
Appare strategico rivolgersi a strumenti digitali che facilitino l’avvicinamento alla pratica autobiografica rendendola coinvolgente e significativa ma anche vicina ai linguaggi della generazione digitale. In questo contesto di riflessione sulla propria identità e narrazione personale, è interessante considerare quanto le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale (IA), stiano rivoluzionando il modo in cui costruiamo e condividiamo le nostre narrazioni personali. L’IA, in particolare, offre nuove opportunità per l’autobiografia, rendendo possibile una riflessione critica e una creatività espansa attraverso l’interazione con modelli computazionali avanzati. Secondo Margaret A. Boden (2019), l’IA può stimolare la creatività umana, espandendo le capacità narrative grazie alla sua capacità di suggerire organizzazioni logiche, stilistiche e offrendo feedback immediato sulle bozze. Queste tecnologie possono facilitare un processo di autoesplorazione più profondo, permettendo agli scriventi di riflettere in modo più articolato sui temi personali; inoltre, l’IA può anche aiutare a organizzare il racconto autobiografico in modo coerente, identificando temi ricorrenti e connessioni tra diverse esperienze di vita, che potrebbero non essere immediatamente evidenti al diretto interessato. Tuttavia, l’integrazione dell’IA nella narrazione autobiografica solleva importanti questioni etiche inerenti la privacy dei dati personali, la sicurezza delle informazioni e l’accuratezza degli algoritmi utilizzati, tutte aree che necessitano di attenzione e regolamentazione.
Autobiografia fotografica
L’autobiografia, nelle sue varie forme, è uno strumento potente per la consapevolezza e la crescita personale che si offre attraverso i linguaggi della scrittura, dell’immagine, del teatro ecc., tutti in grado di consentire l’esplorazione del proprio mondo interiore ed esteriore e di sviluppare la competenza riflessiva, così preziosa com’è per navigare nella complessità della vita moderna. Studi recenti hanno dimostrato che l’uso della narrazione nella formazione delle identità online e offline aiuta a mantenere la coerenza tra le varie sfaccettature della persona, evitando l’alienazione (Biscaldi e Matera, 2023; Denicolai, 2014). Ma non solo, si è dell’idea che l’autobiografia possa risultare funzionale a far emergere dai vissuti quotidiani ciò che Mancino indica come «l’alterità nell’abituale» (2012), ovvero significati nuovi che diversamente potrebbero restare celati dal velo di banalità e ripetitività con cui si tende ad archiviare la routine solo vissuta.
Affinché si possa valorizzare a pieno l’esperienza autobiografica nell’ambito educativo, è importante invitare i giovani a esprimersi attraverso un linguaggio che sentono vicino e spontaneo, una voce in linea con il loro sentire. Possiamo proporre loro di realizzare un’autobiografia fotografica, un’autobiografia scritta, un diario oppure anche un diario di viaggio; si tratta di una valutazione che l’educatore deve fare in funzione del gruppo con cui si trova a lavorare, dialogando con chi lo costituisce, affinché vi sia ampio margine di personalizzazione e si assicuri un’attività interessante. In alcuni casi, un’autobiografia scritta potrebbe apparire schiacciante per la sua lunghezza, mentre un reportage di viaggio offrire un’esperienza spazio-temporale finita e appagante. Sappiamo che le forme di narrazione di sé che utilizzano l’immagine come media prediletto sono ampiamente disponibili in modalità onlife: fotografia, anche in modalità selfie, video da postare, storie e reel, filtri che è possibile applicare, ecc. Per questo motivo, avvicinare i giovani all’autobiografia invitandoli a costruirne una di tipo fotografico, con scatti e didascalie, pare essere una proposta dal buon potenziale. Questo processo può essere particolarmente potente in un’epoca in cui l’immagine ha un ruolo predominante nella comunicazione e nella costruzione dell’identità e con l’intento di coinvolgere i giovani nell’esplorare e comunicare le proprie esperienze in modo visivamente significativo; inoltre, attraverso la selezione delle immagini e la creazione delle didascalie, si ha l’opportunità di riflettere su chi si è, su come ci si vede e su come si desidera essere visti dagli altri. Questo metodo, infatti, attiva la parte riflessiva insita nelle parole, ma dà anche ampio spazio alle emozioni che le immagini sanno esprimere in maniera diretta e non mediata. Dal momento che l’autobiografia permette di «frequentare l’altro fuori da sé» (Demetrio, 1995), come persona con cui interagire e alla quale mostrarsi nella propria umanità, lontana da tabù e stereotipi deleteri, possiamo pensare che riflettere tramite immagini non solo faciliti la comprensione e l’integrazione delle esperienze personali, ma promuova anche l’empatia e la consapevolezza sociale; le fotografie e i selfie non sono solo rappresentazioni visive, ma racconti impliciti che catturano momenti significativi, emozioni e contesti culturali. Nel catturare e conservare la realtà, le esperienze, i ricordi e la quotidianità, la fotografia mostra la sua concretezza e tangibilità; rende possibile rivisitare e riflettere sulle proprie esperienze nel tempo, un aspetto determinante per la formazione di un’identità coesa e per la capacità di affrontare i cambiamenti e le sfide della vita. Diverse applicazioni per smartphone si prestano a mostrare l’aderenza che l’autobiografia può avere alle abitudini digitali della Generazione Z. Si tratta di App, ovvero applicazioni che consentono ai dispositivi mobili di svolgere funzioni specifiche (Prunesti e Lalli, 2011), come Find Penguins e Universum, che permettono di creare autobiografie fotografiche e di viaggio in modo particolarmente intuitivo. Find Penguins consente di creare un diario di viaggio digitale, dove aggiungere foto, note e itinerari potendo anche condividere automaticamente i progressi attraverso i social media; ciò rende il racconto di sé non solo pratica personale, ma anche attività sociale e comunitaria. Con la app Universum, invece, è possibile creare storie personali che includono non solo testi e immagini, ma anche video e registrazioni audio, una multi-modalità che genera una rappresentazione più completa e sfaccettata delle proprie esperienze, con positive ricadute sul coinvolgimento emotivo e su una comprensione più profonda di sé stessi. Inoltre si tratta di App integrate con le principali piattaforme di social network, aspetto che rende più rapido e pratico il recupero e la valorizzazione di quanto condiviso online, da integrare con materiale offline, per esempio scatti fotografici ottenuti con il proprio smartphone. Queste specifiche agevolano l’azione autobiografica e, non di meno, si ritiene sollecitino il senso di continuità onlife, che richiede tanto di vivere quanto di condividere responsabilmente.
Spazio educativo onlife
Promuovere l’autobiografia nelle scuole può aiutare i giovani a elaborare le proprie esperienze, a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e a sentirsi parte di una comunità onlife. Secondo Palumbo e Garbarino (2006), l’autobiografia permette di collegare l’interno con l’esterno, facilitando un dialogo che può alleviare il senso di isolamento e promuovere un benessere psicologico. In particolare, l’integrazione delle dinamiche identitarie e metacognitive in uno spazio educativo onlife rappresenta una sfida e un’opportunità (De Mutiis e Pomponi, 2023).
La scuola ha il dovere di restare contemporanea, pur essendo portatrice di cultura e conoscenze che affondano le radici in altre epoche. Parlare il linguaggio della modernità permette agli studenti di sentirsi compresi e sostenuti nel percorso di crescita. Come afferma Lizzola: «[...] una scuola contemporanea deve essere in grado di rispondere ai bisogni dei giovani, parlando il loro linguaggio e utilizzando le tecnologie e i mezzi di comunicazione a cui essi sono abituati» (2018). La narrazione di sé nel contesto scolastico può anche svolgere una funzione preventiva del disagio giovanile, dal momento che questo è spesso correlato a una mancanza di comunicazione efficace e di supporto emotivo (Carli e Giovagnoli, 2010). L’impatto positivo delle pratiche narrative sul benessere degli studenti è evidenziato anche Batini e Bartolucci che sostengono come l’uso della narrazione nelle scuole faciliti non solo l’apprendimento ma anche la crescita emotiva, migliorando le relazioni educative e promuovendo il benessere complessivo degli studenti (2018).
Di fronte alle molteplici forme che può assumere l’autobiografia, l’insegnante dovrà riflettere sul suo ruolo in qualità di sostenitore nel percorso autobiografico dello studente, chiamato ad aiutarlo nel familiarizzare con la complessità e accettarla (Schön, 1993). Dialogo e ascolto devono costituire la grammatica delle responsabilità dell’educatore; in questo senso, si comprende come la comunicazione vada concepita come vero e proprio «[...] atto di cura» (Borgna, 2001), poiché proprio attraverso il dialogo empatico e la condivisione delle esperienze personali si costruiscano relazioni significative che possano fungere da sostegno emotivo per i giovani. Prevedere l’ascolto delle narrazioni personali degli studenti può avere un effetto terapeutico, contribuendo a creare un ambiente scolastico più inclusivo e accogliente (Borgna, 2017). Autobiografia e documentazione possono trovare un interessante connubio nel contesto scolastico, grazie alle Linee guida per l’orientamento del MIM (2023) e alla Piattaforma digitale unica per l’orientamento, che invitano gli studenti a selezionare gli elementi più significativi del loro percorso legandosi anche alle competenze cosiddette «di vita». L’inclusione delle pratiche autobiografiche nel curriculum scolastico può quindi supportare gli studenti nello sviluppo di una narrativa coerente della propria vita facilitando la costruzione dell’identità e valorizzando l’integrazione delle esperienze di apprendimento di tipo formale e informale.
Ma l’azione educativa non si ferma qui, dal momento che gli educatori devono essere chiamati non solo a sostenere i giovani nella pratica autobiografica, ma anche a educarli al valore delle storie altrui. Attraverso la narrazione, i giovani possono trovare corrispondenze tra il loro vissuto e quello degli altri, scoprire che non sono soli nelle loro esperienze e trarre ispirazione dalle vite altrui. Considerare le storie che li circondano e riconoscere che molte esperienze sono comuni a molti, condivise, è parte integrante di quell’educazione civica che può scegliere di servirsi della pratica autobiografica. Questo processo di riconoscimento reciproco rafforza il senso di appartenenza a una comunità più ampia e costruisce fiducia in sé stessi e negli altri, gettando le basi per una responsabilità personale e collettiva; ciò implica l’esercizio di competenze personali e sociali che aiutano gli studenti a comprendere meglio sé stessi e il loro posto nel mondo. Infine, è importante sottolineare l’importanza di educarsi alla memoria, dal momento che, seppur appaia paradossale rispetto ai nuovi spazi di memoria offerti dalla modalità cloud, non è mai stato così facile dimenticare (Biffi, 2012). Ciò è dovuto sia alla sovrabbondanza di informazioni in cui siamo sommersi sia alla possibilità che si sovrascrivano alle precedenti per via del loro rapido avvicendarsi. Come scrive Biffi: «Ricordare è una competenza cui ci si deve formare, alla luce delle recenti implicazioni che l’attività della memoria va assumendo» (2012). Il filo temporale della memoria consente infatti alla narrazione di mantenere significato: in questo modo «[...] raccontando possiamo allinearci al tempo, riconquistare la natura processuale degli avvenimenti, esercitare quel pensiero critico che ci impone di interrogare il senso di ciò che accade e di ciò che facciamo» (Biffi, 2012). La fotografia dialoga anche con questa esigenza confermando un potenziale educativo che vale la pena continuare a esplorare.
Conclusioni
Le tracce che i giovani lasciano oggi, attraverso parole e immagini, raccontano storie di identità in evoluzione, immerse in una realtà dove i confini tra online e offline si fondono. La fotografia, come forma di autobiografia, diventa un ponte tra passato e presente, permettendo di esplorare sé stessi e il mondo in cui si è immersi. Attraverso questa pratica, i giovani possono costruire un filo che collega le diverse dimensioni della loro vita e avere uno strumento per navigare la complessità dell’era digitale.
È essenziale che educatori e comunità riconoscano il valore di queste espressioni, integrandole nei percorsi formativi e sostenendo i giovani nel processo di autocomprensione. Promuovere la narrazione autobiografica non solo favorisce la costruzione di un’identità coesa, ma rafforza anche il senso di appartenenza e connessione con gli altri. In un mondo dove le informazioni sono sovrabbondanti e la memoria rischia di disperdersi, aiutare i giovani a marcare le proprie tracce diventa un atto educativo fondamentale, che li accompagna nella crescita personale e nella partecipazione attiva alla società onlife.
Bibliografia
Barthes R. (1980), La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, Einaudi.
Batini F. e Bartolucci M. (2018), Narrazione e benessere scolastico. Percorsi e strumenti per migliorare l’apprendimento e la relazione educativa, Trento, Erickson.
Biffi E. (2012), Pratiche narrative per educare. Piccoli, grandi narratori crescono. In Demetrio D. (a cura di), Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, la cura, Milano, Mimesis, pp. 71-116.
Biscaldi A. e Matera V. (2023), Social media e politiche dell’identità, Milano, Ledizioni Ledipublishing.
Boden M.A. (2019), Intelligenza artificiale, Bologna, il Mulino.
Borgna E. (2001), Le emozioni ferite, Milano, Feltrinelli.
Borgna E. (2017), Parlarsi. La comunicazione perduta, Torino, Einaudi.
Boyd D. (2014), It’s complicated. La vita sociale degli adolescenti sul web, Roma, Castelvecchi.
Bruner J. (1992), La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Torino, Bollati Boringhieri.
Cambi F. (2005), Cura di sé e pratiche autobiografiche. Il «doppio legame». In Sarsini D. (a cura di), Percorsi dell’autobiografia tra memoria e formazione, Milano, Edizioni Unicopli, pp. 39-51.
Carli R. e Giovagnoli F. (2010), Psicologia del disagio giovanile, Bologna, Il Mulino.
Cava E., Penna A. e Pizzimenti A. (2021), Nuove frontiere della pedagogia sociale, Milano, FrancoAngeli.
Consiglio d’Europa (2006), Raccomandazioni del Consiglio del 18 dicembre 2006, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
(consultato il 16 agosto 2024).
Consiglio d’Europa (2018), Raccomandazioni del Consiglio del 22 maggio 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
(consultato il 16 agosto 2024).
De Kerckhove D. (1999), L’intelligenza connettiva. L’avvento della Web Society, Roma, FilmAuro.
De Mutiis E. e Pomponi M. (2023), Per uno spazio pedagogico onlife. Dinamiche identitarie e implicazioni metacognitive, «Scienze Pedagogiche», Edizioni Studium, pp. 338-349.
Demetrio D. (1995), Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Milano, Raffaello Cortina.
Denicolai L. (2014), Riflessioni del sé. Esistenza, identità e social network, «Media Education», pp. 164-181.
Dewey J. (2019), Come pensiamo, Milano, Raffaello Cortina.
Floridi L. (2017), La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, Raffaello Cortina.
Galimberti U. (2018), La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo, Milano, Feltrinelli.
Gottschall J. (2013), L’istinto di narrare. Come le storie ci hanno reso umani, Torino, Bollati Boringhieri.
Jedlowski P. (2009), Il racconto come dimora. «Heimat» e le memorie d’Europa, Torino, Bollati Boringhieri.
Lagreca A. (2017), La narrazione come processo di facilitazione del sapere, [s.l.], Edscuola.
Lizzola I. (2018), Pedagogia dell’incontro e della speranza, Assisi, Cittadella Editrice.
Maffesoli M. (1988), Il tempo delle tribù. Il declino dell’individualismo nelle società di massa, Roma, Armando.
McLuhan M. (1967), Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore.
Mancino E. (2012), Narrare con altri linguaggi. In Demetrio D. (a cura di), Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, la cura, Milano, Mimesis, pp. 219-231.
Palumbo M. e Garbarino E. (2006), Ricerca sociale. Metodo e tecniche, Milano, FrancoAngeli.
Prunesti A. e Lalli F. (2011), Geolocalizzazione e mobile marketing. Fare business con le App e i social game, Milano, FrancoAngeli.
Salati S. (2021), La fotografia, uno strumento educativo in un mondo di immagini, «Teoria e prassi», pp. 18-27.
Santinello M., Surian A. e Gaboardi M. (2022), Guida pratica al photovoice. Promuovere consapevolezza e partecipazione sociale, Trento, Erickson.
Schön D.A. (1993), Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale, Bari, Dedalo.
Twenge J.M. (2018), Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi crescono meno ribelli, più tolleranti, meno felici e del tutto impreparati a diventare adulti, Torino, Einaudi.
Valtorta R. (2023), Moira Ricci (20.12.53 – 10.08.04), Mantova, Corraini.
Vivian Maier, https://www.vivianmaier.com/ (consultato il 16 agosto 2024).
Biffi, E. (2012). Pratiche narrative per educare: piccoli, grandi narratori crescono. In D. Demetrio (Ed.), Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, la cura (pp. 71-116). Mimesis.
Barthes, R. (1980). La camera chiara. Nota sulla fotografia. Torino: Einaudi
Batini, F. e Bartolucci, M. (2018). Narrazione e benessere scolastico: percorsi e strumenti per migliorare l’apprendimento e la relazione educativa. Erickson.
Biscaldi, A. e Matera, V. (2023). Social media e politiche dell’identità. Ledizioni Ledipublishing.
Boden, M. A. (2019). Intelligenza Artificiale. il Mulino.
Borgna, E. (2001). Le emozioni ferite. Feltrinelli.
Borgna, E. (2017). Parlarsi: La comunicazione perduta. Einaudi.
Boyd, D. (2014). It’s complicated. La vita sociale degli adolescenti sul web. Castelvecchi.
Bruner, J. (1992). La ricerca del significato. Per una psicologia culturale. Bollati Boringhieri.
Cambi, F. (2005). Cura di sé e pratiche autobiografiche: il «doppio legame». In D. Sarsini (Ed.), Percorsi dell’autobiografia tra memoria e formazione (pp. 39-51). Edizioni Unicopli.
Carli, R. e Giovagnoli, F. (2010). Psicologia del disagio giovanile. Il Mulino.
Cava, E., Penna, A. e Pizzimenti, A. (2021). Nuove frontiere della pedagogia sociale. FrancoAngeli.
Consiglio d’Europa, Raccomandazioni del Consiglio del 18 dicembre 2006, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF, ultimo accesso 16/08/2024 h 17:15..
Consiglio d’Europa, Raccomandazioni del Consiglio del 22 maggio 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01), ultimo accesso 16/08/2024 h 17:35.
De Kerckhove, D. (1999). L’intelligenza connettiva. L’avvento della Web Society. FilmAuro.
De Mutiis, E. e Pomponi, M. (2023). Per uno spazio pedagogico onlife: dinamiche identitarie e implicazioni metacognitive. Scienze Pedagogiche, Edizioni Studium, 338-349.
Demetrio, D. (1995). Raccontarsi: L’autobiografia come cura di sé. Raffaello Cortina.
Denicolai, L. (2014). Riflessioni del sé. Esistenza, identità e social network. Media Education, Edizioni Centro Studi Erickson, 164-181.
Dewey, J. (2019). Come pensiamo. Raffaello Cortina.
Floridi, L. (2017). La quarta rivoluzione: Come l’infosfera sta trasformando il mondo. Raffaello Cortina Editore.
Galimberti, U. (2018). La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo. Feltrinelli.
Gottschall, J. (2013). L’istinto di narrare. Come le storie ci hanno reso umani. Bollati Boringhieri.
Jedlowski, P. (2009). Il racconto come dimora. «Heimat» e le memorie d’Europa. Bollati Boringhieri.
Lagreca, A. (2017). La narrazione come processo di facilitazione del sapere. Edscuola.
Lizzola, I. (2018). Pedagogia dell’incontro e della speranza. Cittadella Editrice.
Maffesoli, M. (1988), Il tempo delle tribù. Il declino dell’individualismo nelle società di massa. Armando.
McLuhan, M. (1967). Gli strumenti del comunicare. Il Saggiatore.
Mancino, E. (2012). Narrare con altri linguaggi. In D. Demetrio (Ed.), Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, la cura (pp. 219-231). Mimesis.
Palumbo, M., & Garbarino, E. (2006). Ricerca sociale: metodo e tecniche. FrancoAngeli.
Prunesti, A., & Lalli, F. (2011). Geolocalizzazione e mobile marketing. Fare business con le App e i social game. FrancoAngeli.
Salati, S. (2021). La fotografia, uno strumento educativo in un mondo di immagini. Teoria e prassi, 18-27.
Santinello, M., Surian, A., & Gaboardi, M. (2022). Guida pratica al photovoice. Promuovere consapevolezza e partecipazione sociale. Erickson.
Schön, D. A. (1993). Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale. Dedalo.
Twenge J. M. (2018), Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi crescono meno ribelli, più tolleranti, meno felici e del tutto impreparati a diventare adulti. Einaudi.
Valtorta, R. (2023). Moira Ricci 20.12.53 – 10.08.04. Corraini.
Vivian Maier, https://www.vivianmaier.com/, ultimo accesso 16/08/2024 h 17:25.
Vol. 2, Issue 1, April 2025