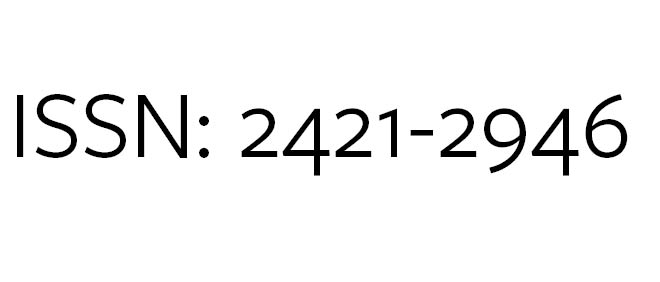Vol. 9, n. 1, aprile 2023
MODELLI EDUCATIVI
Per un progetto della pedagogia italiana
Michele Corsi1
Sommario
Così come gli stessi titoli dei paragrafi indicano, il presente contributo si colloca tra il politico e lo scientifico, con riferimento alla tradizione pedagogica e alla storia di questo ambito disciplinare, particolarmente negli ultimi venti anni. Con due richiami sostanziali. Il primo: a fare sempre più sistema e comunità, nell’unità e nell’internazionalizzazione; e a semplificare: dai settori scientifico-disciplinari alle società scientifiche. Il secondo, forti peraltro della memoria («non c’è futuro senza memoria»): a innovare e a rendere la pedagogia e le sue ricerche contemporanee e utili alle persone, alle istituzioni e al Paese.
Parole chiave
Pedagogia, Politica, Ricerca, Unità, Innovazione.
EDUCATIONAL MODELS
A project for the Italian Pedagogy
Michele Corsi2
Abstract
As the titles of the paragraphs indicate, this contribution intends to have both a political and scientific angle, with references to the pedagogical tradition and the history of this disciplinary field in Italy, particularly in the last twenty years. It carries two key messages. First, it is necessary to create and systematise cohesive and international communities and simplify the scientific-disciplinary sectors and scientific societies. Secondly, whilst rooted in memory («there is no future without memory»), it is essential to innovate to make pedagogical research contemporary and useful to the People, Institutions and the Nation.
Keywords
Pedagogy, Politics, Research, Unity, Innovation.
L’orgoglio di essere pedagogisti italiani
Quando si arriva alla mia età, si ha il dovere della sincerità.
A favore della propria comunità scientifica di riferimento, ma soprattutto dei più giovani fra le colleghe e i colleghi.
Un dovere che discende da una duplice considerazione: le esperienze sinora accumulate e l’incertezza sugli anni che rimangono da vivere.
Una sincerità ovviamente sempre garbata, come si usa tra accademici di rango.
Con uno sguardo, nondimeno, che, dal proprio ambito disciplinare, non può che dirigersi verso l’intera Università italiana.
Perché «non si può star bene da soli», se «il vicino è in sofferenza».
L’egoismo o l’egocentrismo non pagano mai, e l’invidia è un brutto sentimento. Dove il vincitore di oggi rischia di essere il perdente di domani.
Da qui, entro subito in medias res.
L’università è un «sistema» (AA.VV., 2001) al pari di un edificio, o di un palazzo, fatto di tanti appartamenti e pianerottoli.
Il decoro o la tenuta di quell’abitazione complessiva non possono procedere in forma slegata o rapsodica. Richiedono, piuttosto, sinapsi e legami.
È la visione globale, infatti, quando si sale e si scende per quelle scale, o si entra nei tanti alloggi, che è in grado di dirci del positivo stato di salute di quella costruzione, tanto da farne una struttura di pregio. Oppure un fabbricato malmesso e pericolante.
Tant’è che un mio modo di dire da tempo, anche alla luce dei miei tantissimi anni di presidenza di una Facoltà e poi di direzione di un Dipartimento ecc., è che, disponendo di due occhi, uno deve essere rivolto allo specifico prossimo che ci è stato affidato, ma l’altro deve tendere, e concorrere, al benessere complessivo dell’Ateneo che ci ospita e in cui siamo incardinati. Fino all’intero assetto universitario nazionale.
Sicché etica e scienza abitano la stessa galassia.
Così pure politiche accorte e lungimiranti come mediazioni continue e costanti, sagge, si rappresentano, pressoché quotidianamente, come due facce di una stessa medaglia.
Quanto scriverò allora, in queste pagine, promana dai miei 50 anni e oltre trascorsi nel sistema universitario italiano, da pedagogista.
Ma pure da studioso che ha sempre cercato, per i ruoli di servizio nazionale nondimeno ricoperti per un periodo tutt’altro che breve, di tessere rapporti con molti altri ambiti disciplinari: da quelli afferenti alla comune area 11 del CUN ad altre comunità scientifiche anche più distanti: dai matematici ai fisici, dai linguisti ai letterati ecc.
A motivo delle diverse sfide organizzative ministeriali da realizzare nelle nostre differenti sedi universitarie, specialmente negli ultimi due decenni, dopo la riforma Berlinguer (Graziosi, 2010; Brizzi e Frijhoff, 2018; Novarese e Pelleriti, 2020).
Dal Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, e i suoi diversi piani di studio che si sono succeduti, alle SSIS; dalle varie edizioni critiche del TFA, anche di sostegno, ai PAS; dal poi accantonato triennio della FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio), di cui alla legge sulla Buona Scuola n. 107/2015 — che tanto impegno aveva pure richiesto a molteplici comparti disciplinari, e non da ultimo a noi pedagogisti, come alla Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione —, agli attuali 24 CFU e alla futura organizzazione al riguardo dei 60 CFU di cui non si vede ancora la luce, ecc.
Di tutto questo non possiamo che essere orgogliosi come pedagogisti italiani.
Abbiamo fatto la nostra parte con prudenza e avvedutezza.
Indicando le «buone ragioni» dei saperi pedagogici, per una migliore e più consona formazione docente: dalla scuola dell’infanzia alla secondaria superiore.
Molte volte, naturalmente, smussando angoli e trovando tutti gli accorgimenti utili per non abbassare l’asticella e, nel contempo, superando frizioni sempre possibili con gli altri raggruppamenti scientifici, cogliendo anche il positivo insito nelle loro proposte. Ad esempio, coi disciplinaristi.
Tutto positivo, dunque?
Nel proseguo di questo scritto non potrò che mettere in rilievo, invece, alcune zone d’ombra dell’attuale pedagogia italiana, invitandola a un progetto in parte diverso e certamente — almeno dal mio punto di vista — maggiormente «riflettuto».
Che tale è, quanto verrò in seguito scrivendo: un punto di vista o una proposta.
Consapevole, peraltro, della parzialità di ogni singolo, personale pronunciamento. E dell’impossibile neutralità valutativa di ciascun posizionamento individuale.
Per questo esistono le comunità degli studiosi di un medesimo ambito, o anche le comunità più ampie, come quelle di pratiche.
È solo il libero e sereno confronto tra colleghe e colleghi, senza pregiudizi e con la massima onestà intellettuale possibile, che può consentire il salto dalla sempre possibile precarietà di un suggerimento o di un parere da parte di una studiosa e di uno studioso a quella necessaria e imprescindibile oggettività relazionale che è, al contrario, il suggello, o il crisma, di un percorso condiviso comunitariamente e attentamente vagliato (Goode e Hatt, 1968; Nagel, 1968).
E inizio, in questo primo paragrafo, alludendo a due emozioni che sono pure foriere di pensieri e di ulteriori riflessioni.
La prima: per la quale i pedagogisti non sono molto «amati».
E questo sicuramente non ci può inorgoglire.
Da parte di chi anche, circa quindici anni fa, ai vertici del nostro Ministero, ci annoverò tra i mali della scuola italiana, insieme al ’68, a don Lorenzo Milani ecc.
Un pregiudizio? Quasi certamente.
Ma sarebbe troppo facile, o semplicistico, superare, o archiviare, una siffatta valutazione negativa, rifiutandola.
Piuttosto, dovremmo interrogarci sul perché di questo astio e di questa ricercata distanza.
Che serpeggia sovente pure fra non pochi colleghi anche di altri saperi, che ci considerano poco rigorosi, parolai, incapaci di incidere efficacemente sulle condotte e sui comportamenti, ad esempio, scolastici.
Quindi, proprio il rigore.
Il rigore di un’evidenza disciplinare definita.
Dunque, la seconda considerazione.
È molto triste, quando entriamo nelle grandi catene librarie nazionali come Feltrinelli, Laterza ecc., trovare scaffali ben ordinati e accuratamente denominati che fanno capo alla filosofia, alla psicologia, alla storia e così via.
Mentre la pedagogia, anche quando questa dicitura è espressamente segnalata, vede i propri volumi, e sovente unicamente dei colleghi di quella città o di quella sede universitaria, o poco più, mescolati con saggi di puericultura, scienza dell’alimentazione o pediatria divulgativa.
Come se i pedagogisti si occupassero solo d’infanzia.
Anche se qua o là compaiono pure testi di didattica, di docimologia o di pedagogia speciale.
Quindi, con una qualche apertura alla scuola.
Non un sapere, pertanto, autonomo e ritagliato: la pedagogia, ma un tassello di altri tasselli, in un guazzabuglio di testi malamente accostati fra loro, che non può che lasciarci immelanconiti, a disagio e quant’altro.
Dobbiamo, al contrario, recuperare, con forza ed energia, l’orgoglio della nostra disciplina.
E di noi come pedagogisti.
Ovunque e comunque.
Da qui, la proposta.
Per una politica accademica
Per quello che conto, se dovessi appunto lanciare uno slogan, da proporre di perseguire, alla comunità pedagogica italiana tutt’intera, o offrire un orizzonte politico sul quale collocarsi e conseguentemente agire, li sintetizzerei in due irrinunciabili (almeno per me) parole chiave fortemente interconnesse fra loro, così da rappresentare davvero due facce di una stessa medaglia: unità e internazionalizzazione.
Con l’unità, o la sua attuale, maggiore e più consistente ricerca, da declinare su due versanti.
Innanzitutto, ad intra.
Sapendo che l’unità nasce nell’incontro fra tutti, o quanti più possibili; pure a costo di conflitti, spesso anche di scontri magari di un qualche peso. Ma col ricorso sempre dovuto, poi, all’intelligenza delle mediazioni e alla prudenza della saggezza, per risolverli.
Così da non lasciare attivi frizioni, dissensi e distanze.
Che non ci giovano neppure nel rapporto con gli altri comparti scientifici o con i molteplici settori disciplinari con cui ci relazionamo.
Tanto meno nei confronti delle istituzioni universitarie di governo.
Ad esempio, con il nostro Ministero, il CUN, l’ANVUR ecc., perché è un refrain antico che «nelle divisioni altrui — e, cioè, fra i cosiddetti due litiganti — c’è sempre, infine, un terzo che gode».
E questo terzo rischia di non essere la pedagogia italiana.
Consentendole piuttosto, in una «pace attiva» (Roveda, 1990), di chiarire e, quindi, di operare a favore del superamento di quelle accuse, spesso malevoli, ingiuste e artatamente pregiudiziali, di cui è sovente oggetto, e di cui ho scritto nel paragrafo precedente.
Perché, per conquistare autenticamente spazi di presenza e di proposta, ovunque e comunque, c’è da rappresentarsi uniti e compatti.
Anzi esserlo davvero.
La storia ce lo insegna.
Una serie di piccole «imbarcazioni» si vincono facilmente.
E in molti non si aspettano altro.
Il divide et impera di casa d’Asburgo, infatti, ha pagato (e con costi tutt’altro che lievi) per qualche decennio nell’Ottocento o poco più, ma poi alla fine, nel 1918, l’impero austro-ungarico è franato rovinosamente, dando vita a una serie di piccoli Stati (e questo è oggettivo), molti dei quali non hanno avuto nemmeno vita facile, all’indomani della loro nascita, e quasi sino ai giorni nostri.
Una grande corazzata, ben attrezzata e agguerrita, invece, non solo incute maggiore rispetto, ma è anche più difficilmente affondabile.
Con ritorno, pertanto, a quell’orgoglio di cui si è già scritto, e che non può non guidarci.
Orgoglio e non superbia.
Orgoglio e non paranoia acritica e spesso pure perversa.
L’orgoglio di sapere di valere e di voler difendere, portare avanti e realizzare le proprie «buone ragioni».
Non già le ragioni del «piccolo orto conchiuso» fine a sé stesso (quello pedagogico, come direbbero i nostri detrattori), ma le motivazioni, alte e morali, di un reale servizio all’educazione, alle sue istituzioni anche scolastiche, e al Paese.
E da qui, umanamente e comprensibilmente, nondimeno all’accademia pedagogica italiana.
Com’è nelle nostre migliori intenzioni, da sempre.
E, infine, ad extra.
Con un extra che può essere pure annoverato come un «secondo fatto» a noi interno, ma la cui esistenza ci fa correre il «secondo rischio» di allontanarci dalla rappresentazione scientifica, politica e operativa dell’ambito di Education, com’è attualmente strutturato in Europa, e anche al di fuori dei confini dell’Unione.
Mi riferisco alla divisione tutta italiana del comparto pedagogico nazionale in quattro distinti settori scientifico-disciplinari.
Alcuni con più colleghe e colleghi incardinati, altri meno numerosi.
La motivazione o le motivazioni?
Quella più nobile è di aver voluto difendere, e di volerlo tuttora, la specificità di un determinato ambito euristico, dandogli piena visibilità, favorendo rapporti evidenti e consoni, quasi mono-linguistici, fra i docenti ivi afferenti.
Quella meno nobile, pur se comprensibile, è che, quando si diede loro vita, si sperava (ma anche allora contro ogni speranza, se si fosse stati solo più attenti e informati) che questa moltiplicazione avrebbe potuto portare a un aumento di dottorati di ricerca, di posti in organico ecc. In una o due parole: a ottenere più spazi e più potere.
Ma oggi?
Attualmente, con la progressiva riduzione degli FFO agli atenei italiani, ovvero col timore pure di non pochi Rettori nel creare nuovi posti da RTDb o RTT ovvero da associati o da ordinari, limitando il calcolo di tali costi al qui e ora, e senza tener conto della maggiore spesa futura degli scatti stipendiali negli anni a venire, specie a fronte di colleghe e di colleghi ben giovani: tutto questo ha ancora senso?
Nondimeno, ci aiuta?
E aiuta particolarmente i settori più piccoli, quando, affinità o meno, dobbiamo ricoprire gli insegnamenti dei nostri Corsi di laurea?
Infine, con l’attivazione dei settori concorsuali per l’abilitazione scientifica nazionale, dopo la L. 240/2010, e, cioè, l’aver ricevuto i due SC 11/D1 e 11/D2, in cui la pedagogia generale e sociale è tutt’una con la storia della pedagogia e dell’educazione, ovvero la didattica e la pedagogia speciale sono insieme alla pedagogia sperimentale (o con la ricerca educativa, che dir si voglia), si sono forse annacquati, o hanno perso la loro identità, questi diversi filoni della nostra ricerca pedagogica nazionale?
Non mi pare proprio.
Nemmeno negli esiti degli abilitati di cui a queste prime tornate.
Recupero a questo punto, ulteriormente, quel diritto-dovere della sincerità, consentitomi anagraficamente.
Spesso, tutto questo mi appare unicamente una «guerra tra poveri».3
Altrimenti, potrei definire questa attuale quadripartizione come una sorta di scandalo, nel suo stesso significato etimologico di «trappola, inciampo, intoppo, molestia — ovvero una scelta molesta —, impedimento». Con parole diverse: di farci «zoppicare», «cadere», «sbandare». Conclusivamente: un’«azione cattiva, un discorso corruttore, un cattivo esempio».
Dove, allora, il possibile rischio, o la temibile caduta, di questa perdurante moltiplicazione settoriale?
Un esempio per tutti: relativamente ai progetti europei.
Tutti ci teniamo a vincerli.
Come in ordine ai PRIN.
Ben sapendo, del resto, che gli stessi PRIN sono alimentati dai fondi dell’Unione.
Pecunia non olet.
Specialmente in questo periodo, che dura da almeno due o tre decenni, di «vacche sempre più magre», se non addirittura «sterili», in ordine ai finanziamenti per la ricerca da parte del nostro Ministero.
Ma chi vince poi, anche fra noi, questi opportuni (per tanti motivi) progetti europei?
Coloro che praticano la co-inter-trans-disciplinarietà (Stramaglia, 2019).
Che hanno saputo tessere reti, e creare rapporti, pure con ambiti molto distanti dalla pedagogia tradizionalmente intesa: con gli economisti e i sociologi, coi biologi e con gli scienziati tout court, con gli agrari, gli studiosi dell’ambiente, i tecnologi, gli ingegneri, i medici ecc.
Avventurandosi, nondimeno, per temi e piste poco adusi, o nient’affatto frequentati, dalla più abituale ricerca pedagogica.
Con la medesima, migliore, internazionalizzazione, e le sue prassi, a richiederlo oggi con forza.
Parrebbe, comunque, che l’orientamento ministeriale ecc. sia teso, al presente, a un superamento, o a una riorganizzazione, di questi settori.
Per una politica della ricerca
Se non sbaglio, le attuali società scientifiche di ambito pedagogico sono nove. Perché talora perdo il conto.
Con qualche altro micro-raggruppamento in aggiunta, che non fa parte però della Consulta.4
Anche qui, la domanda, o le considerazioni, sono più o meno le stesse, mutatis mutandis, che abbiamo avanzato per i quattro settori scientifico-disciplinari.
Servono, attualmente, tutte queste organizzazioni?
Oppure si potrebbe andare, se non a una loro pressoché definitiva semplificazione, a maggiori forme di unitarietà?
I settori sono funzionali comunque, ancora oggi, alla didattica e all’organizzazione universitaria in tutti i loro rivoli o canali.
Le società scientifiche, invece, avrebbero il compito di presiedere alla ricerca, al suo potenziamento e alla sua crescita qualitativa e quantitativa.
In altri termini, avrebbero il compito di indirizzarla.
Ma questo accade davvero?
E con quale intensità?
Non vorrei rispondere a queste domande.
Per lasciarle piuttosto, quali riflessioni, alle colleghe e a colleghi.
Pur non essendomi ignoti alcuni benemeriti contatti fra scuole e atenei in ciascuno dei nostri comparti, che hanno dato vita a forme di cointeressenza investigativa e di collaborazione scientifica, anche con l’ausilio di alcune validissime riviste di apertura nondimeno internazionale, che fanno da deposito, cassa di risonanza, volano e veicolo di queste indagini.
Ma: «terzo appello alla sincerità», ho il timore che non solo in «casa pedagogica», ma pure in altri ambiti disciplinari, le società scientifiche siano, al presente, maggiormente delle rappresentazioni di contrattazione con Enti, Ministeri, organizzazioni, altri settori ecc. (non esclusa la mia stessa personale responsabilità, a suo tempo), che non, prevalentemente, organismi di orientamento, di selezione, di affinamento euristici. Nel nostro caso: della ricerca pedagogico-educativa anche di comparto e di una loro armonizzazione e composizione, orizzontali e verticali.
E, qui, mi permetto sommessamente di avanzare un ulteriore ragionamento.
Pure alla luce di quanto vengo leggendo.
Mi pare talvolta, infatti, di assistere a una inaudita moltiplicazione di filoni di investigazione e di scrittura in cui, benevolmente non di rado, si fa fatica a ritracciare anche la cifra pedagogica.
Per essere piuttosto, talora, questi studi maggiormente prossimi ad altri saperi, e in forma nemmeno infrequente; non possedendo poi, neppure a fondo, le matrici epistemologiche, storiche ed evolutive di quelle discipline: dalla sociologia alla psicologia e ai campi affini alle scienze mediche o ingegneristiche.
Ponendosi infine, sovente, quali esercizi «quasi» banali, divulgativi, a-scientifici.
Mi sovviene, a questo punto, l’antica lectio di Sergio De Giacinto in una delle sue prime opere (De Giacinto, 1966), in cui, studiando la situazione universitaria statunitense, commentava che un docente di storia americana, ad esempio dal 1865 al 1870, non era in grado di supplire, per lo specialismo raggiunto, a un collega, sempre di storia americana, di un quinquennio precedente o successivo.5
Sicché assistiamo, attualmente, a una sorta di crescita esponenziale di esperti del micro, che hanno perso di vista il macro.
E, cioè, l’ordito pedagogico unitario di riferimento o la sua tessitura complessiva.
Sicché è anche scomparsa, in buona parte, la generazione di quei nostri Maestri o di taluni fra le colleghe e i colleghi con cui sono cresciuto, che sono stati in grado di trascorrere meritoriamente da un settore all’altro, e da una disciplina all’altra, nel corso della loro lunga carriera accademica, operando, più che egregiamente, sul piano sia scientifico che didattico.
Avendoci nondimeno regalato opere di assoluto spessore, che andavano dalla pedagogia generale e sociale alla storia della nostra disciplina, alla didattica. Persino alla pedagogia sperimentale.
Tre nomi per tutti (ma ne potrei citare molti altri): Franco Frabboni, Mauro Laeng e Cesare Scurati.
Comprensibilmente, mi si potrebbe, però, avanzare una legittima obiezione.
E, cioè, che oggi la scienza si è talmente affinata, raffinata, moltiplicata, da richiedere una pari disseminazione euristica.
Ma ne siamo davvero convinti?
Preferisco, però, non attardarmi in ulteriori riflessioni, affidandomi, piuttosto, alla saggezza, alla competenza e all’onestà intellettuale delle colleghe e dei colleghi, nel rispondere a questo quesito.
In sintesi, questo paragrafo, come il precedente, rispondono a un bisogno: dalla semplificazione dei settori disciplinari a una diversa organizzazione delle società scientifiche, con un ritorno anche ai motivi per cui sorsero, negli ultimi decenni del secolo scorso, ad esempio la SIPED e la SIRD. Laddove la mia richiesta è di superare, al presente, divisioni e steccati, per creare nuovi legami e maggiori sinapsi.
In una parola: di fare comunità. Ex novo.
O di rifarla, se magari in passato si fossero mai date più strette forme aggregative fra ambiti didattici e saperi euristici.
Per quanto ci riguarda: di fare comunità pedagogica.
Innovazione e contemporaneità
A volte, scorgo del «chiuso» o del «vecchio» nelle nostre ricerche.
Anche nel solco di quella frastagliata frantumazione e proliferazione investigativa di cui ho appena scritto.
Con ricerche che ritornano, fra l’altro, quali ridondanti, minuziose o quasi leziose calligrafie su autori, scuole e ambiti di indagine che, pure a rovesciarli come calzini, non sono in grado di aggiungere nulla di nuovo a quanto già scritto e consegnatoci da tempo.
Apriamoci piuttosto al presente. Alla contemporaneità. Rendendo di nuovo o, finalmente, utile, la pedagogia.
Sicché, se anche qui volessi lanciare uno slogan dal presente al futuro, scriverei: «Innoviamo, rendiamoci contemporanei, ma soprattutto offriamo modelli, strategie, pratiche (o “ricette”, alla Dewey) davvero utili» (Dewey, 1967).
Così da poter occupare il futuro, prima ancora che questo accada.
Per prevenirlo, indirizzarlo, governarlo.6
Cercando di essere come Giano bifronte: e cioè, per un verso, di essere «forti della memoria» della nostra disciplina (del resto: «non c’è futuro senza memoria») e, per altro, di correre incontro al presente e al futuro. Abbracciandolo senza pregiudizi. E non quali tristi e sconsolate Cassandre.
Il che non vuol dire affatto che non si possano avere giudizi e talora pure riserve su molto di quello che accade oggi.
Ma queste personali, legittime elaborazioni non ci devono distanziare dalla storia che accade e che avanza. Smettendo anche i panni, spesso vestiti, e nondimeno funerei, dei laudatores temporis acti.
Questo, infatti, è il presente che ci è stato donato.
Questa, la zolla su cui, deweyanamente, dobbiamo curvarci.
Questo è il tempo evangelico della nostra semina.
E, recuperando la mia visione antropologica di riferimento (Corsi, 2015), certo possono esistere tempi più difficili di altri — e qualcuno potrebbe pure ritenere che gli attuali rientrino in questa condizione —, ma, tomisticamente, anche nell’imprescindibile rispetto e nell’ineliminabile fondatezza della libertà e della responsabilità personali (Corsi, 2003), non possiamo dimenticare — almeno i credenti — che tutta la storia ha a che fare con Dio, da Lui promana e a Lui ritorna.
Nel mistero, che sovente ci sfugge.
E nel dolore, spesso insopportabile, che non di rado male-diciamo pure.
Ovvero, laicamente o fichtianamente, se tutta la storia è, invece, opera delle nostre mani, nel bene e nel male, con chi prendersela se non con noi stessi, con le nostre sbadataggini, coi nostri silenzi e, sovente, con la nostra immoralità?
E veniamo adesso a taluni ambiti di ricerca (alcuni, non tutti, e random, solo a mo’ di esempio, e senza un pensiero latente a monte) della pedagogia contemporanea.
Dove, anche qui, pongo delle domande, ma mi guardo bene dal dare delle risposte.
È possibile una pedagogia del lavoro che non sia declinata interdisciplinarmente, per essere conchiusa, piuttosto, nel ristretto ambito delle elaborazioni pedagogiche o delle riflessioni filosofico-educative?
Una pedagogia interculturale (utile, strategica e contemporanea) che non si traduca pure in didattiche più che precise, mirate e funzionali per i differenti ordini e gradi di scuola, può ritenere di avere assolto, compiutamente ed efficacemente, al proprio mandato pedagogico istituzionale?
E così per talune ricerche dell’intero ambito pedagogico, poche o tante che siano non importa: cosa hanno davvero in comune con la storia delle nostre discipline? E, nondimeno, cosa sono in grado di offrire a una maggiore compiutezza del presente e a una sua più precisa puntualizzazione?
Oppure molti studi, che si auto-definiscono empirici o sperimentali, sono davvero tali?
E vengo adesso al mio peculiare ambito investigativo: la pedagogia delle relazioni educative familiari (Corsi e Stramaglia, 2009).
È ancora tollerabile che alcune emergenze o taluni epifenomeni in ascesa (alla luce anche della mia più che quarantennale attività psicoterapeutica) come, ad esempio, la condizione omosessuale e le persone omosessuali (e nondimeno gli adolescenti e i giovani omosessuali), con tutti i rigetti omofobici che registriamo quotidianamente (Cambi, 2015), siano tuttora oggetto di poche, sparute ricerche pedagogiche e di colleghe e colleghi da potersi contare sulle dita della mano?
Chi sta elaborando modelli di vita e di convivenza educativo-relazionali-comunicativi per le coppie omosessuali che pure esistono, in buon numero, nel nostro Paese?
E per le ipotetiche famiglie omosessuali a venire?
Così da non doversi trovare impreparati quando questo accadesse (Corsi, 2016). Come, adesso, in merito alla discussa contrapposizione sulla bigenitorialità da maternità surrogata.
Con una pedagogia italiana, poi, che volesse scrivere unicamente per un territorio ristretto tra le Alpi e le isole Eolie. Questa sarebbe la vocazione internazionale della nostra disciplina? Questo, il desiderio del confronto con le colleghe e coi colleghi di altre nazioni e culture?
In modo da accreditare davvero una reale, sostanziale, e non immaginifica, comunità pedagogica internazionale.
Basti pensare — e la stampa nazionale ne ha dato ampio riscontro — che la giurisprudenza mondiale sta ormai sdoganando le nozze gay. Equiparandole, di fatto, al matrimonio tradizionale.
Così la Corte Costituzionale dell’Ecuador, con la sua sentenza del 12 giugno 2019, andandosi ad aggiungere, in quel continente, all’Argentina, alla Colombia e al Brasile, che hanno già compiuto passi in questa direzione.
E fermandosi a un solo anno, appunto il 2019: persino in Africa, l’alta Corte del Botswana, con il suo pronunciamento dell’11 giugno 2019, ha statuito che la legge del 1965, che puniva le relazioni omosessuali fino a sette anni di prigione, è incostituzionale, sancendo che «lo Stato non può essere lo sceriffo delle camere da letto delle persone», le quali devono essere rispettate nella loro privacy.7
Il 6 giugno scorso, la Court of Final Appeal di Hong Kong ha trascritto il matrimonio, contratto in Nuova Zelanda, tra due persone dello stesso sesso, di cui uno di nazionalità cinese. Riconoscendo ai coniugi gay i medesimi diritti sociali e gli stessi benefici fiscali della coppia sposata eterosessuale.
Sempre nel continente asiatico, in Giappone, il 3 giugno 2019 è stata presentata una proposta di legge per eliminare la distinzione di sesso nella formulazione dell’art. 24 di quella Costituzione, che considera il matrimonio come l’unione tra moglie e marito. Approvata, poi, successivamente.
Si tratta, a ben vedere, di singoli, ma sintomatici esempi, che, in un mondo sempre più globalizzato (o internazionale), riduce, fino a polverizzarle, le distanze fisiche e culturali sino a oggi esistenti su questa materia.
E il nostro Paese? E la pedagogia italiana cosa propone al riguardo?
Bibliografia
AA.VV. (2001), L’università per un sistema formativo integrato. Fondamenti, connessioni, esperienze, prospettive, Milano, Vita e Pensiero.
Brizzi G.P. e Frijoff W. (2018), Digital academic history. Studi sulle popolazioni accademiche in Europa, Bologna, Il Mulino.
Cambi F. (2015), Omofobia a scuola. Una classe fa ricerca, Pisa, ETS.
Corsi M. (2003), Il coraggio di educare. Il valore della testimonianza, Milano, Vita e Pensiero.
Corsi M. (2015), La mia Pedagogia. Un itinerario biografico, scientifico e umano (con profilo biografico-antologico). In S. Ulivieri, L. Cantatore e F.C. Ugolini (a cura di), La mia pedagogia, Pisa, ETS, pp. 447-479.
Corsi M. (2016), La bottega dei genitori. Di tutto e di più sui nostri figli, Milano, FrancoAngeli.
Corsi M. e Stramaglia M. (2009), Dentro la famiglia. Pedagogia delle relazioni educative familiari, Roma, Armando.
De Giacinto S. (1966), Struttura dell’insegnamento, Napoli, Morano.
Dewey J. (1967), Le fonti di una scienza dell’educazione, Firenze, La Nuova Italia.
Goode W.J. e Hatt P.K. (1968), Metodologia della ricerca sociale, Bologna, Il Mulino.
Graziosi A. (2010), L’università per tutti. Riforme e crisi del sistema universitario italiano, Bologna, Il Mulino.
Nagel E. (1968), La struttura della scienza. Problemi di logica nella spiegazione scientifica, Milano, Feltrinelli.
Novarese D. e Pelleriti E. (2020), Università «contro»? Il ruolo degli atenei negli ordinamenti in crisi, Bologna, Il Mulino.
Roveda P. (1990), La pace cambia. Proposte pedagogiche, Brescia, La Scuola.
Stramaglia M. (a cura di) (2019), Pop Cultures. Sconfinamenti alterdisciplinari, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia.
1 Università degli Studi di Macerata e Università Telematica Pegaso.
2 Università degli Studi di Macerata e Università Telematica Pegaso.
3 Quella stessa «guerra tra poveri», in nome — a mio parere — anche dell’attuale separatezza fra i nostri quattro settori, per cui ci si accusa tuttora, da un ambito all’altro, su chi fa davvero ricerca, o ricerca utile, e non, piuttosto, «omelie» e quant’altro di simile. Forse, una diversa ricomposizione fra i nostri ambiti ci aiuterebbe a non spezzare più, nel tempo, «il capello in quattro», come alla fine degli anni Settanta, allorché la domanda prevalente era se fosse maggiormente marxista il partito comunista sovietico o quello cinese.
4 La Consulta Pedagogica aduna tutte le Società scientifiche di ambito pedagogico ivi accolte.
5 Non diversamente, forse, sta succedendo in ambito medico, dove pur comprendo che le attuali, e sufficientemente impreviste sino a ieri, sfide di salute ci offrono, al presente, tutta una serie necessitata di specialismi, con la pressoché scomparsa del clinico a tutto campo, ovvero del vecchio medico di famiglia. E con la conseguenza, tutt’altro che mirabile, che, al primo, più o meno serio, incidente di percorso, si ricorre ex abrupto ai pronti soccorsi. Che appaiono, così, una scelta ineluttabile, quando non deresponsabilizzante. Sicché questi reparti appena citati si rappresentano, ormai, come una più che affollata anticamera dell’inferno o una sorta di bolgia dantesca.
6 Mi auguro, ad esempio, che qualche collega stia già scrivendo sulle baby gang ecc., così da analizzare questi fenomeni e offrire diagnosi e terapie adatte a evitare, o per lo meno a limitare fortemente, il ripetersi di questi veri e propri drammi della «mala educazione», sempre più precoci per età.
7 Mentre le psicologie e le psicoanalisi contemporanee molto avrebbero da dire pure sulle matrici profonde ed esperienziali della scelta omosessuale.
Vol. 9, Issue 1, April 2023