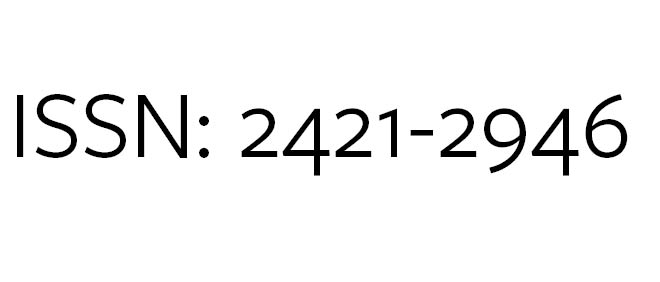Teorie pedagogiche - Pedagogia del lavoro / Educational Theories - Pedagogy of Work
La precarietà occupazionale come dispositivo biopolitico e bioeconomico
The precariousness of employment as a biopolitical and a bio economical devise
Fabrizio d’Aniello
Professore associato di Pedagogia generale e sociale (M-PED/01) presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata.
Sommario
Questo articolo si colloca nella prospettiva della pedagogia del lavoro e, muovendo dallo sfondo antropologico offerto dal lavoro produttivo industriale, si propone di indagare la condizione di precarietà come dispositivo biopolitico e bioeconomico che vanifica l’educabilità nei contesti di lavoro post-fordista. Nello specifico, l’articolo pone a tema il rapporto tra precarietà occupazionale e precarietà esistenziale nell’era del biocapitalismo cognitivo, affronta la problematica dell’individualizzazione contrattuale — vista come un riflesso dell’individualizzazione neoliberista del lavoro — in ordine alla mobilizzazione integrale delle energie umane, mette in luce la relazione tra precarietà e consumo e, in conclusione, sottolinea il ruolo politico e culturale che la pedagogia dovrebbe assumere ai fini della ricomprensione del lavoro e dell’agire economico.
Parole chiave
Pedagogia del lavoro, precarietà occupazionale, biopolitica e bioeconomia
Abstract
This article fits within the framework of labour pedagogy. It aims to study the condition of job insecurity as a bio-political and bio-economic mechanism which thwarts educability in post-Fordist work contexts. The argument starts from the anthropological background offered by industrial productive work. Specifically the paper focuses on the relationship between occupational insecurity and existential insecurity in the era of cognitive bio-capitalism; addresses the problem of contractual individualisation — seen as a result of the neoliberal individualisation of work — in regard to the complete mobilisation of human energies; highlights the connection between insecurity and consumption. In conclusion the contribution underlines the political and cultural role that education should undertake for the purposes of reconsidering work and economic action.
Keywords
Pedagogy of work, job insecurity, bio-politics and bio-economy
Premessa
Nel 1964, Calvino pubblica, per la rivista «Il menabò», il saggio intitolato Antitesi operaia, dove propone una sorta di ricognizione delle valutazioni del ruolo storico della classe operaia di quegli anni, nel tentativo di delineare l’attualità della sua configurazione. Dopo avere premesso che la possibilità stessa dell’antitesi si allontana inesorabilmente da un’effettiva ipotesi di realtà, dato che i lavoratori sono talmente subordinati alla disciplina della macchina da divenirne semplici ingranaggi incapaci di opposizione, lo scrittore e intellettuale si sofferma sulla coercizione operata dal sistema, sottolineando come essa venga esercitata dentro il lavoro e fuori dal lavoro, attraverso le logiche consumistiche. Per questo motivo, egli scrive che «desiderare o pensare o immaginare altra cosa da quella che il sistema impone diventa un’impresa disperata» (Calvino, 1995, p. 126).
Da allora è passata molta acqua sotto i ponti e, in verità, un’antitesi — culminata nei movimenti di protesta degli anni Settanta — c’è stata, ma la disperazione lamentata da Calvino sembra ancora legittima, anzi risulta rafforzata nella sua percezione, e questo vale sia il lavoro produttivo industriale (oggetto dell’articolo in quanto modello di riferimento antropologico) sia per il lavoro dipendente in generale. Quello che cambia rispetto al passato sono i mezzi e i confini dell’assoggettamento dell’uomo. Non si può più parlare di disciplina della macchina e nemmeno del desiderio di accesso al consumo scatenato da una certa cultura. Il paradigma fordista è superato e anche la rivoluzione dei consumi è stata rivoluzionata (Lipovetsky, 2007). Tuttavia, si può parlare di una sofisticazione dell’assoggettamento che ha nella precarietà occupazionale, in particolare, una forza motrice ineguagliabile; nonché una forza atta a vanificare la soluzione di continuità tra il dentro e il fuori, se è vero che supporta una colonizzazione valoriale e simbolica improntata alla crucialità della merce (Revelli, 2001, p. 59), la quale origina nel contesto di lavoro e continua, potenziandosi, oltre la soglia d’ingresso del medesimo.
Poiché a quest’ultimo aspetto, legato a doppio filo con la persistenza della merce di contro alla frammentazione dei rapporti umani, dei luoghi e dei tempi provocata dalla precarietà, abbiamo dedicato altri contributi, nelle pagine seguenti non vi ritorneremo approfonditamente, ma ci occuperemo della sostanza biopolitica e bioeconomica della precarietà, intesa come lo strumento in grado di mettere a valore tutta la vita dell’individuo, onde poi approdare a congrue riflessioni pedagogico-educative.
Precarietà e biopolitiche del lavoro
La precarietà della condizione di lavoro non è certo una novità nel panorama della storia del capitalismo. Dipendente da crisi congiunturali o dai rapporti di forza dominanti, essa ha largamente frequentato il dipanarsi del capitalismo pre-fordista e ha pure permeato il capitalismo fordista, sebbene con un impatto assai minore. Però, sia nel primo che nel secondo caso sussisteva una netta distinzione tra il tempo del lavoro e il tempo della vita (Marchetti, 2010), determinando ricadute non totalizzanti.
Questo non può avvenire nell’era del biocapitalismo cognitivo (Morini e Fumagalli, 2010), dove l’inscindibilità tra conoscenza e vita, e più in dettaglio il linguaggio e la comunicazione (Marazzi, 1999), pervadono le fasi principali del processo capitalistico.
Focalizzando l’attenzione sulla fase squisitamente produttiva, è chiaro che la suddetta distinzione viene meno quando la riflessività, la relazionalità, i bisogni di reticolarità, la formazione, l’apprendimento e il coordinamento costituiscono i parametri di un lavoro che mira ad alimentare la «triade dialettica comunicazione-cooperazione-autocontrollo/controllo sociale», ossia quando è l’intero potenziale umano soggettivo e intersoggettivo che confluisce nell’attività lavorativa insieme alla sua capacità di auto ed etero-adeguamento (Fumagalli, 2011, pp. 71-75).
Ne deriva che, se il tempo e la sfera della vita è assorbito dal tempo e dalla sfera del lavoro, stante l’esigenza di coinvolgere l’essere nella globalità delle sue funzioni, la precarietà dell’occupazione si trasforma in precarietà esistenziale. In altre parole, è tutta la persona che viene messa in gioco dalla precarietà: non è solo il lavoro a essere precario, ma la rappresentazione di sé che si esplica come mai prima nel lavoro.
Quest’ultima sottolineatura non può essere compresa a fondo se non consideriamo la tendenza all’individualizzazione contrattuale che sta alla base di gran parte della condizione precaria contemporanea e l’individualizzazione del lavoro che presiede alla prima. L’individualizzazione contrattuale è sia l’esito di un lungo e perdurante processo di deregolamentazione dei diritti e di deistituzionalizzazione sindacale funzionale in primis alla metamorfosi (finanziaria) del capitale e alla sua autonomizzazione dalla società del lavoro (d’Aniello, 2015, pp. 82-84), sia la risposta alla «mobilità oggettiva» (Fumagalli, 2011, p. 69) del lavoro (elasticità dei mercati, mutevolezza dei luoghi e dei tempi produttivi, cambiamenti tecno-produttivi, ecc.) e alle istanze di mobilizzazione soggettiva a fronte della complessità, variabilità e perturbabilità degli scenari organizzativi e operativi. Inoltre, a proposito di mobilizzazione concepita come investimento totale, essa appare il tramite più immediato per la concretizzazione della individualizzazione neoliberista del lavoro.
Questa, sommariamente, consiste nel superamento della contrapposizione classica tra lavoro e capitale attualizzato grazie allo sforzo neoliberista di trasformazione antropologica del lavoratore da oggetto a «soggetto economico attivo» che è di per sé capitale e che, in quanto tale, è votato per definizione all’autoinvestimento (Foucault, 2005, pp. 183-185), a ergersi a «imprenditore di se stesso» (Gorz, 2003, pp. 17-21). Detto altrimenti, se nella concezione neoliberista lavoro e capitale coincidono (e non confliggono) e il salario è il rendimento di un capitale (umano), tale rendimento è sotto la responsabilità del lavoratore e del suo impegno a far fruttare le proprie competenze, e l’individualizzazione contrattuale è il luogo naturale di esercizio della responsabilità, perché primariamente soggettiva e correlata all’espressione delle differenti facoltà individuali. Conseguentemente, si moltiplicano e si modificano in itinere stipule contrattuali che esulano dall’assistenza sindacale e regolano di volta in volta la natura e il livello della mobilizzazione.
Aderendo all’interpretazione biopolitica (Combes e Aspe, 1998; Durand e Le Floch, 2006; Dardot e Laval, 2013), questo stravolgimento teorico e ideologico propriamente neoliberista — corredato di evidenti ricadute pratiche sul piano dell’agire economico e politico in generale, sulla mutazione della rappresentazione manageriale e organizzativa circa l’apporto e il ruolo dei singoli e, ovviamente, sul crescente primato del diritto privato nella contrattazione — non comporta l’umanizzazione educativa del capitale, ma la capitalizzazione della vita. È palese, dunque, la ripercussione sull’esistenza tutta, specialmente se, tramite l’uso strategico di retoriche incentrate sulla valorizzazione del proprio capitale, l’individualizzazione contrattuale è metabolizzata dall’uomo che lavora come indiscutibilmente propedeutica a una messa in prova legittimamente individuale, e se questa messa in prova è alimentata dalla promessa di realizzarsi integralmente nel lavoro una volta che è svanita la dipendenza dalla macchina, consegnando libertà e autonomia inaudite: in definitiva, se io lavoratore, nel momento in cui posso disporre liberamente e autonomamente di tutto me stesso (mente, corpo, cervello e cuore), giacché svincolato dall’essere appendice macchinica, fallisco nel mettere a profitto i miei talenti, fallisco come persona detentrice di quei talenti, non unicamente come lavoratore.
A questo punto, di là dalla denotazione esistenziale, è lecito affermare che la condizione precaria determinata dalla privatizzazione del rapporto di lavoro e, a monte, dall’individualizzazione del lavoro è un potente dispositivo di controllo biopolitico che fa perno attorno a due grimaldelli contigui: 1) quello che apre le porte all’affiorare prepotente di un’automotivazione strettamente connessa con l’onere di rendersi capitale, con quanto segue in ordine all’illusorio perseguimento di un appagamento autorealizzativo assicurabile dalla necessità di risorse e relazioni umane spendibili in libertà e autonomia (illusorio perché funzionalisticamente animato dalla prospettiva biopolitica di agire dal di dentro, non attraverso la costrizione esterna, e strumentalmente teso all’adattarsi alle nuove forme organizzative e produttive); 2) quello che apre le porte alla paura di non rendersi capitale a sufficienza, rispetto alle aspettative del datore di lavoro e alle condotte altrui.
Riguardo al primo grimaldello, tornando all’incipit dell’articolo, l’antitesi non è ugualmente riproponibile, oggi, non perché la persona sia completamente subordinata alla macchina, ma perché la persona è indirettamente persuasa a diventare la nuova macchina e, quindi, ad autoalienarsi, accettando (volontariamente) il proprio travasamento nel contenitore della ratio capitalistica neoliberista. Secondariamente, l’antitesi non è riproponibile perché la precarietà impedisce il formarsi di una solidarietà tra lavoratori. E con questo veniamo alle considerazioni sul secondo grimaldello. La paura di non capitalizzarsi adeguatamente radica il soggetto in un eterno presente, rinnovato di giorno in giorno, fatto di sfide con se stesso e, soprattutto, con gli altri, esacerbando una competizione dettata dal desiderio di riconoscimento e, dunque, di conservare il posto di lavoro. In quest’ottica, la paura non è soltanto uno dei principali strumenti biopolitici di assoggettamento, diretto a prosciugare il fattore umano, ma è anche il tratto che svela un apparente paradosso delle (bio)politiche del lavoratore (Fumagalli, 2011, p. 76; Chicchi, 2011, pp. 21-22). Infatti, se da un lato l’intento biopolitico è quello di servirsi di ogni energia umana in una prospettiva collaborativa, dall’altro lato lo spettro della paura causa una concorrenza che potrebbe sembrare disfunzionale. Potrebbe, per l’appunto, ma non è disfunzionale e non è neppure una contraddizione, anzi reca tre vantaggi: il primo è quello di stimolare l’attuazione di comportamenti emulativi — per mezzo del sunnominato autocontrollo/controllo sociale — che livellano verso l’alto l’indice delle prestazioni senza intaccare il nucleo cooperativo della pratica; il secondo è quello di costruire gerarchie interne non imposte dall’alto; il terzo è quello di evitare il sorgere di una comune capacità politica di contrasto, organizzata e consapevole.
Precarietà e proiezione nel consumo
Ricapitolando, la condizione precaria, a muovere dal disegno di individualizzazione neoliberista e dal suo traslare il rischio tipicamente imprenditoriale nel lavoratore, mira all’autoattivazione complessiva al servizio del capitale e la paura che fisiologicamente accompagna siffatta condizione, sostenuta dal ricatto del bisogno, è in un certo qual modo giustificata proprio dalla seduttiva introiezione di quella subdola conversione antropologica che esaudisce la brama di autogoverno negata nel fordismo. Dire che è giustificata non significa dire che è mitigata, ma che è inconsciamente assunta come ineludibile contropartita nel gioco perverso della capitalizzazione di sé. Essa, in realtà, persiste con la sua morsa avvolgente e è vividamente presente con tutto il suo peso, quotidianamente.
Ora, l’appello al fenomeno antropologico vagliato in superficie solleciterebbe un approfondimento del medesimo in chiave biopolitica e anche del suo correlato sotto il profilo delle passioni gioiose appena accennate nelle pagine addietro (la tensione illusoria verso la realizzazione «e-ducativa» di sé) (Lordon, 2015). Ma, tenendo fermo l’oggetto di questo contributo, giova proseguire con la paura indotta dalla precarietà e con il suo intreccio con la tematica del consumismo.
Qualche anno fa, ne La solitudine del cittadino globale, Bauman asseriva che, dopo la caduta del muro di Berlino, il paradigma capitalista, in assenza di un’alternativa valida e praticabile, avesse ormai dilagato, occupando qualsivoglia ambito vitale e imponendo da un lato il mito della libertà del mercato e dall’altro la verità delle sue distorsioni utilitaristiche, incapaci di perseguire il bene comune e capaci, invece, di affossare qualunque parvenza di intervento politico in favore della legittimazione, promozione e consolidamento di un nucleo di valori diversi da quelli economici. L’effetto di questo dato di fatto, per il sociologo, è un esteso clima di apatia istituzionale e di apatia soggettiva, di sfiducia politica e generalizzata, di indifferenza che diffusamente sfocia nella disgregazione relazionale, nella chiusura, nel nichilismo e nel cinismo, di disagio esistenziale che sprigiona un’incertezza interpretabile secondo diverse accezioni. Ebbene, posto che concordiamo quasi totalmente con questa analisi — laddove il quasi suggerisce una distanza di vedute circa il ruolo della politica, che appare complice e non solo succube —, ciò che colpisce l’attenzione nell’introdurre il rapporto tra precarietà e consumismo è un’affermazione precisa del sociologo, riferita all’incertezza collegata ai meccanismi del neoliberismo: «il mercato prospera sull’incertezza» (Bauman, 2003, p. 38).
L’incertezza, in generale, è un ovvio portato dello sfaldamento pressoché recente di punti di ancoraggio e identificazione collettivi quali le grandi narrazioni, gli orizzonti ideologici, la coscienza di classe, la sfera pubblica della società dei lavoratori, ecc., e il ripiegamento su se stessi, ben esemplificato da U. Beck con il concetto di «individualization» (Beck e Beck Gernsheim, 2001), o almeno con la parte di esso che rimanda alla soggettivazione delle esperienze di crisi, ne è un derivato altrettanto ovvio. Tanto l’incertezza quanto questa introflessione sono a loro volta supportati dalle pervasive dinamiche dell’economico e, peculiarmente, attraverso il lavoro.
L’impossibilità di addivenire a una mediazione e condivisione profonda con l’altro, rimanendo invero su un piano di superficialità interattiva — a motivo della predetta frantumazione solidale, della fluidità dei rapporti, dei tempi e dei luoghi lavorativi originata dalla precarietà e citata in apertura e, nondimeno, delle politiche manageriali dell’incarico a termine entro un team work (Sennett, 2012, p. 18) — inducono il lavoratore a vivere in solitudine la propria condizione di sofferenza determinata dall’insicurezza dell’occupazione. La mancanza di un solido basamento relazionale, inoltre, non è solo utile a una concorrenza funzionale o a una decompressione preventiva di un’eventuale azione politica, ma serve a proiettare l’individuo verso l’unico appiglio sicuro che resta nella circolarità di quell’eterno presente in cui è gettato: la merce.
L’insicurezza, così, e di seguito la paura di non adempiere al proprio compito di soggetto economico cadendo nella disoccupazione sono attenuate dal consumo, che si trasforma nel «making sense della vita quotidiana» (Siri, 2004, p. 70). Il mercato, allora, prospera sull’insicurezza e, nello specifico, su quell’insicurezza accentuata in primis dal vissuto precario nell’ambito lavorativo, perché la «dittatura del tempo presente» capitanata dalla precarietà medesima è oltremodo strumentale all’espandersi del consumismo (Giorgetti Fumel, 2012, p. 17).
Il vuoto di ideali, valori e progettualità che si è venuto a creare e che è stato riempito dalla supposta potenza morale dell’homo oeconomicus, provocando un’insicurezza che ha acuito una già connaturale precarietà ontologica dell’essere umano e che ha rinchiuso l’uomo dentro di sé, è un vuoto colmato sì su scala macro, economicamente globalista e finanziariamente imbevuta, ma è tramite il micro — pur nella sua non necessità assoluta per la riproduzione autofaga del capitale (finanza) — che si realizza la captazione biopolitica delle condotte e il proposito bioeconomico di assorbire tutto l’umano, nell’orario lavorativo e non. Per questo, non è azzardato sostenere che il lavoro precario è una vera e propria fucina biopolitica e bioeconomica.
Tornando al rapporto tra precarietà e consumo, e per l’esattezza alla ciclicità del presente, merita rilevare che questa è significativamente simmetrica alla temporalità del consumismo, a quella «successione di adesso» che sostanzia il suo tempo «puntinista», espressione che Bauman (2010, pp. 41-42), nuovamente, utilizza mutuando da M. Maffesoli. Quale sia il nocciolo del nesso è presto spiegato. L’assolutizzazione del presente proprio dello stato di precarietà, il concentrarsi giocoforza sul momento, ostacola massimamente la sedimentazione dell’esperienza e tale impraticabilità, implicando per certi versi la scomparsa del soggetto (Adorno, 1979, p. 176), lo prepara ad assumere le uniche vesti consentite, quelle dell’«organo ricettivo del mercato», fondendosi con l’oggetto-merce (Giorgetti Fumel, 2012, pp. 20-21). Parimenti, il consumo che rende possibili la fusione e l’identificazione — e dapprima una relazione con l’oggetto che sostituisce l’inafferrabilità della relazione con l’altro soggetto — offre un’area esperienziale che sopperisce a una mancanza, ma al contempo, poiché appartiene a un tempo fatto di istanti e a una dimensione dell’effimero che rinvia alla regola aurea dell’iperconsumo, ossia il principio della gettabilità e del rimpiazzo del bene (Lipovetsky, 2007, p. 307), la persona è costantemente calata in un alveo di insoddisfazione che rigenera insicurezza. In breve, trattasi di un corto-circuito e, pertanto, affermare che la merce è un appiglio sicuro, significa solo questo, che c’è, che non è sottoposta al regime dell’incertezza, che è sempre sotto gli occhi indipendentemente dalla variabilità plausibile degli ambienti lavorativi e che attenua, come anzidetto, ma non dissolve l’angoscia del lavoratore precario.
Il richiamo all’angoscia permette, in dirittura d’arrivo, di recuperare la solitudine della sua sperimentazione e di meditare sull’inagibilità di un’interazione profonda e sull’isolamento del lavoratore per fornire un’ultima considerazione. La fissità asociale sul presente, non consentendo una dilatazione del desiderio nel futuro, è proficua per l’obbedienza all’imperativo consumistico del godimento immediato, ma pure per quell’autoreferenzialità del godimento che contrassegna l’epoca dell’iperconsumo. In altre parole, l’affidamento sulle sole proprie forze che il lavoratore odierno, precario, autoimprenditore, esperisce, tracima in un appagamento autistico che replica l’autosufficienza alla quale è abituato. Se non esiste più il terreno di coltura della solidarietà di gruppo/classe, perché inaridito dalla precarietà e dai suoi annessi e connessi a monte e valle, anche l’atto del consumare risente di intenzionalità individualistiche, orientate, per dirla con Lipovetsy (2007, pp. 25-26), alla ricerca della felicità privata, alla esclusiva soddisfazione intima. E la relazione con l’oggetto, che surroga la relazione con il soggetto, non può che essere una relazione con un sé ingurgitato dalle cose. Certo, altre variabili concorrono alla spiegazione del perché sia cambiata in questo modo la tensione consumistica, eppure è innegabile che le condizioni di lavoro e le modalità stesse di lavoro corrispondano a una variabile causale non trascurabile sul versante antropologico, come è innegabile — Ford docet — che il lavoratore è sempre il primo consumatore.
Lavoro e educabilità negata
A fronte di questa disamina, critica, volutamente radicale ed estremizzata in alcune sue pieghe affinché emergesse nitida una realtà avvalorata dalla letteratura scientifica e dalla vita, sorgono alcuni input di matrice pedagogica e educativa, la cui messa in trasparenza informerà questo paragrafo finale.
È fuori di dubbio che la rappresentazione di un lavoro di simile fattezza, incline a rinnovare una servitù piuttosto che a liberare da quelle già note, sia foriera di un’educabilità tanto decantata dai teorici delle organizzazioni e del capitale umano quanto inautentica. Molte potenzialità umane messe in campo potrebbero far pensare al concretarsi di un auspicabile progetto neo-umanistico del lavoro post-fordista, ma le finalità soggiacenti deviano da questa ipotesi. L’attività lavorativa si carica di aspettative etimologicamente educative vanificate dall’intento di una spremitura a tutto tondo e il divenire precari, al di là dalle motivazioni vere o presunte delle crisi economiche, è la via che facilita un asservimento incoraggiato dalla mutazione genetica del capitalismo come processo. Un capitalismo che non è più circoscritto nel tempo e nello spazio, che si è smarcato da compromessi sociali, che si è imposto come cultura egemonica e che si è affrancato dalla morsa della dialettica con il lavoro. Un capitalismo privo di limiti, direbbe Lordon (2015, p. 58), che attraverso il lavoro, a partire dal lavoro, condiziona l’agire di un popolo, dei popoli. Perché gli individui pensino in un certo modo, perché si comportino in un certo modo, perché consumino in un certo modo (Demichelis e Leghissa, 2008, p. 7).
Un’ambizione educativa, di autorealizzazione, di rinvenimento di senso e significato non può insistere su un’opera biopoliticamente intrisa e una speranza educativa non può albergare in un impiego che sfuma all’improvviso per una fluttuazione di mercato, per un’altalena borsistica, per uno spread in rialzo, per una ristrutturazione necessitata, per una delocalizzazione, per salari risibili rintracciabili altrove, per la libertà pretesa dal mercato. Questo non è catastrofismo pedagogico, bensì è constatare un’inattuabilità educativa testimoniata dalla verità del progresso dell’individualizzazione contrattuale, dell’ampliarsi della precarietà e dell’impossibilità di distinguere lavoro e vita nel lavoro produttivo (e trasversalmente in ogni settore), dell’incremento della disoccupazione pre e post-crisi, del transito sensibile dalle politiche del lavoro alle politiche del lavoratore, dell’aumento dello stress lavorativo e del consumo di sostanze psicotrope per alleviarlo (Casiccia, 2008, p. 128; Cipolla e Lombi, 2012), dell’indebitamento per il consumo nonostante la certezza dell’instabilità occupazionale (Lucidi, 2015).
Per tutte queste ragioni e, per di più, sulla scia della consapevolezza che l’interesse della pedagogia italiana in materia di lavoro (e economia) conta pochi cultori a dispetto della rilevanza dei riflessi educativi e formativi delle questioni in ballo, la pedagogia ha il dovere di preoccuparsi e occuparsi di problemi che investono le traiettorie di sviluppo umano e la dignità della persona. Nello specifico, al fine di non essere ridondanti, riproponendo sollecitazioni già avanzate sulla sponda della formazione professionale iniziale e continua, dell’educazione economica, della formazione emotiva dei lavoratori e dell’edificazione educativa di una figura antropologica (l’homo col-laborans) opposta a quella dell’homo oeconomicus, la pedagogia ha il dovere di intervenire su ulteriori due livelli: quello politico e quello della formazione e dell’aggiornamento degli insegnanti e dei formatori.
Circa il primo, quanto si domanda, facendo appello a una comune coscienza pedagogica che trascende la maggiore o minore competenza di ricerca, è che i pedagogisti prendano posizione sulle interconnessioni tra economia e politica, cominciando col partecipare attivamente al dibattito pubblico sugli argomenti che dovrebbero stargli massimamente a cuore. Ad esempio, la prevalente funzionalizzazione dell’apprendimento, della conoscenza e del sapere propugnata dalle politiche del lifelong learning, fortemente sbilanciate a vantaggio delle esigenze del mercato e delle sue trasformazioni; la funzione tendenzialmente adattiva ai processi economici riservata alla reintroduzione dell’educazione economica nella scuola (secondaria) dalla riforma varata nel luglio dello scorso anno, dove la cornice teorica (documenti di preparazione) che delinea l’identikit di quella che è essenzialmente un’alfabetizzazione economico-finanziaria risponde eminentemente a bisogni cognitivi di presa d’atto; lo scopo, ancora tendenzialmente e meramente adattivo, con cui è ripresentata l’alternanza scuola-lavoro; la stessa visione produttivistica della scuola (Baldacci, 2015).
Circa il secondo livello, quanto si domanda è che i pedagogisti facciano tesoro di tutte le occasioni e di tutti i mezzi loro concessi per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti e per la formazione e l’aggiornamento dei formatori dell’Iefp (istruzione e formazione professionale) di modo che l’istruzione in ambedue i canali non escluda il coraggio di educare; ovverosia il coraggio di svincolarsi dalle traiettorie di perpetuazione/assuefazione di/a un certo ordine economico-lavoristico e di agevolare, dunque, l’implementazione di una coscienza vigile e di uno spirito critico relativamente al dato di realtà, alle sue cause e ai suoi molteplici effetti. (Questo, naturalmente, comporta in prima battuta che gli attuali e futuri insegnanti e formatori medesimi siano portati a indagare in profondità una condizione di precarietà che, peraltro, non li ha esentati, non li esenta in via assoluta tuttora e probabilmente non li esenterà da essa). Quello che si chiede, insomma, grazie alla formazione e all’aggiornamento degli insegnanti e dei formatori e alla loro previa cointeressenza nelle trame precarie, è che il sistema di istruzione e formazione aiuti i giovani a sondare e interrogare criticamente l’agire economico, prendendo le mosse dal porre in risalto e sviscerare il concetto di vendibilità di sé e l’ambivalenza implicita nella precarietà.
L’espressione vendibilità di sé sintetizza esemplarmente i dinamismi vagliati in rapporto all’autoimprenditoria neoliberista, all’autoalienazione non conflittuale, all’autoannientamento nell’oggetto di consumo (vendersi alla merce) e sintetizza, ugualmente, una tendenza che i nostri giovani conoscono bene e alla quale sembrano aderire sempre più, forse per sfuggire a un destino precario e sicuramente perché precocemente stretti dai tentacoli bioeconomici: non vendersi alla merce, ma vendersi come merce, tramutando il (video)gioco postato on line, le loro abilità ludiche, il loro divertimento, la loro simpatia, la loro ironia, ecc. in oggetto digitale di consumo idoneamente remunerato da sponsor vari; in fin dei conti è un altro pezzo di vita che si arrende all’economico, come accade anche con i social media in genere.
Per quanto concerne la predetta ambivalenza, merita rilevare che quella precarietà che punta sul presunto, riscattato primato della agency umana quale libertà di disporsi capitalisticamente (o libertà di non farlo perdendo il lavoro), e che sospinge con diversi strumenti la presunta libertà di godere con il consumo, non riesce a nascondere un esito boomerang. La libertà colta sotto il segno della soggettivazione positiva — negata nel fordismo e ricompresa strumentalmente nel post-fordismo come anticipato —, non può essere soffocata, mascherata e deviata all’infinito. Difatti, e qui sta l’ambivalenza, iniziano ad affiorare le prime, timide e estemporanee istanze di giustizia e temporalità sociale, ancorché disorganiche per i motivi addotti, connesse con una sincera autonomia soggettiva nel lavoro (così come iniziano a radicarsi le prime iniziative di consumo responsabile, critico, sostenibile, ecc.). In sostanza, se la precarietà ha svilito e schiacciato la libertà, esaltandone la finta sagoma, la libertà vera sta lentamente rialzandosi da terra, perché la precarietà, «nel momento in cui intende attivare la “libera” e docile disposizione dei soggetti al mercato [del lavoro e dell’iperconsumo], al contempo non può far altro che incrinare un equilibrio che è interno a quello stesso potere e alla sua sovrastrutturale trappola consumatoria» (Chicchi, 2012, p. 136). Non è dato di sapere quando questa libertà si ergerà definitivamente, ma è ammissibile pensare che agire educativamente in direzione di una coscientizzazione e padronanza critica, favorendo il configurarsi di una cittadinanza attiva e proattiva, faciliterà tanto il movimento esteso verso l’alto quanto un movimento condiviso, articolato e di impatto significativo.
In conclusione, sia l’invito a un impegno pedagogico di marca politica, a muovere dalle questioni attigue agli interessi tradizionali o recenti fino a comprendere la relazione più vasta tra pedagogia e economia, sia l’invito a destare educativamente gli animi si collocano in un’area culturale d’intervento che ha per obiettivo, non il ripristino della società del lavoro, ma il riposizionamento del lavoro (non soltanto produttivo) e dell’economico tra i mezzi della crescita umana. Con il sobbarcarsi un puntuale onere politico e, soprattutto, con uno scuotimento dal basso a largo raggio, il pedagogico potrebbe contribuire non poco a destabilizzare un sostrato culturale che, con i suoi riduzionismi antropologici e le sue ideologie di scorta, si è prepotentemente insinuato nei meandri dell’essenza e dell’esistenza umana (lavorativa e non), negando dignità di cittadinanza alla dimensione educante del noi e ai «beni relazionali» (Bruni, 2013).
Bibliografia
Adorno T.W. (1979), Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, Torino, Einaudi.
Baldacci M. (2015), I punti critici del documento «La Buona Scuola». In M. Baldacci, B. Brocca, F. Frabboni e A. Salatin, La Buona Scuola. Sguardi critici dal Documento alla Legge, Milano, FrancoAngeli, pp. 11-38.
Bauman Z. (2003), La solitudine del cittadino globale, Milano, Feltrinelli.
Bauman Z. (2010), Consumo, dunque sono, Roma-Bari, Laterza.
Beck U. e Beck Gernsheim E. (2001), Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, London, Sage.
Bruni L. (2013), Economia e antropologia del «noi»: La sfida della gratuità. In G. Gabrielli (a cura di), La diversità come dono e sfida educativa, Milano, FrancoAngeli, pp. 134-142.
Calvino I. (1995), Antitesi operaia. In Id., Una pietra sopra, Milano, Mondadori.
Casiccia A. (2008), Vita, lavoro, autonomia nella condizione umana contemporanea. In L. Demichelis e G. Leghissa (a cura di), Biopolitiche del lavoro, Milano-Udine, Mimesis, pp. 127-142.
Chicchi F. (2011), Introduzione. Scenari, resistenze e coalizioni del lavoro vivo nel capitalismo contemporaneo. In F. Chicchi e E. Leonardi (a cura di), Lavoro in frantumi. Condizione precaria, nuovi conflitti e regime neoliberista, Verona, Ombre Corte, pp. 7-24.
Chicchi F. (2012), Lavoro in frantumi: Sofferenza e desiderio nell’epoca della precarietà generalizzata. In M. Giorgetti Fumel e F. Chicchi (a cura di), Il tempo della precarietà. Sofferenza soggettiva e disagio della postmodernità, Milano-Udine, Mimesis, pp. 117-136.
Cipolla C. e Lombi L. (a cura di) (2012), Droga, mondo del lavoro e salute, Milano, FrancoAngeli.
Combes M. e Aspe B. (1998), Revenu garanti et bio-politique, «Alice», vol. 1, pp. 49-53, http://multitudes.samizdat.net/Revenu-garanti-et-biopolitique (ultimo accesso: 29/07/2015).
d’Aniello F. (2015), Le mani sul cuore. Pedagogia e biopolitiche del lavoro, Fano, Aras.
Dardot P. e Laval C. (2013), La nuova ragione del mondo. Critica della ragione neoliberista, Roma, DeriveApprodi.
Demichelis L. e Leghissa G. (2008), Premessa. In L. Demichelis e G. Leghissa (a cura di), Biopolitiche del lavoro, Milano-Udine, Mimesis, pp. 7-12.
Durand J.-P. e Le Floch M.-C. (a cura di) (2006), La question du consentement au travail. De la servitude volontaire à l’implication contrainte, Paris, L’Harmattan.
Foucault M. (2005), Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Milano, Feltrinelli.
Fumagalli A. (2011), La condizione precaria come paradigma biopolitico. In F. Chicchi e E. Leonardi (a cura di), Lavoro in frantumi. Condizione precaria, nuovi conflitti e regime neoliberista, Verona, Ombre Corte, pp. 63-78.
Giorgetti Fumel M. (2012), Introduzione. Riflessioni sul tempo della precarietà. In M. Giorgetti Fumel e F. Chicchi (a cura di), Il tempo della precarietà. Sofferenza soggettiva e disagio della postmodernità, Milano-Udine, Mimesis, pp. 11-34.
Gorz A. (2003), L’immateriale. Conoscenza, valore e capitale, Torino, Bollati Boringhieri.
Lipovetsky G. (2007), Una felicità paradossale. Sulla società dell’iperconsumo, Milano, Raffaello Cortina.
Lordon F. (2015), Capitalismo, desiderio e servitù. Antropologia delle passioni nel lavoro contemporaneo, Roma, DeriveApprodi.
Lucidi J.S.S. (2015), Aumentano i consumi grazie all’indebitamento. Le basi per una nuova crisi finanziaria, http://scenarieconomici.it/aumentano-i-consumi-grazie-allindebitamento-le-basi-per-una-nuova-crisi-finanziaria/ (ultimo accesso: 15/02/2016).
Marazzi C. (1999), Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell’economia e i suoi effetti nella politica, Torino, Bollati Boringhieri.
Marchetti A. (2010), Il tempo e il denaro. Saggi sul tempo di lavoro dall’età classica all’epoca della globalizzazione, Milano, FrancoAngeli.
Morini C. e Fumagalli A. (2010), Life put to work: Towards a life theory of value, «Ephemera. Theory & Politics in Organizations», vol. 3-4, pp. 234-252, http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/10-3morinifumagalli.pdf (ultimo accesso: 09/02/2016).
Revelli M. (2001), Oltre il Novecento. La politica, le ideologie e le insidie del lavoro, Torino, Einaudi.
Sennett R. (2012), Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione, Milano, Feltrinelli.
Siri G. (2004), Società dei consumi e nuove identità. L’evoluzione della persona all’inizio del terzo millennio, tra globalizzazione economica e frammentazione del sé, «Sociologia del lavoro e dei consumi», vol. 1, pp. 61-70.
Autore per la corrispondenza
Fabrizio d’Aniello
Indirizzo e-mail: fabrizio.daniello@unimc.it
Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata, P. le Bertelli 1, Contrada Vallebona, 62100 Macerata.
© 2016 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.
Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo effettuata, se non previa autorizzazione dell'Editore.