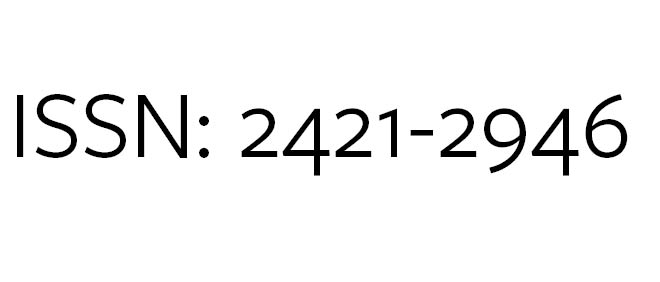Premessa
C’è un popolo al mondo per cui il futuro è alle spalle e il passato davanti agli occhi. Questo popolo, gli Aymara, condivide parte dell’altopiano andino e vive fra la Bolivia, il Perù e l’Argentina. Nonostante vivano su un territorio così vasto, gli Aymara sono riusciti a mantenere comuni lingua e culti tradizionali. Quando alcuni ricercatori, per lo più antropologi e linguisti, iniziarono le loro indagini in questa parte del mondo, si accorsero che per gli Aymara il tempo scorreva in modo diverso dal nostro, all’inverso (Núñez e Sweetser, 2006, pp. 1-49).
Nella loro lingua la dimensione temporale coincide con quella spaziale, per cui quando in un discorso un Aymara si rivolge al passato utilizza la parola narya che letteralmente significa “sguardo rivolto in avanti”. Viceversa, quando si rivolge al futuro utilizza l’espressione quipa ovvero “dietro”. Oltre che alla lingua, anche la loro gestualità confermerebbe la concezione retrospettiva di questo popolo, per cui la frase “progettiamo il nostro futuro”, consuetudine in tutte le altre culture, si svuoterebbe dei significati esistenziali e pedagogici che siamo soliti attribuire ad essa.
Pertanto, mentre noi quando vogliamo raccontare del nostro passato facciamo cenno con le braccia e onduliamo le mani dietro le spalle quasi a voler toccare il punto ideale in cui inizia il racconto, gli Aymara le muovono in avanti, nel tentativo di individuare qualche evento memorabile posto di fronte ai loro occhi. Senza addentrarci nelle diverse interpretazioni dei ricercatori a questa “capovolta” concezione del tempo, quando sentii parlare per la prima volta degli Aymara mi domandai quali fossero stati i motivi che avevano spinto questo popolo a raccontare gli eventi del passato come se fossero ancora lì, a un passo, davanti ai loro occhi. Forse gli Aymara possono insegnare molto a chi come noi prova a immaginare scenari futuri possibili pur mettendo gli eventi passati metaforicamente dietro le spalle. Questo studio poggia sull’ipotesi di riconoscere l’esercizio della memoria e la pratica narrativa importanti investimenti sul futuro per il soggetto. Infatti, oltre al denaro, possiamo fare economia personale di ricordi, di esperienze, di storie, per i cui rendimenti occorrerà attendere tempi lunghi ma con garanzie di sviluppo certe sul piano sia individuale sia collettivo.
Educando il soggetto già da bambino alle narrazioni e alla loro condivisione, esplorazione ed elaborazione, i racconti “minori”, soltanto in apparenza superficiali e privi di una trama, di personaggi e scenario, trasformeranno i minori a rischio devianza in adulti capaci di emanciparsi e allontanarsi dai territori, mentali e fisici, della marginalità, poiché avranno imparato a meglio sostenere il desiderio, a produrre un’influenza diretta sulla realtà e a proiettare, consapevolmente, se stessi nel futuro.
Imparare a memoria: learn off by heart
Il fatto di intendere, quasi in modo esclusivo, la memoria come una funzione cognitiva è la prima e importante evidenza scientifica che riguarda il tema trattato in questo studio. Avendo avuto negli anni l’opportunità di discutere dei nessi esistenti fra memoria, esperienza e narrazione con docenti e studenti nelle università e nella scuola, e con famiglie, ospiti e formandi in altri contesti educativo-formativi, quando provavo a chiarire la mia direttrice di ricerca introducendo nella discussione la parola memoria, accadeva spesso di essere interrotto con frasi del tipo: “io non riesco a memorizzare, mi piacerebbe imparare a ricordare meglio!”. Non potendo attribuire al caso la ricorrenza delle medesime risposte in setting anche molto diversi fra loro e in presenza di soggetti di età e ruoli differenti, emerse lo stimolo che mi indusse a esplorare ulteriormente l’argomento.
Accanto al pensiero, al linguaggio, all’attenzione, alla percezione, all’affettività, alla volontà, all’intelletto, la memoria è una fra le più importanti funzioni cognitive messe a disposizione dell’uomo dalla natura (Boncinelli, 2011).
Appena veniamo al mondo la memoria è continuamente sollecitata dalle occasioni di sviluppo offerte dal contesto sociale di riferimento, che diventa una vera e propria “aula di apprendimento estesa” all’interno della quale il bambino, svezzato culturalmente, impara a nutrirsi del mondo esterno. Nel tempo le informazioni diventano innumerevoli e il bambino inizia a sviluppare e affinare tutta una serie di stili cognitivi e strategie di apprendimento indispensabili per ritenere al meglio questa enorme mole di dati assieme alle esperienze, ai luoghi, ai volti, alle sensazioni e agli odori. In fase evolutiva, il bambino dispone di un repertorio di funzioni cognitive: di base e superiori, che poi la cultura mescola opportunamente nel pervenire a un “mix mentale” equilibrato.
Le funzioni cognitive di base offrono al bambino l’immediata possibilità di interconnettersi con il mondo esterno, con il mondo abitato dagli altri bambini e progettato dagli adulti, attraverso l’apprendimento graduale del linguaggio, la pratica del pensiero e l’esercizio della memoria riguardo le esperienze passate. Secondo Gopnik, già a partire dal quarto anno di età il bambino è in grado di mettere in correlazione le esperienze di vita, sebbene esigue, con gli insegnamenti che da queste derivano[1] (Gopnik, 2010, p. 149). Dopo la comparsa di questa sorta di “autobiografo interno”, ancora immaturo ma già capace di mettere in relazione le dimensioni temporali del presente, del passato e del futuro inanellandole fra loro, il bambino inizierà a sperimentare una serie di varianti mentali che negli anni gli consentiranno di superare la prospettiva egocentrica, comprendere a pieno i codici culturali e i linguaggi con cui viene a contatto, valorizzare l’apporto dell’altro e progettare il suo futuro (Perucca e De Canale, 2012).
Osservare, esplorare, analizzare, fare sintesi e formulare ipotesi sintetiche di soluzione dei problemi rappresentano invece le funzioni cognitive superiori, che garantiscono l’entrata e la partecipazione nel mondo del bambino.
In seguito, con lo sviluppo della meta-cognizione,[2] ovvero con la capacità generale di riflettere e gestire al meglio le proprie funzioni cognitive di base e superiori, il bambino diviene l’attore protagonista della sua vita e il costruttore più meticoloso della sua personalità.
Raggiungere la consapevolezza di come funzioniamo da un punto di vista cognitivo, ovvero essere consapevoli di come memorizziamo e apprendiamo, delle modalità attraverso le quali formuliamo le ipotesi nella risoluzione di un problema e dei tempi entro i quali si manifesta il nostro pensiero riflessivo e, ancora, di come integriamo le informazioni provenienti da fonti plurime, generiamo alternative nella risoluzione di un problema, automonitoriamo i processi di apprendimento, valutiamo le difficoltà di un compito, implementiamo il piano strategico scelto, prevediamo i tempi di risoluzione, autovalutiamo e autorinforziamo la spiegazione di un eventuale insuccesso, in breve di come funziona la nostra mente, ci dà la possibilità di essere in qualche modo padroni dei nostri progetti e del nostro futuro.
Purtroppo, in diverse occasioni abbiamo constatato come la scuola di oggi e la didattica praticata nelle sue aule stentino a favorire l’utilizzo di questo potentissimo “puntello di progettazione del Sé”, la metacognizione appunto, che offre opportunità alternative di sviluppo, individuale e collettivo, sia sul piano dei saperi disciplinari, sia sui piani esistenziale, psicologico e sociale. Richiamando De Montaigne, lo slogan pedagogico gridato da Morin al mondo delle istituzioni che si occupano di educazione e formazione: “è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena” (Morin, 2000), evidenzia come oggi più di ieri sia necessario riformare il pensiero nell’ottica dell’organizzazione delle conoscenze e dello sviluppo delle competenze chiave e delle intelligenze personali.
Come Baldacci ha osservato, nell’epoca della società conoscitiva sarebbe più utile integrare fra loro diversi modelli di didattica che, assieme, potrebbero meglio costruire le competenze di base, le fondamenta dell’apprendimento appunto, favorire lo sviluppo dei processi cognitivi di base e superiori, arricchire culturalmente e fare emergere i talenti personali racchiusi nel guscio duro della personalità in divenire di ogni studente (Baldacci, 2004).
Potrebbe non essere solo un caso, infatti, che molti dei nostri compagni di scuola, quelli che venivano etichettati dagli insegnanti come i “campioni della memoria”, abbiano oggi vite professionali monotone e prive di quell’interesse, curiosità e tensione esplorativa che, al contrario, caratterizzano le vite degli individui che hanno avuto l’opportunità di scoprire le strategie cognitive più adeguate per rispondere alle continue e stressanti sollecitazioni del mondo esterno, vivendo all’interno di una cornice temporale e spaziale collettiva.
Nella maggior parte dei casi, chi a detta degli insegnanti possedeva a scuola una memoria prodigiosa, da mnemonista, negli anni non ha saputo riflettere adeguatamente su se stesso, sulla propria vita e sulle proprie esperienze, e per queste ragioni, probabilmente, oggi ha ancora poca padronanza di quei processi mentali che gli avrebbero garantito un più adatto posto nel mondo. Come a voler sottolineare che le “traiettorie dell’apprendimento” possono percorrersi a patto che il soggetto sia educato, e a sua volta si educhi, all’esplorazione delle proprie risorse emotive, cognitive, metacognitive e relazionali.
Quando dialogo con gli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado, la mia preoccupazione più grande è proprio quella di favorire questa scoperta interiore, le occasioni dell’apprendimento autodiretto[3] le chiama Quaglino (2004), ovvero l’abilità di mettere la lente di ingrandimento sui meccanismi di funzionamento della nostra mente e delle sue facoltà, fra le quali anche la memoria.
La memoria, fortunatamente, è solo in minima parte immagazzinamento di informazioni, e noi non siamo certamente database in carne e ossa da riempire di dati fino a raggiungere la massima capacità portante. Se avessimo una concezione così ristagnante e immobile della memoria, nella migliore delle ipotesi rischieremmo nel tempo un’indigestione, seguita da conati, di informazioni ritenute[4] (Granieri, 2007). Come noto, chi apprende “a memoria” tende più facilmente a perdere l’informazione acquisita. Fin da piccoli, accogliendo i consigli dei più grandi e dei maestri di scuola, prima di ripetere davanti ai parenti ciò che avevamo imparato come una cantilena, la maggior parte di noi ha esercitato la memoria riflettendosi in ogni specchio presente in casa. Con molta probabilità, di quelle ore interminabili passate a ripetere le poesie riflessi in uno specchio e poi in piedi su una sedia durante le occasioni importanti, rimarrà poco, poiché le informazioni, come le esperienze di vita, vanno certamente narrate e riflettute ma a partire da se stessi e allargando gli spazi della riflessione nella direzione dei compagni di classe, degli insegnanti, dei genitori, della famiglia e della società.
Per sostentarsi la memoria ha bisogno, al contempo, di riflessione e cooperazione, di conoscenza di Sé, disponibilità e conferma collaborativa e soltanto una scuola capace di offrire ai suoi studenti una didattica attenta ai processi di apprendimento e ai suoi fattori emotivo-affettivi, all’apprendimento cooperativo, allo sviluppo delle funzioni cognitive di base e superiori e alla scoperta delle intelligenze personali, sarà in grado di intenderla come il più potente strumento evolutivo di cui la specie umana dispone.
Imparare “a memoria”, learn off by heart, è inevitabilmente imparare fuori dal cuore. Al contrario, la memoria si alimenta di emozioni e trova proprio nelle esperienze vissute “ad alta intensità affettiva” il suo ambiente ideale di sviluppo.
Dunque, è preferibile che qualunque “traiettoria dell’apprendimento” passi dal cuore, poiché nell’evitare di sostarvi – nel tentativo ingenuo di ricercare scorciatoie o strade alternative – il soggetto potrebbe facilmente perdersi.
Le parole della memoria
La seconda evidenza emersa dagli studi sulla memoria effettuati in questi anni riguarda la presenza nella letteratura di una moltitudine di aggettivazioni, connotazioni e specificazioni che caratterizzano il costrutto.
Sotto forma di wordcloud, nuvola di parole, la figura 1 riportata di seguito racchiude, non esaustivamente, una parte degli aggettivi attribuiti al costrutto di memoria rinvenuti nei testi che si occupano del medesimo argomento pur entro differenti confini disciplinari. Così, per uno storico esiste una memoria storica, per un sociologo una memoria sociale (Halbwachs, 1997), collettiva (Halbwachs, 2001) o comune (Margalit, 2006), per un neurologo una memoria procedurale e dichiarativa (Papagno, 2008), e via dicendo. Come pure, per un antropologo, psicologo, musicista, ecc., che indaga il costrutto di memoria sempre all’interno di uno specifico ambito di ricerca e di azione. Con grande sorpresa, l’argomento memoria come categoria pedagogica non compare nei testi e nelle ricerche di chi si occupa di processi e interventi in ambito educativo-formativo.

Fig. 1 Le parole della memoria.
La sovrabbondanza degli aggettivi della memoria rinvenuti nelle pubblicazioni scientifiche sembra corrispondere alla sovrabbondanza delle attribuzioni registrate dai soggetti nei diversi setting educativo-formativi nei quali ho indagato il costrutto; gli individui interpellati in aula a riflettere sul tema della memoria definiscono il costrutto richiamando, anche se spesso in modo confusivo, una moltitudine di aggettivi.
Se in un primo momento abbiamo osservato come la memoria venga intesa quasi esclusivamente nei termini di una funzione cognitiva di base, la presenza, nei testi e nelle teste, di numerosi aggettivi attraverso i quali è possibile connotarla potrebbe complicare ulteriormente i processi di insegnamento-apprendimento, specie nel momento in cui si tenta di pervenire a una definizione sufficientemente esaustiva.
Immagini mentali e metafore della memoria
La confusione generata dalla difficoltà di individuare aggettivi universalizzabili del costrutto tende a ridursi nel momento in cui si tenta di fare emergere le immagini mentali e le metafore della memoria dei soggetti in formazione.
Infatti, quando i ricercatori decidono di indagare le “strutture di conoscenza” della memoria, ovvero esplorare le modalità attraverso le quali il soggetto si fa un’idea del suo funzionamento mentale e del funzionamento mentale dell’altro, spesso si assiste all’emersione di rappresentazioni mentali della memoria maggiormente generalizzabili. Conseguentemente, la rappresentazione mentale è un “concentrato interpretativo” che ogni soggetto realizza nel tentativo di ritenere, organizzare e interpretare le informazioni e i dati provenienti dal mondo esterno.
La rappresentazione mentale è dunque un “filtro”, emotivo e cognitivo al contempo, tra il mondo interno e il mondo esterno, posto nella distanza metaforica che divide il Sé dall’Altro.
I cinque sensi, assieme a tutto ciò che fino a quel momento siamo stati, ovvero le nostre esperienze, il nostro background culturale, il sesso, l’età, la razza, la religione, ecc., sunteggiano la conoscenza generando specifiche rappresentazioni che immagazzinano e strutturano le informazioni sotto forma di immagini, di scripts (copione, sceneggiature), di frames (quadro di riferimento, cornice), di sequenze di azioni, schemi o eventi (Santoianni e Striano, 2000).
Oltre alle immagini mentali, un secondo “concentrato interpretativo” utilizzato dall’uomo per organizzare, comprendere e costruire la realtà è la metafora.
Da un punto di vista psicologico la metafora, dal greco meta-pherein, che letteralmente significa “trasferire”, “trasportare”, permette l’elaborazione delle informazioni, la strutturazione di schemi di conoscenza nuovi a partire da vecchi e il cambiamento delle nostre strutture emotivo-cognitive. Dunque, per le scienze cognitive e la linguistica moderna la metafora non consiste solamente in un fenomeno linguistico di violazione semantica utilizzata per fini retorici, poetici o semplicemente espressivi, ma, come fenomeno che trova collocamento tra il pensiero e il linguaggio, rappresenta un importante processo cognitivo attraverso il quale domini di conoscenza già consolidati possono essere utilizzati per svilupparne di nuovi (Gelo e Mergenthaler, 2003, pp. 53-65).
In altri termini, la metafora permette di parlare di “qualcosa nei termini di un’altra”. Ad esempio quando affermiamo che nelle nostre esperienze “finiamo sempre per combattere”, non facciamo altro che mettere in risalto l’aspetto combattivo nel proteggere una nostra idea, tralasciando tutto ciò che riguarda l’aspetto cooperativistico (Giusti e Ciotta, 2005).
Ritornando al nostro esperimento psico-sociale di emersione delle strutture di conoscenza, alla domanda “qual è l’immagine che meglio può rappresentare per te la memoria?”, la maggior parte dei soggetti risponde con disegni che la raffigurano come una scatola, un magazzino, un deposito, un contenitore, un archivio, un cassetto, una libreria, una cartella, un’agenda.[5] Soltanto pochi scelgono di raffigurare la memoria diversamente, ad esempio attribuendo ad essa l’immagine di un treno, di un albero, di un pianeta, di un iceberg, di un processo ciclico.
Senza mai introdurre nella discussione alcuna informazione che avrebbe di certo potuto generare una modifica, sebbene momentanea, delle rappresentazioni mentali della memoria dei soggetti, i disegni raccolti offrono lo spunto per avviare alcune interessanti riflessioni sulla complessa operazione pedagogica di educabilità cognitiva (Baldacci, 2012) o di modellaggio delle rappresentazioni mentali.
In ambito pedagogico il concetto di educabilità cognitiva è introdotto da Massimo Baldacci. Per il pedagogista la forma mentis, o mentalità, è la struttura cognitiva di un soggetto che si esprime nei termini di un particolare modo di vedere le cose. Si tratta dunque dell’insieme di disposizioni mentali, durevoli e fondate su abitudini e credenze personali, attraverso le quali ognuno di noi valuta le situazioni, esprime un giudizio e compie delle azioni.
È possibile lavorare pedagogicamente per “educare” tali strutture cognitive innanzitutto certificando la disponibilità al cambiamento del soggetto interessato all’azione educativa e, in un secondo momento, attraverso la permanenza in adeguati e condivisi setting formativi in grado di fare emergere schemi di pensiero alternativi eventualmente implementabili dallo stesso.
L’operazione di modellamento cognitivo, o lavoro meta-rappresentazionale, necessita di “tempi pedagogici”, ovvero di lassi temporali medio-lunghi di apprendimento; di conseguenza gli studenti in possesso di specifiche rappresentazioni di memoria non potrebbero mai in tempi brevi, ad esempio ricorrendo a qualche ora di esercitazione in aula, modificare completamente le proprie rappresentazioni mentali.
Tuttavia, può accadere che nel momento in cui il docente decide di introdurre in una discussione un nuovo elemento di riflessione, al quale potrebbe seguire una successiva modifica rappresentazionale, il soggetto avverta una sorta di shock cognitivo o di apprendimento che può influenzare momentaneamente il suo pensiero, condizionandolo. Pertanto, lo shock cognitivo è soltanto il primo momento di un processo graduale di modellaggio mentale che necessita di ulteriore tempo, confronto, pensiero riflessivo ed esperienza.
Lavorando nel nostro caso con le immagini mentali e con le metafore della memoria, occorre domandarsi se esistano e quali siano le forze culturali e le dinamiche familiari e sociali che spingono gli studenti, ma anche gli adulti incontrati in altre occasioni e in altri setting di formazione, a rappresentare la memoria come una funzione statica, autobiografica e retrospettiva e non dinamica, sociale, prospettica e, per queste ragioni, tendente alla ricerca di significati capaci di dare senso alle esperienze del soggetto e delle comunità.
L’esperimento laboratoriale psico-sociale di emersione e modellaggio delle rappresentazioni mentali, ripetuto più volte in questi anni di ricerca, confermerebbe come, nella maggior parte dei casi, i soggetti considerino la memoria nei termini di una funzione cognitiva di base privilegio del singolo, destinata alla memorizzazione e pertanto priva di elementi di dinamicità, socialità e processualità.
La scatola dei ricordi fragili
Se dovessimo rappresentare con un’immagine la memoria, le ricerche confermerebbero, dunque, che la maggior parte di noi sceglierebbe di raffigurarla disegnando una scatola. Anche per gli studenti partecipanti agli esperimenti laboratoriali di emersione delle rappresentazioni mentali della memoria, i ricordi legati alle esperienze di vita e di apprendimento vanno raccolti in grandi scatole di cartone e conservati nel ripostiglio della loro personalità.
Inoltre, nel caso si trattasse di esperienze spaesanti legate ad avvenimenti che hanno provocato un qualche disorientamento psicologico e lasciato per questo un segno negativo nella vita degli individui, emerge come questi “ricordi in cicatrizzazione” potrebbero rendere ancora più delicato il funzionamento della memoria.
Esprimendo il desiderio di “volerli cancellare dalla propria storia” o, come in più occasioni hanno detto, di “voltare definitivamente pagina”, di “mettere un punto per poi andare a capo”, di “ripartire da zero”, i soggetti in formazione invitati alla riflessione cercano di “resettare” la propria memoria riponendo di gran lena gli avvenimenti spiacevoli della loro vita nel simbolico scatolone dei ricordi che in precedenza avevano disegnato.
Dunque, questa “scatola dei ricordi fragili” non è solamente una raffigurazione grafica ma uno specifico modo di rappresentare il passato e tutto il suo carico di esperienze negative da un punto di vista più emotivo-affettivo che cognitivo.
Tuttavia, come sappiamo anche dagli studi psicologici sul meccanismo difensivo freudiano della rimozione, ogni qual volta il soggetto tenti di fare i conti con le esperienze traumatiche del suo passato, può accadere che lo scatolone di cartone con tutto il suo contenuto di ricordi fragili cada dal ripostiglio dov’era stato riposto velocemente, per giunta con il rischio ulteriore di infrangersi a terra.
Tendere al significato
Dagli studi pedagogici sappiamo che l’individuo è culturalmente “abituato” a intendere il processo del ricordare più come uno sforzo retrospettivo riguardante gli eventi del passato che come una tensione prospettica (Romeo, 2014) interessata a scrutare gli scenari, ancora poco visibili, del futuro. Ogni accadimento della nostra vita determina riflessioni, decisioni presenti e progetti futuri e, qualora il passato risultasse caratterizzato da eventi disorientanti il soggetto sul piano psicologico ed esistenziale, occorrerà considerare l’opportunità di significare in modo nuovo, alternativo, ciò che con tanta ostinazione culturale cerchiamo di riporre nel metaforico scatolone di cartone dei ricordi fragili.
Ri-significare le esperienze spaesanti del passato vuol dire in primo luogo credere che la vita, nonostante tutto, abbia senso e che per questa ragione sia ancora possibile generare cambiamento individuale attraverso il progetto di Sé.[6] Ri-significare le esperienze spaesanti del passato vuol dire osservare ciò che è accaduto con uno sguardo differente, cercando di adottare una prospettiva alternativa che permetta un distanziamento emotivo dal trauma e la trasformazione della testimonianza in un’impalcatura, emotiva e cognitiva al contempo, per i soggetti che hanno vissuto, o vivono, esperienze simili e che per questo presentano i sintomi della medesima “malattia del passato” (Romeo, 2010).
Ad esempio, quando una donna che, in passato, è stata vittima di stalking risponde da dietro una cornetta telefonica di un numero verde, trovando la forza di aiutare con la sua testimonianza altre donne presunte vittime di condotte assillanti, compie un’operazione di ri-semantizzazione[7] del suo vissuto poiché, nel tentativo di attribuirne senso, prova a gettare il suo sguardo oltre il muro, prima altissimo e insormontabile, dell’esperienza spaesante.
Quando una donna in passato vittima di stalking trova la forza interiore per condividere con altre vittime di condotte assillanti la sua difficile storia e ciò che ha imparato da questa, ad esempio affacciandosi da uno sportello di un Centro Antiviolenza, ascoltando le loro urgenze narrative e accogliendo i loro bisogni di tutela e cura, rende allo stesso tempo prospettica la sua memoria e progetto la sua vita. Adottare una prospettiva alternativa attaverso la quale imparare a storicizzare e metaforizzare le esperienze spaesanti, ovvero ri-significarle, vuol dire in breve “prestare orecchi” a quanti hanno vissuto i medesimi drammi esistenziali, affinché dai loro racconti si possano trarre consigli utili per facilitare l’annessione di quanto accaduto alla propria storia di vita in maniera più sostenibile.
Quanto noi c’è in me, quanto me c’è nel noi?
Un’altra interessante evidenza emersa dagli studi sulla memoria e sulla narrazione svolti in questi anni riguarda la difficoltà incontrata dagli individui a pensarsi come esseri intersoggettivi. Nel momento in cui si chiede a uno studente di raccontare la sua vita scolastica, o a un formando di descrivere un’esperienza significativa legata alla sua professione, nella maggior parte dei casi si può osservare che il racconto è sempre “egocentricamente” presentato. Chi narra se stesso, la propria biografia, non fa per niente riferimento, o lo fa poco, al gruppo con il quale si identifica e al contesto socio-culturale nel quale è inserito, ovvero alla dimensione sociale che caratterizza e delimita la sua vita.
Dunque, il soggetto interpellato a esplorare la sua storia, mentre cerca di mettere a fuoco la sua esperienza di vita attraverso una sorta di screening mnestico degli eventi memorabili che l’hanno scandita, preferisce collocare in secondo piano l’Altro per concentrarsi unicamente sulla propria persona.
Così accade che nella sceneggiatura descritta dal soggetto narrante sembra non esserci più spazio per tutti quegli attori protagonisti, diventati nel tempo del racconto mere comparse, che hanno segnato in qualche modo la sua vita, delimitandola o ampliandola.[8]
Nella maggior parte delle interviste somministrate in questi anni, interviste che hanno riguardato per lo più emergenze esistenziali, come ad esempio l’esperienza di una deportazione, di un esilio, di un terremoto, di un abuso, la concentrazione porta il soggetto narrante a sforzarsi durante l’esplorazione di Sé messa in atto attraverso il racconto. Non a caso lo sforzo retrospettivo a cui facevo riferimento in precedenza sembrerebbe proprio giustificare la sensazione di spossatezza provata dal soggetto narrante alla fine del lavoro di intervista.[9] Alcune delle osservazioni fatte fino a questo momento, che in parte possono cogliersi anche nei dialoghi di tutti i giorni, durante le chiacchierate con gli amici o a colazione in un bar, diventano evidenze nel momento in cui attribuiamo al racconto una funzione prospettica, cioè lo intendiamo quale strumento pedagogico, individuale e collettivo, utile per investigare nel presente il passato e, a partire da questo, progettare il futuro.
Più che attraverso un’orale pratica del Noi, il racconto di Sé esprimerebbe un impegno psicologico teso a immaginare uno scenario futuro; una capacità di prefigurare una prospettiva, individuare un orientamento, intraprendere un percorso progettuale. Il racconto di Sé si trasformerebbe, dunque, in ricerca di se stessi; nel proprio presente, dal proprio passato, per il proprio futuro.
Il soggetto che racconta se stesso difficilmente àncora la propria narrazione alla dimensione temporale della memoria, quando è accaduto l’evento, alla dimensione spaziale della memoria, dove è accaduto l’evento e, come abbiamo appena osservato, alla dimensione sociale della memoria, con chi eravamo quando è accaduto l’evento. Chi si racconta sembra avere poca percezione dell’ampiezza relazionale della sua memoria, ovvero del numero dei soggetti che, a vario titolo, hanno contribuito a costruire e mantenere la sua personalità e delle esperienze ad “alta intensità affettiva” dalle quali dipendono aspetti importanti del suo attuale essere. Sembra dunque che il soggetto narrante preferisca raccontare le sue esperienze attraverso il proprio ed esclusivo sguardo, volgendolo solo di rado agli altri attori, protagonisti o comparse, della sua vita.
Eppure, la ricerca svolta nei territori che purtroppo si sono misurati negli anni con le catastrofi e le emergenze ci insegna quanto importante sia il dialogo con l’Altro, quanto utile sia la condivisione del dolore e, a partire da questa “spartizione emozionale”,[10] la costruzione di un futuro sostenibile nel quale chi ha avvertito una condizione di spaesamento riesca finalmente a ritrovare una dimora esistenziale, psicologica e sociale[11] (Friedman et al., 2001). Oltre alla ricerca nel campo delle catastrofi e delle emergenze, anche la geometria può aiutarci a spiegare la relazione esistente tra il racconto e la prospettiva. È giusto dire che il racconto ha sempre a che fare con lo spazio entro il quale è restituito e con la direzione, appunto prospettiva, dalla quale origina. Infatti, con il termine prospettiva, dal latino perspicere, intendiamo l’azione del guardare attraverso e del guardare distintamente da un punto. Tuttavia, se lo spazio del racconto, la prospettiva dal quale principia, rimanesse individuale e non si aprisse al fascio delle prospettive attraverso le quali l’Altro volge lo sguardo alla vita, si potrebbe perdere l’importante opportunità di significare in modo collettivo i racconti.
Come a dire che il racconto, per essere prospettico, deve abbandonare una visione puramente egocentrica, la prospettiva individuale, e guadagnare una visuale più ampia e sociale. Della necessità di questo “cambio di visuale” del racconto se ne accorge anche la giornalista Concita De Gregorio quando, invitata al concerto organizzato per festeggiare il secondo compleanno di Lulubella, la figlia del cantante Niccolò Fabi portata via da una meningite fulminante nell’estate 2010 dopo avere appena imparato a cantare la canzone Parole parole di Mina, si stupisce tra la folla di come anche un’esperienza spaesante possa generare ricordi prospettici e progettualità.
[...] Ho sentito il nastro che Mina ha inciso con Niccolò, per questa festa: Parole parole. “Perché era la canzone preferita di Lulú, ma anche perché in questo periodo la frase più frequente che sentivo da quelli che ci avvicinavano era: non ci sono parole. E invece ci sono eccome, hanno un’importanza enorme; ogni singola parola che ci è stata detta, anche quella smozzicata o solo intuita, ci ha aiutato tantissimo. Il dolore se non è condiviso diventa rabbia e disperazione. Noi siamo musicisti: un concerto per noi è il modo più diretto per parlare e stare insieme. Magari non riusciranno neppure a cantare tutti, gli amici che sono venuti, ma sono tutti qui”. Quello che è accaduto è stato talmente forte che doveva scatenare qualcosa di altrettanto straordinario: il dolore condiviso si trasforma, genera forza. Eccola. Poi Niccolò sale sul palco e comincia a suonare, le lacrime le assorbe la terra i sorrisi se li prende la luna. (De Gregorio, 2011, p. 40).
Per concludere, se volessimo provare a rispondere alla domanda che dà il titolo a questo paragrafo, cioè quanto noi c’è in me e quanto me c’è nel noi?, potremmo dire che, essendo il racconto registrato e riprodotto egocentricamente, ognuno di noi è poco consapevole della presenza di altri individui nella propria vita poiché, impregnati di senso sociale[12] (Piasere, 2002), intendiamo la presenza dell’Altro come un’informazione culturalmente acquisita. Tuttavia, come anche Niccolò ha spiegato dal palco sul quale ha cantato in memoria della figlia Lulubella, se il racconto non diventa collettivo, se non è condiviso all’interno di una più ampia “comunità narrativa”, sarà più difficile l’elaborazione e il superamento delle esperienze spaesanti.
La narrazione come “navigatore dell’esperienza”
Dopo avere osservato quanto sia difficile per gli individui intendere la memoria come una funzione cognitiva dinamica e intersoggettiva, proviamo a comprendere meglio i meccanismi attraverso i quali il racconto del nostro passato può rappresentare, capacitando in modo adeguato i ricordi, un primo passo verso l’individuazione di possibili percorsi di sviluppo. Barths amava ripetere, a proposito del racconto inteso come necessaria fonte di verità, che “il senso non è alla fine del racconto, non sta nella sua soluzione ma lo attraversa in tutto il corso della sua struttura” (Marrone, 1987).
Oltre agli studi barthesiani sulla linguistica e sulla semiologia, le ricerche pedagogiche sulla narrazione del passato suggeriscono come pure impossibile sia individuare il senso all’inizio del racconto. Tuttavia, con modalità e tempi differenti, l’individuo avverte una sorta di impulso a raccontare le sue esperienze di vita, tanto che anche il più introverso fra gli umani spesso avverte l’impellente necessità di raccontarle agli altri, come pure a se stesso.
Dunque, il racconto sembra essere legato a una sorta di istinto primordiale, un bisogno di significazione del presente e di ri-significazione dei ricordi che riguardano il passato. L’urgenza narrativa che caratterizza la specie umana, manifestata nel racconto orale o scritto, ma anche nella pittura, nella scultura e ancora nella musica, nella danza, ecc., risponderebbe quindi all’esistenziale necessità di ogni soggetto di ricercare il senso, guadagnare significati nuovi, adattarsi al mondo che è fuori di noi (Bruner, 1991).
Più volte, infatti, in questo articolo abbiamo sottolineato quanto l’esercizio della memoria fosse più prospettico che retrospettivo e per questo riguardasse più il futuro che il passato. Il senso, dunque, attraversa il racconto di ognuno di noi e, probabilmente, questa ricerca interiore di significato è tanto più difficoltosa quanto più spaesanti sono state le esperienze che proviamo a raccontare a noi stessi e agli altri.
Il senso attraversa le nostre storia di vita, e le metafore e le immagini mentali sono le spie e gli indicatori di una così importante conquista sul piano emotivo, affettivo, percettivo, cognitivo, linguistico e motorio[13] (Gelo, 2007, pp. 329-353).
Probabilmente il bisogno di memoria e la capacità di narrare dell’uomo suggeriscono che la vita stessa debba essere intesa quale costante ricerca di senso che, specie nel fronteggiamento del trauma, richiede puntelli e sostegni sociali in grado di favorire questo delicato attraversamento emotivo e cognitivo.
Le narrazioni, quando sono condivise e adeguatamente metaforizzate, rendono possibile sia l’individuazione e l’elaborazione di questi difficili e importanti snodi educativi della nostra esperienza, i traumi per l’appunto, sia il ri-posizionamento psichico nella rete culturale in cui siamo inseriti.
Possiamo pertanto immaginare la narrazione come una sorta di GPS, come un navigatore dell’esperienza, ovvero un sistema di posizionamento della nostra identità nel mondo (Romeo, 2012). Alla stregua delle operazioni di ricerca della destinazione effettuate in auto con l’ausilio del sistema di navigazione satellitare, possiamo raggiungere la meta designata, cioè il plausibile scenario progettuale, percorrendo un tracciato che comincia da un punto di partenza stabilito, la nostra esperienza in un tempo specifico della nostra vita, e segnala progressivamente il percorso compiuto e quello ancora da compiere. Per questo motivo, quando scaviamo nel nostro passato, e la metafora dello scavo psicologico rende appieno l’idea della fatica dell’operazione mentale compiuta, le domande alle quali tentiamo di rispondere trovano risposta poiché, attraverso la memoria autobiografica, stabiliamo un nesso tra quello che eravamo in passato, quello che siamo nel presente mentre ricordiamo e proviamo a raccontarci e quello che, idealmente, saremo nel futuro.
In questo modo il soggetto che si rende protagonista consapevole di una nuova storia, mentalmente lontana dall’evento traumatico, costruita all’interno di setting narrativi che promuovono adeguati percorsi pedagogici di metaforizzazione, inclusiva dell’Altro e ricca di disponibilità, impegno e responsabilità personale, che per questi motivi viene chiamata narrazione trampolino, rende fattibile il suo riposizionamento e rinnovamento psicologico, sostenendo altresì “il desiderio, la proiezione di Sé e incidendo sul futuro attraverso una diretta ed efficace influenza sullo stato attuale delle cose” (Greimas, 2001).
L’intelligenza retrospettiva, narrativa e prospettica come competenze chiave per l’apprendimento permanente
L’utilizzo della narrazione e la trasmissione di conoscenza all’interno delle nostre società ricorrendo ad essa, oltre a evocare scenari fantastici e dipingere amori difficili a causa delle malefatte di streghe brutte e cattive, rispondono a una rivalutata prospettiva epistemologica.
A causa della complessità e dinamicità dei contesti attuali, all’interno dei quali è possibile assistere al liquefarsi dei modelli simbolici e, dunque, all’indebolimento delle possibilità di dare senso al mondo (Guidi e Salvatore, 2006, pp. 185-211), è andato sempre più rivalutandosi l’approccio narrativo basato sullo storytelling (storie collettive) o sulle autobiografie (storie individuali), favorendo così, in opposizione alla “dimensione logico-scientifica”, l’ascesa della “dimensione narrativa”.
È in particolare Jerome Bruner a sviluppare la distinzione esistente tra dimensione scientifica e dimensione narrativa.
Per lo psicologo cognitivista esisterebbero due tipi di pensiero: da un lato il “pensiero paradigmatico” orientato alla categorizzazione e alla generalizzazione, dall’altro il “pensiero narrativo” mirato alla comprensione e all’interpretazione dei significati e dei modi in cui gli individui organizzano la propria esperienza (Bruner, 1986).
Il pensiero paradigmatico sembra essere tipico del ragionamento scientifico nel suo orientamento verticale e gerarchico che connette oggetti e/o eventi al di fuori del contesto, procedendo per falsificazioni e generalizzazioni verso la definizione di leggi universalmente valide. Ancora, risulta essere efficace nella soluzione di problemi scientifici, poiché impiega strategie di ragionamento della logica formale, ma può rivelarsi del tutto inadeguato nei confronti di problematiche che riguardano il sociale e la soluzione di questioni che l’individuo affronta giornalmente.
Il pensiero narrativo, al contrario, è tipico dei ragionamenti quotidiani influenzati dai contesti di azione: dunque organizza oggetti e/o eventi adottando un criterio di coerenza orizzontale. Questa modalità di pensiero persegue l’obiettivo non di verificare o definire delle leggi universali, bensì di narrare storie specifiche, singoli casi e accadimenti del contesto.
Il pensiero narrativo è dotato di una propria “intelligenza narrativa”; nel senso di un’intelligenza tesa a costruire significati e configurazioni interpretative e organizzazioni semantiche. Il pensiero narrativo consiste quindi in una sequenza organizzata di eventi esperiti nello spazio e nel tempo, in un insieme di contenuti narrati che sono le azioni realizzate dagli attori assieme ai bisogni che le hanno prodotte, in seguito a situazioni ed eventi vissuti come incongruenti e nei confronti dei quali non potevano essere utilizzati i consueti schemi interpretativi di risoluzione. È interessante notare come l’individuo nella vita di tutti i giorni debba prendere decisioni e risolvere problemi sempre in condizioni di incertezza. Questa incertezza favorirebbe il ricorso di procedure di analisi di tipo euristico e pratico, che funzionano come “scorciatoie logiche” in grado di evitare i lunghi e complessi calcoli tipici del ragionamento logico-scientifico.
Perciò egli non può non tenere conto del contesto, delle proprie credenze e dei ricordi che affiorano alla mente. Ha bisogno di cercare conferme alle proprie ipotesi e non può rimettere in discussione ogni volta i presupposti della sua conoscenza. Nell’osservazione degli eventi è costretto a lavorare sui piccoli numeri e ad attribuire ad essi una portata assai più generale. (Smorti, 1994, p. 112)
Nella quotidianità l’individuo sente la necessità di astrarre un numero sempre maggiore di indicazioni comportamentali dal minor numero possibile di indizi, cioè deve abbandonare i canoni classici del ragionamento logico. Quando procede in modo logico-paradigmatico l’individuo fa uso di categorie gerarchiche, di proposizioni formali avulse dal contesto, mette in relazione, subordinandolo o sopraordinandolo verticalmente, un caso individuale con categorie generali, ricorre a leggi generali di tipo causale, ricerca somiglianze a scopo classificatorio. Quando invece procede in modo narrativo, l’individuo articola sequenze temporali sensibili e dipendenti dal contesto, muovendosi in modo orizzontale e collegando, dunque, gli elementi in rapporto a un’azione.
A proposito del pensiero autobiografico-narrativo Duccio Demetrio ha scritto che:
[…] la mente non si limita a rievocare immagini in sé isolate, fra loro distinte e vaganti; l’intelligenza retrospettiva costruisce, collega, e quindi colloca nello spazio e nel tempo, riesce a dar senso a quell’evento soltanto se lo “socializza”: trapassando così dal momento evocativo al momento interpretativo. L’istante cognitivo cerca nessi, cause, collegamenti per spiegare quell’evento apparentemente singolare. (Demetrio, 1996, p. 60)
Con l’intento di orientare le politiche scolastiche ed extrascolastiche di ogni Stato membro, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la Raccomandazione 2006/962/CE, del 18 dicembre 2006 (Gazzetta ufficiale L. 394 del 30/12/2006, p. 10), relativa alle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente, definendo un quadro di riferimento di conoscenze, abilità e attitudini essenziali da applicarsi specialmente a soggetti o gruppi svantaggiati che, per realizzare le loro potenzialità educative, necessitano di un particolare e strutturale sostegno. Oltre alla comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere, la competenza matematica e di base in campo scientifico/tecnologico e quelle digitali, sociali e civiche, il “saper ricordare e raccontare” dei quali abbiamo finora parlato come base per la costruzione di un sostenibile progetto personale, bene si integrano con le restanti competenze chiave della Raccomandazione, individuate nel senso di iniziativa e di imprenditorialità, nella consapevolezza ed espressione culturale e nell’imparare a imparare.
“Intelligenza retrospettiva” e “intelligenza narrativa”, dunque, rappresentano i lati di una medesima medaglia pedagogica; di una competenza chiave per l’orientamento di Sé alternativa e imprescindibile a che i soggetti, specie i minori anagraficamente inseriti nel ciclo obbligatorio di istruzione e formazione, diventino consapevoli “narr-attori” della loro esistenza, cioè attori con un ruolo da protagonista nella propria narrazione e nei processi decisionali di ogni giorno.
Saper ricordare e raccontare come Bisogni Educativi Speciali per l’orientamento di Sé
Le linee guida sull’apprendimento permanente, definite nella Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio nel dicembre del 2006, in seguito hanno fatto da sfondo nel nostro Paese alla stesura delle “Indicazioni per il curricolo 2012”, che di fatto delineano il profilo ideale dello studente al termine del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado).
Le 8 competenze chiave definite in sede europea tendono a rendere centrale il concetto di competenza, sia circoscrivendolo a una disciplina o a un ambito di discipline (competenze disciplinari), sia attribuendogli una valenza trasversale per tutte le discipline, attraverso scelte precise che coinvolgono la didattica, l’organizzazione della classe e il clima d’aula (Vanini, 2013, p. 33).
Questo ha reso possibile nelle scuole italiane una specifica calibrazione didattico-pedagogica, grazie alla quale prevedere dei “traguardi di sviluppo delle competenze” da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico, indicando altresì, accanto ad essi, una serie di “obiettivi di apprendimento”.
Tra questi traguardi di sviluppo delle competenze ricordiamo: la “valorizzazione dell’oralità” (parlato, ascolto e interazione), la “capacità di argomentare”, l’“apprendimento per problemi” e l’interessante focus su “identità, memoria e cultura storica” specie nel ciclo della primaria, anni nei quali matura nei bambini la progressiva consapevolezza dell’identità, costruita sia attraverso la loro storia, sia attraverso quella della famiglia d’origine riferita alle quattro generazioni vissute in un arco temporale di circa cento anni.
Anche il sistema scolastico italiano, dunque, assunto come orizzonte di riferimento normativo il quadro europeo, reputa essenziali, per chi scrive, le meta-competenze del “saper ricordare” e del “saper raccontare” per la formazione del futuro cittadino, la trasmissione dello spirito comunitario e l’orientamento collettivo delle comunità scolastiche, professionali e sociali che progressivamente il bambino abiterà.
Le “Indicazioni per il curricolo 2012” dedicano inoltre un capitolo importante alla “prospettiva inclusiva”, attraverso la quale si auspica che le scuole diventino luoghi di apprendimento e crescita in cui ogni bambino possa esperire la diversità come normalità e, in un’ottica di valorizzazione, come ulteriore fattore di arricchimento personale. Sicuramente una scuola inclusiva, come pure una classe inclusiva, dei docenti inclusivi e una didattica inclusiva, può anche cambiare arredi o utilizzare materiali didattici differenti, esponendosi così a qualche imprevisto, ma è proprio dal confronto con tali imprevisti che lo studente misurerà le capacità di sviluppare il suo progetto di vita, senza lasciare che l’imprevisto stesso la faccia da padrone (Vasquez e Oury, 2011).
La prospettiva inclusiva in Italia, come anche negli altri Stati membri dell’Europa, assume importanza rilevante specie alla luce della comparsa dell’area dei cosiddetti Bisogni Educativi Speciali (BES).
La Direttiva ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la successiva Circolare n. 8 del 06/03/2013 recante le indicazioni operative per la sua attuazione delineano e precisano meglio la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
La Direttiva ministeriale ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica italiano, basato tradizionalmente sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei BES, comprendente lo “svantaggio sociale e culturale”, i “disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi specifici evolutivi” e le “difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e lingua italiana” derivanti dall’appartenenza a culture diverse.
Le parole “calde” per sviluppare e consolidare una scuola veramente inclusiva diventano dunque “estensione”, “presa in carico globale e inclusiva”, “uguale accesso agli apprendimenti”, “personalizzazione” e “capability”, pena la mancata realizzazione di adeguate “aule e didattiche di sostegno” per tutti gli studenti in difficoltà.
Pertanto, il bisogno educativo, che teoricamente e nella prassi didattica da “normale” diventa ora “speciale”, dovrà essere mappato in una fase di analisi dei bisogni anch’essa “speciale”, che per individuarlo e soddisfarlo deve avvalersi di strumenti “speciali” (vedi il PDP o Piano Didattico Personalizzato e il PAI o Piano Annuale per l’Inclusività), entro un paradigma bio-psico-sociale e pedagogico-didattico e non, come accadeva in precedenza, esclusivamente biomedico.
Infatti, andando oltre la certificazione di disabilità, quindi scostando lo sguardo pedagogico dal concetto di “patologia”, come giustamente afferma Vehmas, i BES riguardano «tutti quei bisogni che sono unici in ogni individuo, dato che tutti siamo speciali, con pari valore, nel senso di diversi» (Vehmas, 2010, p. 92).
I BES rappresentano dunque una macro-categoria entro la quale far confluire tutte le possibili difficoltà educative/apprenditive degli alunni; sia le situazioni tradizionalmente considerate come disabilità cognitiva, fisica e sensoriale, sia quelle caratterizzate da deficit in specifici apprendimenti clinicamente significativi, quali ad esempio la dislessia, il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), il disturbo dello spettro autistico e altre situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva e di contesto socio-culturale.[14] Scrivono Ianes, Macchia e Cramerotti:
Nell’idea di bisogno educativo speciale è centrale il concetto di funzionamento educativo-apprenditivo. In questa dimensione, peraltro totalizzante l’esperienza evolutiva del bambino, si attribuisce un’enfasi prevalente al concetto di apprendimento (nei più disparati ambiti), frutto dell’intreccio tra le varie spinte endogene, per maturazione biologica programmata geneticamente, e le mediazioni educative degli ambienti. Nei contesti delle varie forme di educazione, formale e informale, il bambino cresce apprendendo, sviluppando competenze negli ambiti più diversi: cognitivo, linguistico, interpersonale, motorio, valoriale, autoriflessivo, ecc. Questi funziona bene dal punto di vista evolutivo se riesce a intrecciare positivamente le spinte biologiche alla crescita con le varie forme di apprendimento date dall’esperienza e dal contatto con le relazioni umane e gli ambienti fisici. (Ianes, Macchia e Cramerotti, 2013, p. 37).
Il funzionamento educativo-apprenditivo, in quest’ottica, è il risultato di un mescolamento tra biologia, esperienze, ambienti, relazioni e iniziative poste in essere dal soggetto e, in questa sorta di “shakeraggio culturale”, il progetto educativo individuale si pone proprio quale strumento di soddisfazione del bisogno speciale nelle sue azioni quotidiane.
Chiaramente, durante l’età evolutiva le varie dimensioni emotivo-affettive e comportamentali del bambino, vedi ad esempio l’autostima, l’autoefficacia, l’emotività, l’autocontrollo, la motivazione, gli stili di attribuzione, i comportamenti problema, interagendo sfavorevolmente con altri elementi contestuali e ambientali, possono essere concausa di bisogno educativo speciale.
Ma è pur vero che queste dimensioni sono “prodotto sociale”, ovvero il frutto dell’educazione e della cura degli adulti di riferimento che, sin dai primissimi anni di vita, insegnano ai figli a essere più autonomi, a esplorare in sicurezza il mondo avendo sempre alle spalle figure di riferimento rassicuranti, a motivarsi maggiormente quando davanti a un compito la cui gestione è spesso risultata fallita ci si sente de-motivati, a generare rappresentazioni della vita includenti nella propria vision i punti di vista degli altri, imparando così a modellarle nel caso ce ne fosse bisogno o se ne avvertisse l’esigenza, a gestire l’ansia e, ancora, a essere adattivi, resilienti e/o a saper galleggiare, senza affondare, nel mare di quelle avversità non programmate che la vita ci pone spesso di fronte.[15]
Queste sono anche le ragioni che spingono la pedagogia a ritenere importantissimi il coinvolgimento e la valorizzazione della risorsa “compagni di classe”, attraverso l’utilizzo del metodo di insegnamento-apprendimento cooperativo, nell’aiuto di quelli più fragili da un punto di vista fisico, biologico, psicologico, relazionale, sociale e culturale.
Le riflessioni poste in essere fino a questo momento spingono a sostenere la tesi che, alla stregua di una malattia acuta o cronica, di una disabilità cognitiva, di un disturbo specifico di apprendimento o di una lesione o menomazione fisica, l’“incapacità di ricordare” e l’“incapacità di raccontare”, in altre parole l’assenza nel bambino in età evolutiva di quelle particolari competenze di “pensarsi retrospettivamente per immaginarsi nel futuro attraverso il suo racconto personale”, possano essere considerate a tutti gli effetti bisogni educativi speciali da soddisfare in vista dello sviluppo di un’identità sociale e professionale specifica della vita adulta.
La tesi qui esposta è sostenuta da importanti “puntelli scientifici” provenienti da studi di matrice sociologica, pedagogica e psicologica.
Jedlowski (2000), studioso dei processi culturali che molto si è interessato dei nessi esistenti tra la narrazione e la vita quotidiana, riflettendo sulle macerie esistenziali che la Germania Nazista aveva rovesciato sui popoli sottomessi al termine della guerra, ribadisce che l’“incapacità di ricordare” e l’“incapacità di raccontare” possono anche dipendere dall’“impossibilità di ricordare” e dall’“impossibilità di raccontare” (Jedlowski, 2009), e questo non solo per l’inenarrabilità del trauma vissuto, ma anche per la presenza di un contesto “sordo” alle richieste di individui bisognosi di sostegno.
Il ragionamento del sociologo, maturato soprattutto in seguito allo studio delle paradossali testimonianze dei sopravvissuti alla seconda guerra mondiale che, di ritorno nelle loro comunità, si sentivano incompresi finanche dai loro stessi familiari,[16] risuona come un monito per gli operatori della relazione di cura, specie quelli educativi, che devono meglio imparare a “prestare orecchi”, per usare in questo scritto una più calzante metafora dell’ascolto, a tutti quei segnali/bisogni, trascritti all’interno di un tema, bisbigliati in una conversazione tra compagni o soltanto colti su una fronte corrugata, che i nostri studenti, come fari nelle piccole e grandi tormente quotidiane, lanciano dai banchi di scuola a noi adulti.
Tuttavia, questa particolare categoria di segnali/bisogni educativi, il bisogno di memoria, lo definisce il pedagogista Tramma (2003), e il bisogno narrativo, non possono essere assolutamente soddisfatti con lo stesso metro utilizzato per “misurare” quelli formativi, perché, per l’appunto, dotati di uno “statuto speciale”.
A questo riguardo Bochicchio (2012), nel campo dell’Educazione degli Adulti, ha osservato con lungimiranza che il bisogno formativo, inteso come una particolare categoria di bisogno umano, non è esprimibile soltanto nei termini di una “carenza”, di un “vuoto da colmare”, di un “gap da riempire”, da un punto di vista dell’apprendimento, poiché esso si sostanzia soprattutto di un futuro “desiderato”.
E questo vale ancora di più oggi, data la lontananza culturale da quelle logiche della “catena di montaggio” e dell’addestramento scientifico della manodopera che, a cavallo tra il XIV e il XX secolo, caratterizzarono le organizzazioni durante la fase dell’espansionismo industriale (Bochicchio e Di Sabato, 2007).
Infatti, già a partire dagli esperimenti sull’influenza del “fattore umano” sul risultato delle prestazioni di Elton Mayo, il caposcuola del cosiddetto “movimento delle relazioni umane” sviluppatosi negli anni Trenta del secolo scorso, possiamo considerare l’individuo in formazione permanente, “dalla culla alla tomba” (from the cradle to the grave), una fonte di risorse “potenziali” esprimibili nei termini di intelligenza, creatività, conoscenze, capacità decisionali, intraprendenza, impegno e dedizione al lavoro che, nella realtà di tutti i giorni, sono in gran parte latenti e che occorre per questo “risvegliare” migliorando la convivenza organizzativa (Bochicchio, 2011).
Il bisogno educativo speciale, allora, la cui radice etimologica discende dal gotico bi-sunja, dove sunnia indica la “cura” o la “preoccupazione”, mentre il prefisso bi una duplice direzione di significato (Bochicchio, 2012, p. 36), non può che essere inteso nell’ottica di un “sogno duplice”, cioè di un’“attesa dotata di senso” capace di sostenere, entro una dimensione della relazione e della cura, la persona nella realizzazione del suo più completo progetto di vita.
Un altro “puntello scientifico“ a sostegno di questa tesi deriva dagli studi psicologici, specie quelli che, interessandosi oggi della “prefigurazione del futuro”, recuperano il concetto di Prospettiva Temporale Futura (PTF) di lewiniana memoria (Petitta, Vecchione e Avallone, 2009, pp. 369-397).
Sulla scorta delle riflessioni di Lewin, che definiva la PTF come «lo spazio a venire che influenza il comportamento presente» (Lewin, 1939), i ricercatori, nell’ambito degli studi sulle rappresentazioni del futuro, forniscono un’interessante distinzione nel modo di pensare il domani che incide sulla motivazione e sui comportamenti delle persone.
Tra questi, James distingue le credenze sul futuro dalle immagini fantasiose (James, 1950), contrapponendo così ad “ancoraggi forti” alla realtà, poiché il futuro è ipotizzato in base a delle letture consapevoli del passato, “ancoraggi deboli” al desiderio che un dato evento si verifichi, assimilabili ai sogni diurni, centrati più sui limiti e sulle fantasie che sulla padronanza dei problemi, sulla vigilanza mentale, sull’acquisizione di informazioni e sull’impegno nell’azione.
Più in generale, se si osserva che qualunque forma di pensiero positivo circa il domani basato sull’esperienza passata predice il benessere e lo sforzo che un individuo metterà nella prestazione futura (Holahan e Moos, 1986), le fantasie e gli stili di evitamento delle difficoltà, viceversa, comportano uno scarso confronto con la realtà e, dunque, una disfunzionale pianificazione rispetto al loro fronteggiamento e superamento (Epping-Jordan, Compas e Howell, 1994, pp. 539-547).
Per queste ragioni, per chi scrive, l’“incapacità di ricordare” e l’“incapacità di raccontare”, oltre a rappresentare importanti “spie diagnostico/cliniche” da monitorare a scuola nel caso in cui si volesse, per legge solo dopo il passaggio alla seconda classe della scuola primaria, intraprendere un percorso medico-specialistico al fine di valutare l’esistenza di specifici disturbi evolutivi, possono, quali deficit dell’area dello svantaggio scolastico per i quali si adotta in Italia il principio della “personalizzazione dell’insegnamento” sancito nella Legge n. 53 del 28 marzo 2003 (in GU Legge n. 77 del 2 aprile 2003), trovare riparo sotto il costrutto-ombrello di BES.
Di certo, la mancata o ritardata rilevazione e soddisfazione di questi bisogni a “statuto speciale” renderà il bambino in età evolutiva inabile a conoscersi a fondo, emotivamente e cognitivamente, pensarsi e decidere entro un plausibile scenario di sviluppo personale e professionale, la prospettiva temporale futura a cui faceva riferimento Lewin, poiché nessuno gli avrà insegnato a utilizzare la narrazione di Sé come un più sicuro e attendibile navigatore della sua esperienza.
Le narrazioni trampolino: perché i minori devono raccontare e raccontarsi
Al termine di questo studio, nato con l’intento di chiarire i nessi esistenti fra la memoria, la narrazione e i bisogni educativi speciali, matura l’esigenza di rispondere ad alcune e importanti domande. Fra tutte: perché i minori, specialmente quelli in età scolare e/o a rischio devianza, che vivono dunque all’interno di contesti sociali marginali, dovrebbero imparare a meglio raccontare e raccontarsi?
Per rispondere a questa domanda prendo spunto da una richiesta emblematica di ascolto pervenuta al Tribunale per Minorenni presso cui lavoro, che aveva come oggetto “l’incapacità dei genitori di comprendere i comportamenti aggressivi messi in atto a scuola dal figlio adottivo”. Dopo avere ascoltato prima le richieste dei genitori adottivi in sede di audizione e, successivamente, i bisogni del figlio minorenne, emersero alcuni aspetti che in questa sede vale la pena mettere in evidenza.
Prima di tutto il minore, invitato a riferire a proposito dei suoi comportamenti aggressivi, sembrava non comprendere la gravità di quanto accaduto. Non gli importava, infatti, che gli altri studenti da lui presi a pugni nel cortile della scuola potessero subire importanti traumi e lesioni al capo e agli occhi. In quella aggressività, diceva, “scaricava tutto se stesso”, anche senza motivi che potessero giustificarla. Il minorenne non si difendeva, ma cercava con grande facilità la rissa e ogni occasione diventava per lui terreno di scontro fisico e verbale.
Dopo alcune ora passate a esplorare il suo vissuto di figlio adottivo, il minorenne inizia ad attribuire quella violenza agli anni della sua infanzia difficile.
Parla a proposito di “piccoli dolori” che riemergono quando chiude gli occhi e picchia gli altri ragazzi senza mai fermarsi. Senza entrare nello specifico della sua storia di vita, il minorenne straniero era stato adottato da una famiglia italiana quando aveva superato da poco i quattro anni di vita, pochi ma sufficienti a ritenere nella memoria alcune esperienze significative vissute nella terra d’origine.
Gli psicologi dell’età evolutiva e gli esperti dell’apprendimento infantile ci dicono, infatti, che è proprio intorno ai quattro anni di vita che la memoria autobiografica del bambino inizia a strutturarsi come funzione cognitiva e a realizzare, anche se in modo ancora acerbo, un’operazione di inanellamento fra passato, presente e futuro.
Salvo casi eccezionali, mentre ricordiamo con fatica o per niente le primissime esperienze infantili, la maggior parte di noi ricorda “fotograficamente” alcune scene avvenute in famiglia proprio a partire dai quattro anni di vita.
Questo perché, in virtù di quello che Luisa Passerini definisce primato dell’intersoggettività (Passerini, 2003), intorno ai quattro/cinque anni di vita i soggetti iniziano a percepirsi come esseri sociali e, strutturando la memoria assieme al linguaggio e al pensiero, riescono a lasciare un’impronta, via via sempre più profonda, nella vita di tutti i giorni.
Il minorenne durante l’audizione inizia a fare riemergere alcuni ricordi del suo passato perduti nell’oblio; riposti nella sua “scatola dei ricordi fragili” diremmo noi.
Ricorda alcuni volti di bambino, forse si tratta di alcuni suoi fratelli, con i capelli biondi, sottili e chiarissimi. Non ricorda i volti dei genitori, ma è sicuro di essere stato in una culla assieme ad altri bambini, in un luogo molto freddo e dalle cui finestre si vedeva scendere la neve. Raccontandosi, il minore crede sia possibile attribuire parte dei suoi comportamenti aggressivi di oggi a quel passato sconosciuto e, incuriosito dall’emersione improvvisa di questi flashback soggettivi che lo inondano di emozioni, si rende disponibile a un approfondimento, da me approvato e sollecitato, di tipo psicologico.
I “ricordi fragili” del nostro minorenne sono molto simili a quelli di altri soggetti adottati che, una volta diventati adolescenti o adulti, provano con grande difficoltà a inanellare passato, presente e futuro.
Come scrive Bonato (2013), “la ricerca dell’identità è un percorso all’indietro nel passato complesso che inizia quando le persone adottate sono in grado di ascoltare verità, anche dolorose, della loro vita che ancora non conoscono consapevolmente, ma dalle quali si sentono intrigate, nella speranza che queste possano dare significato nuovo al tempo, curare le ferite e rendere possibili incontri e pacificazioni”. Molte persone tenute all’oscuro della propria vicenda adottiva comunicano pensieri che, raccolti e condensati, suonano pressappoco così:
Io però mi sono sempre sentito “diverso” dagli altri e provavo un certo disagio. Non ne capivo la ragione, ma era così. Era come se intorno alla mia nascita ci fosse qualcosa di oscuro, di non detto e i miei svicolassero quando capitava che io ponessi loro delle domande; ad esempio chiedevo perché non ci fosse neanche una foto di me piccolino prima dei due anni in braccio alla mamma o al papà, o perché fossi nato in una città diversa e lontana da dove vivevamo. Inventavano delle bugie che non tenevano a lungo e mi sentivo imbrogliato. (Bonato, 2013, p. 5)
Nel caso in cui le persone, ritenendo di essere stati adottati attraverso l’adozione nazionale, chiedano di “accedere a informazioni che riguardano la loro origine e l’identità dei genitori biologici” come previsto dalla legge,[17] vengono a conoscenza che nel loro certificato di nascita integrale compare la dizione “figli di donna che non consente di essere nominata”, i pensieri da loro comunicati sono colmi di delusione, rabbia e sdegno.
È mai possibile che io debba morire senza aver conosciuto chi mi ha fatto nascere? Io avrei desiderato conoscere la sua storia e capire che cosa le abbia fatto decidere di non riconoscermi dopo avermi partorito. Quando mi è stato adagiato al seno il mio bambino appena nato e ho potuto stringerlo e baciarlo, ho sentito che io non avrei mai potuto abbandonarlo. (Ibidem, p. 8)
E, ancora:
Avrei voluto fare pace con lei e stare in pace con me stessa; speravo, incontrandola, che il male che mi porto dentro potesse essere accantonato per sempre e trovare nel passato, finalmente accettato, il suo giusto posto. (Ibidem)
La condizione di figlio adottato e le narrazioni che negli anni ne derivano ci fanno comprendere meglio quanto sia importante l’operazione psicologica di riposizionamento del Sé, senza la quale nessun progetto di rinnovamento personale potrà essere messo in pratica.
È come se nelle impostazioni del nostro metaforico navigatore dell’esperienza mancasse quella fondamentale tappa di partenza, il passato, sulla quale poi impostare il resto del cammino. Come a voler porre l’accento sul fatto che, se non sappiamo da dove proveniamo, non sappiamo nemmeno dove siamo né, tantomeno, dove siamo diretti.
Le storie segrete, dimenticate, nascoste, cattive (Contini e Manini, 2007), i “piccoli dolori” di cui parla il minorenne durante l’audizione, hanno quindi bisogno di un giudice severo, non di certo il giudice che le ascolta, vale a dire di un soggetto responsabile e maturo che rincorso da un tempo passato tiranno si impegna a ritrovarle e a significarle.
Occorre riaprire i “cassetti segreti” affinché si possa tessere una trama che metta nuovamente in gioco l’area personale del sentire, del conoscere, del comunicare e del progettare porzioni importanti della personalità di ognuno che altrimenti sfocerebbero in tensione, aggressività, disagio o, nel caso migliore, resterebbero esiliate in fantasmatici silenzi.
In conclusione di questo studio, ritorniamo alla nostra domanda di partenza e proviamo a rispondere anche alla luce di queste complesse esperienze di ricostruzione dell’identità di figli adottati svolte in diversi Tribunali per i Minorenni italiani.
Perché dovremmo tutti imparare a raccontare e i minorenni, specie quelli in evidente stato di disagio esistenziale e a rischio devianza, dovrebbero imparare a meglio raccontarsi?
Chi scrive è convinto che l’esercizio della memoria, quello individuale e collettivo, e la narrazione assurgano a importanti compiti evolutivi per la specie umana, al di là degli aspetti linguistici e stilistici presenti nel racconto.
Per prima cosa possiamo dire che i soggetti, raccontando e raccontandosi, nel corso dello sviluppo evolutivo maturano funzioni cognitive sempre più introspettive e capacitano[18] (Nussbaum, 2002) risorse psichiche attraverso le quali meglio comprendere e modellare la propria e la mente degli altri rendendosi conto di essere attori protagonisti e non mere comparse sul palcoscenico del mondo.
Strutturare racconti, comprenderne l’importanza e approfondire le immagini e le metafore mentali al loro interno implicano l’acquisizione di una specifica abilità a rappresentare le cose nei termini di altre cose che apportano significati e visuali nuovi, soprattutto ispirandosi e attingendo a fonti esterne (libri, giornali, radio, televisione, ecc.) o ricorrendo a eventi capitati a conoscenti, amici e familiari.
Troppo spesso, infatti, i minorenni invitati a raccontarsi in audizione o a scuola non sono in grado di esprimersi adeguatamente, di costruire un ragionamento che abbia un senso compiuto, e questa incapacità di raccontarsi, questa impossibilità di percepirsi nel sociale e modellare i propri sguardi sul mondo, può allontanarli dalla realtà e avvicinarli all’ignoranza, allo stereotipo, al pregiudizio, al disagio, al crimine.
Non è un caso che molti minorenni al limite del territorio dell’illecito tendano a giustificare i loro “falsi pensieri” e i comportamenti criminali che ne derivano, poiché, in assenza di un confronto adeguato, li reputano giusti aprioristicamente e in senso assoluto.
Inoltre, la narrazione assume una funzione che potremmo definire “sedativa”, poiché in un primo momento di esondazione emotiva del trauma, qualunque esso sia, offre al soggetto la possibilità di riflettere sulle sensazioni di colpa e vergogna provate, sull’angoscia, sulle paure e sull’abbandono.
Poi, in un secondo momento, la narrazione assume una funzione che potremmo definire “trampolino”, poiché le storie, anche quelle più dolorose, possono trasformarsi in potenti strumenti pedagogici per riconoscersi, ri-posizionarsi all’interno di un “recinto sociale”, orientare le scelte e individuare, con buoni margine di errore, i percorsi da intraprendere nel futuro.
In questo modo anche i “ricordi fragili”, che abbiamo inteso quali particolarissimi bisogni educativi speciali da soddisfare, possono costruire il futuro, diventando progetto e prospettiva, a patto però che il soggetto si accorga dell’Altro, della dimensione sociale che lo avvolge proteggendolo, e sappia integrarli come risorse in questa complessa operazione di ri-significazione del proprio passato.
Ritorno per un momento agli Aymara e al loro bizzarro modo di intendere il tempo.
E se avessero ragione loro? Se fosse più utile puntare lo sguardo sul passato piuttosto che sul futuro? Forse, culturalmente può sembrarci strano sbirciare al suo interno. Di solito siamo abituati a resettarlo, ad azzerarlo e, ogni qual volta maturiamo una delusione, a voltargli le spalle facendo finta di niente.
Quante volte abbiamo detto a noi stessi e agli amici: “è acqua passata”, “volta pagina e vai avanti”, “devi cancellare il tuo passato”?
Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, c’è chi raccoglie i frutti di ciò che ha seminato e lo fa perché sa dove ha piantato i semi, riconosce i solchi nella terra, non si scorda del cammino fatto.
Loro, gli Aymara, possono anche avere il futuro alle spalle, ma, avendo lo sguardo continuamente fisso sul passato, possono permettersi in sicurezza di saltarci dentro all’indietro.
Note
[1] Per l’americana Alison Gopnik, esperta di apprendimento infantile, i bambini in età prescolare non riescono a collegare le esperienze passate alle intenzioni future, per cui in essi la memoria prospettica è quasi assente. Solo a partire dal quarto anno di vita, il bambino inizia a distinguere e gestire una molteplicità di eventi mentali e questo, attraverso l’apprendimento del linguaggio, determinerà intorno al sesto anno di vita lo sviluppo completo della sua memoria autobiografica.
[2] Possiamo affermare che la metacognizione è governance dei processi mentali di base e superiori o di primo e secondo livello. Come una governante in una grande villa, il soggetto che ha sviluppato capacità metacognitive gestisce nel modo più appropriato tutte le risorse cognitive di base e superiori di cui dispone. Attraverso lo sviluppo della metacognizione, il soggetto diventa il governante dei propri processi cognitivi e l’esploratore di specifiche attitudini riflessive.
[3] Per Gian Piero Quaglino ognuno è chiamato a essere “maestro di se stesso”, ovvero a divenire responsabili del proprio apprendimento nell'ottica di un orientamento più sostenibile e di una trasformazione personale completa. Tuttavia, auto-formazione non è auto-didattica, poiché l’apprendimento autodiretto si manifesta nella capacità di essere autonomi del proprio apprendimento pur riconoscendo al docente un ruolo fondamentale. Per questo motivo possiamo affermare che l’autoformazione si realizza entro rapporti di “autonoma dipendenza” tra docente e discente.
[4] Con il termine infoglut si intende uno stato psicologico di fastidio provocato dalla sovrabbondanza e dall’impossibilità di gestione di informazioni. Nel libro Blog generation di G. Granieri (2007), si utilizza il termine information overload per indicare l'eccesso di informazioni che, non potendo essere elaborate, può portare a una situazione paradossale per cui si realizza l’equazione «infinito = nullo».
[5] Tenuto sotto la supervisione del Prof. Franco Bochicchio presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dell’Università del Salento nell’a.a. 2012-2013, Formare attraverso la memoria è il nome dato al percorso formativo integrativo realizzato all’interno dell’insegnamento di Teorie e tecniche della formazione del corso di laurea triennale in Servizio Sociale. Il percorso formativo, progettato alternando attività laboratoriali a giornate seminariali, nacque dall’ipotesi di esplorare le strutture di conoscenza degli studenti del corso, circa sessanta, in riferimento ai costrutti che connotano la memoria in termini di processo formativo, per valutare il gap rappresentazionale esistente tra conoscenza ingenua e conoscenza scientifica e pervenire alla scrittura di una narrazione collettiva in grado di significare l’esperienza spaesante dell’attentato alla scuola secondaria di secondo grado di Brindisi “Morvillo-Falcone” del maggio 2012, vissuta in prima persona da molti degli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea triennale in Servizio Sociale.
[6] Lo psicologo inglese F.C. Bartlett evidenziava già nel 1932 come l’attività del ricordare, non essendo separata né dai processi di pensiero, né da quelli dell’immaginazione, fosse an effort after meaning, cioè uno sforzo tendente al significato. Dunque, i ricordi, come tutta l’attività cognitiva, sono orientati e diretti verso la ricerca di significati in grado di dare un senso all'operare del soggetto.
[7] L’attribuzione di senso nuovo alle esperienze traumatiche del passato è possibile, da un punto di vista emotivo e cognitivo, grazie alle operazioni mentali di emersione, de-costruzione e costruzione di specifiche immagini e metafore mentali. Nel corso di una ricerca compiuta nella Provincia di Brindisi nel 2014, dal nome La.r.a.: lavorare in rete per l’antiviolenza, che aveva come obiettivo principale la tessitura di una rete di attori sociali per il fronteggiamento del fenomeno della violenza e il supporto psico-socio-assistenziale di donne e minori abusati, si è potuto comprendere come le vittime accolte nelle Case rifugio o nelle Comunità alloggio per gestanti e madri con figli site sul territorio provinciale utilizzassero il linguaggio metaforico come strumento cognitivo privilegiato per attribuire senso al loro doloroso vissuto. Tuttavia, in una primissima fase di presa in carico, di solito successiva al contatto con i Servizi sociali territoriali, con le Forze dell'ordine o i Centri antiviolenza, le donne vittime di maltrattamento non sono in grado di fare emergere o generare metafore del vissuto di violenza poiché, essendo ancora emotivamente invischiate nell’esperienza, non riescono a portarle su un piano cognitivo che permetterebbe loro una maggiore elaborazione. Solamente in un secondo momento, individuato in un tempo di circa sei mesi da chi di questi interventi si occupa, cioè quando le emozioni possono essere maggiormente “pensate”, con l’aiuto di un facilitatore, psicologo o educatore, è possibile costruire metafore più adeguate attraverso le quali attribuire un nuovo senso e distanziarsi psicologicamente dal vissuto violento. Fra le tante metafore raccolte durante la ricerca e, nello specifico, nella delicata e protetta fase di intervista delle vittime, mi piace riportare in questa sede quella del “burattino legato da fili al suo burattinaio”. Proprio come un burattino incapace di muoversi autonomamente si sentiva una donna vittima di violenza ospite di una Casa rifugio, e questa era l’immagine che attribuiva al suo difficile passato prima di intraprendere, assieme ad altre donne, un percorso di autonomia e pervenire alla costruzione di una nuova metafora che potesse meglio spiegare la sua e la vita dei suoi bambini; come quella di “un diamante dalle innumerevoli facce, una per ogni aspetto della sua vita futura”.
[8] Chi scrive è convinto che il soggetto sia generalmente poco consapevole delle influenze degli altri individui nella sua vita. Ripercorrendo il nostro passato, è possibile comprendere come molte decisioni, scelte professionali e progetti siano dipesi dalle opportunità maturate in seguito agli incontri con altri individui che hanno significativamente influenzato i nostri percorsi di vita. Ad esempio, nei diversi momenti dell’orientamento selettivo, fase utilizzata dai selezionatori per misurare l’attitudine al ruolo e il profilo motivazionale, quando si chiede al candidato di raccontare il proprio curriculum vitae secondo una prospettiva sociale e non individuale, cioè secondo gli incontri che hanno portato quel soggetto in quel posto, in quel momento e con quel bagaglio esperienziale, accade che egli si disorienti tanto da stentare a parlare sembrando così di non conoscersi a fondo.
[9] La sensazione di spossatezza è avvertita tanto dal narratore quanto dall’intervistatore, poiché tra i due attori/poli del setting narrativo è come se si dispiegasse un metaforico elastico empatico dalla cui gestione dipende l’esito dell’intervista. Se l’elastico empatico dovesse risultare troppo teso, rischiando persino una lacerazione, l'intervistatore rischierebbe di distanziarsi eccessivamente dal vissuto dell’intervistato, mancando per questo l’appuntamento con l’individuazione degli snodi educativi della sua vita. Viceversa, se l’elastico empatico dovesse risultare poco teso, l’intervistatore parteciperebbe eccessivamente al vissuto dell’intervistato, tanto da esporsi a un coinvolgimento emotivo, affettivo e cognitivo che comunque ne precluderebbe l’esito. La gestione di questo metaforico elastico empatico, cioè la ricerca del giusto posizionamento mentale tra distanza e partecipazione dal vissuto di chi narra, rappresenta un requisito fondamentale di ogni scambio narrativo che abbia finalità scientifiche.
[10] Durante una giornata in compagnia degli ospiti di una comunità terapeutica salentina che si occupa di dipendenze patologiche, ricordo che, nel descrivere il loro percorso di emancipazione dalla droga, emerse come il dialogo con il gruppo, la condivisione del dolore e la costruzione di legami più forti, al di là del programma terapeutico, rappresentasse già il 50%-60% del lavoro su se stessi.
[11] Con riferimento all’esperienza del terremoto aquilano del 2009, utile è la lettura del testo di M. Dallari (a cura di), Scosse e riscosse. Disegni, racconti e conversazioni per elaborare un trauma, Trento, Erickson, 2010.
[12] L’antropologo Leonardo Piasere, parlando di ricerca per impregnazione, introduce la metafora della spugna per indicare l’immersione di ogni soggetto nelle pratiche culturali altrui dalle quali inevitabilmente si emerge inzuppati, intrisi o, nella versione veneta proposta dall’antropologo, imbombegàti.
[13] In ambito psicoterapico l’utilizzo del linguaggio metaforico permette la trasformazione della dimensione tacita delle nostre esperienze emotive in una conoscenza esplicita di tipo dichiarativo, che consente di collocare il fluire delle proprie emozioni entro una cornice interpersonale dell’esperienza. Nella psicoterapia cognitivo-costruttivista, Gelo ha notato come il “coefficiente di densità metaforica” del paziente e del terapeuta nel corso del trattamento, ovvero la frequenza delle metafore prodotte dalla coppia terapeutica, sia molto basso nella fase iniziale caratterizzata dal linguaggio emotivo, alto nella fase caratterizzata dalla riflessione astratta e dalla ristrutturazione cognitivo-affettiva, per poi quasi scomparire nella fase finale della terapia. Questo confermerebbe l’importanza del linguaggio metaforico sia per il reperimento di risorse residuali nel paziente utili per lo sviluppo di fondamentali competenze cognitivo-emotive, sia per l’attivazione di strategie risolutive della propria problematica.
[14] Secondo gli scienziati sociali la condizione di indigenza comporta una riduzione delle capacità intellettive, per cui le generazioni che vivono nella “trappola della povertà” accumulano negli anni importanti deficit cognitivi. La creatività e la nostra capacità progettuale, che sostanziano una “mentalità esplorativa”, lasciano il posto a una “mentalità da carenza” che costringe l’individuo a concentrare le sue energie psichiche e fisiche sui bisogni più impellenti precludendone, allo stesso, tempo possibilità evolutive. Non è più la mancanza di “onore, orgoglio e ambizione” a condurre alla povertà, come professava la famosa teoria descritta da Joseph Townsend nel 1786 nel libro Dissertation on the Poor Laws, bensì la povertà, economica, alimentare e affettiva, a condannarci a una vita cognitivamente limitata che trascura ogni altro obiettivo di miglioramento. In definitiva, la povertà, di tutti i tipi, riduce letteralmente l’immaginazione e la capacità di plasmare la nostra vita (cfr. Mullainathan e Shafir, Scarcity: Why having too little means so much, New York, Times Book, 2013). Anche la Comunità Europea e gli studiosi di welfare ci dicono che la povertà produce cicatrici precoci nello sviluppo cognitivo dei bambini che soltanto le reti di sicurezza e l’inclusione sociale possono aiutare a guarire (cfr. Towards Social Investment for Growth and Cohesion, Comunicazione della Commissione Europea, Brussels, 20/02/2013).
[15] Riporto qui in nota un’esperienza sulla quale ho a lungo riflettuto. L’estate appena passata, mentre ero in spiaggia a prendere il sole, ho visto una bambina affaccendarsi nel cercare conchiglie in riva al mare. Dopo un’ora circa, l’ho rivista ritornare con il secchiello pieno zeppo di conchiglie, perfettamente integre e lavate. Le ho chiesto cosa contenesse il secchiello e le ho fatto i complimenti per la tenacia mostrata nell’avere portato a termine, con buonissimi esiti, la ricerca nonostante il caldo torrido di luglio. Di tutta risposta la bambina, di circa 7-8 anni di età, mi spiegò che il merito, quel giorno, era stato tutto della “fortuna che aveva bussato alla sua porta”. Dedicai poi qualche minuto per spiegare, sotto lo sguardo preoccupato e incuriosito dei genitori, che il merito non era stato della fortuna, bensì suo che aveva dedicato tempo e sforzo fisico alla realizzazione del compito. Le parole dette dalla bambina ci fanno capire quanto potenti strumenti di orientamento del Sé siano le idee, le considerazioni e le rappresentazioni collettive, delle quali ci impregniamo, appunto, per immersione culturale. Allo stesso modo intuiamo quanto sia difficile per un bambino di quell’età sovvertire, per così dire, questo sovrindividuale ordine rappresentazionale, pervenendo altresì a teorie personali del mondo e sulla propria presenza nel mondo. L’atteggiamento di totale accettazione di un’entità esterna che ha governato il suo fare, la fortuna, ci racconta di una bambina che la letteratura definisce helpless, cioè di quei bambini che potrebbero reagire male alle sconfitte, scoraggiarsi facilmente nelle difficoltà o, cosa ben più grave, non rendersi conto di quanto importante sia stato il proprio contributo nella risoluzione di uno specifico problema per mancanza di basi solide di auto-stima.
[16] Lo scrittore Mario Rigoni Stern, che nell’inverno del 1942 era stato sergente maggiore del corpo di spedizione italiano in Russia e in seguito all’armistizio dell’8 settembre del 1943 deportato come IMI nel campo di concentramento di Hohenstein, ospite nel dicembre 2006 a Che tempo che fa, programma televisivo condotto da Fabio Fazio, parla di quanto fosse stato difficile raccontare il dolore al ritorno ad Asiago. Stern racconta di come risultasse sorprendente sentirsi incompresi dalla gente del suo paese e dai suoi stessi familiari che non credevano alle sue storie. Si avvertiva il senso di colpa per essere ritornati, per avere lasciato i compagni in Prussia e per queste ragioni era una vergogna essere ancora vivi. La situazione era paradossale tanto che appena giunto ad Asiago, prima di uscire dal treno, aspettò assieme agli altri reduci una notte intera per poi essere rinchiusi quaranta giorni in contumacia. Dice Stern che spesso le mamme dei soldati che non fecero ritorno ad Asiago non riuscivano a parlarci e per questo i superstiti avvertivano il peso dei compagni rimasti intrappolati nelle gelide steppe. Cfr. M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve, Torino, Einaudi, 2008.
[17] Art. 28, legge 4 maggio 1983, n. 184, così come sostituito dall’art. 24, legge 28 marzo 2001, n. 149, c. 3-7.
[18] Con il termine capacitazione, in inglese capability, la filosofa Martha Nussbaum intende le capacità, anche residuali, che un soggetto può esplicitare e mobilitare nel fronteggiamento di un compito o problema.
Bibliografia
Baldacci M. (a cura di) (2004), I modelli della didattica, Roma, Carocci.
Baldacci M. (2012), Trattato di pedagogia generale, Roma, Carocci.
Bochicchio F. e Di Sabato T. (2007), Lineamenti di organizzazione e gestione delle risorse umane. Logiche interpretative della complessità organizzativa, Lecce, MoviMedia.
Bochicchio F. (2011), Convivere nelle organizzazioni. Significati, indirizzi, esperienze, Milano, Raffaello Cortina.
Bochicchio F. (2012), I bisogni di formazione. Teorie e pratiche, Roma, Carocci.
Bonato A. (2013), Mia madre non è la madre: la ricerca dell’identità nelle persone adottate, “Quaderni di Psicoterapia infantile”, n. 68, Roma, Borla.
Boncinelli E. (2011), La vita della nostra mente, Roma-Bari, Laterza.
Bruner J. (1986), La mente a più dimensioni, Roma-Bari, Laterza.
Bruner J. (1991), La costruzione narrativa della realtà, in M. Ammaniti e D.N. Stern (a cura di), Rappresentazioni e narrazioni, Roma-Bari, Laterza.
Contini M.G. e Manini M. (a cura di) (2007), La cura in educazione. Tra famiglie e servizi, Roma, Carocci.
Dallari M. (a cura di) (2010), Scosse e riscosse. Disegni, racconti e conversazioni per elaborare un trauma, Trento, Erickson.
De Gregorio C. (2011), Così è la vita. Imparare a dirsi addio, Torino, Einaudi.
Demetrio D. (1996), Raccontarsi. L’autobiografia come cura del sé, Milano, Raffaello Cortina.
Epping-Jordan J.E., Compas B.E. e Howell D.C. (1994), Predictors of cancer progression in young adult men and women: Avoidance, intrusive thoughts, and psychological symptoms, “Health Psychology”, vol. 13.
Friedman M.J., Ford J.D., Gusman F.D., Ruzek J.I. e Young B.H. (2001), L’assistenza psicologica nelle emergenze. Manuale per operatori e organizzazioni nei disastri e nelle calamità, Trento, Erickson.
Gelo O. e Mergenthaler E. (2003), Psicoterapia e linguaggio metaforico, “Psicoterapia”, n. 27.
Gelo O. (2007), Le metafore in psicoterapia cognitivo-costruttivista: uno studio empirico su un caso di disturbo di personalità narcisistica (caso K.), in G. Nicolò e S. Salvatore (a cura di), La ricerca sui risultati e sul processo in psicoterapia, Roma, Carlo Amore.
Giusti E. e Ciotta A. (2005), Metafore: nella relazione d’aiuto e nei settori formativi, Roma, Sovera.
Gopnikp A. (2010), Il bambino filosofo. Come i bambini ci insegnano a dire la verità, amare e capire il senso della vita, Torino, Bollati Boringhieri.
Guidi M. e Salvatore S. (2006), Trasformazione di scenario e nuovi modelli di formazione, in F. Bochicchio (a cura di), Gli esperti della formazione. Profili interpretativi di una professione emergente, Melpignano (LE), Amaltea.
Granieri G. (2007), Blog generation, Roma-Bari, Laterza.
Greimas J. (2001), Del senso, Milano, Bompiani.
Halbwachs M. (1997), I quadri sociali della memoria, Napoli, Ipermedium.
Halbwachs M. (2001), La memoria collettiva, Milano, Unicopli.
Holahan C.J. e Moos R.H. (1986), Personality, coping, and family resources in stress resistance: A longitudinal analysis, “Journal of Personality and Social Psychology”, n. 51.
James W. (1950), The principles of psychology, New York, Dover.
Jedlowski P. (2000), Storie comuni. La narrazione nella vita quotidiana, Milano, Bruno Mondadori.
Jedlowski P. (2009), Il racconto come dimora. Heimat e le memorie d’Europa, Torino, Bollati Boringhieri.
Ianes D., Macchia V. e Cramerotti S. (2013), L’individuazione dell’alunno con bisogni educativi speciali su base ICF: indicazioni e strumenti, in D. Ianes e S. Cramerotti (a cura di), Alunni con BES. Bisogni Educativi speciali, Trento, Erickson.
Lewin K. (1939), Field theory and experiment in social psychology: Concepts and methods, “American Journal of Sociology”, vol. 44.
Margalit A. (2006), L’etica della memoria, Bologna, il Mulino.
Marrone G. (1987), Con Roland Barthes alle sorgenti del senso, Roma, Meltemi.
Morin E. (2000), La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero. Milano, Raffaello Cortina.
Mullainathan S. e Shafir E. (2013), Scarcity: Why having too little means so much, New York, Times Book.
Núñez R.E. e Sweetser E. (2006), Aymara, where the future is behind you: Convergent evidence from language and gesture in the cross-linguistic comparison of spatial construals of time, “Cognitive Science”, vol. 30.
Nussbaum M.C. (2002), Giustizia sociale e dignità umana, Bologna, il Mulino.
Papagno C. (2008), Come funziona la memoria, Roma-Bari, Laterza.
Passerini L. (2003), Memoria e utopia. Il primato dell’intersoggettività, Torino, Bollati Boringhieri.
Perucca A. e De Canale B. (2012), L’educazione dell'infanzia e il futuro del mondo, Roma, Armando.
Petitta L., Vecchione M. e Avallone F. (2009), Efficacia personale e prefigurazione del futuro nei giovani lavoratori atipici, “Psicologia dell’educazione”, vol. 3.
Piasere L. (2002), L’etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropologia, Roma-Bari, Laterza.
Quaglino G.P. (a cura di) (2004), Autoformazione. Autonomia e responsabilità per la formazione di sé nell'età adulta, Milano, Raffaello Cortina.
Rigoni Stern M. (2008), Il sergente nella neve, Torino, Einaudi.
Romeo F.P. (2010), Dal ricordo individuale alla memoria collettiva. Riflessioni per una “fabbrica della memoria”, in S. Colazzo (a cura di), Sapere Pedagogico, Roma, Armando.
Romeo F.P. (2012), Ricordi-lucciola: per un consumo etico della memoria, in M.G. Simone (a cura di), Consumo e crisi economica. Risvolti esistenziali e prospettive educative, Napoli, Guida.
Romeo F.P. (2014), La memoria come categoria pedagogica, Tricase (LE), Libellula.
Santoianni F. e Striano M. (2000), Immagini e teorie della mente. Prospettive pedagogiche, Roma, Carocci.
Smorti A. (1994), Il pensiero narrativo. Costruzione di storie e sviluppo della conoscenza sociale, Firenze, Giunti.
Tramma S. (2003), I nuovi anziani. Storia, memoria e formazione nell’Italia del grande cambiamento, Roma, Meltemi.
Vanini P. (2013), La scuola delle competenze, in G. Cerini (a cura di), Le nuove indicazioni per il curricolo verticale, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli.
Vasquez A. e Oury F. (2011), L’organizzazione della classe inclusiva. La pedagogia istituzionale per un ambiente educativo aperto ed efficace, Trento, Erickson.
Vehmas S. (2010), Special Needs: A philosophical analysis, “International Journal of Inclusive Education”, vol. 14.
Art. 28, legge 4 maggio 1983 n. 184, così come sostituito dall’art. 24, legge 28 marzo 2001, n. 149, c. 3-7.