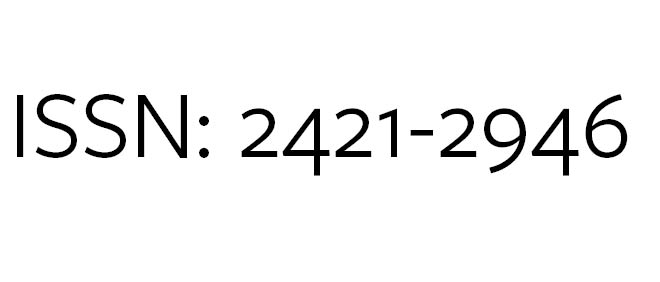Vol. 11, n. 2, ottobre 2025 — pp. 1-3
EDITORIALE
L’Esame di Stato può essere un esame di «maturità»?1
L’attuale Governo sta mettendo mano a una riforma dell’Esame di Stato, che dovrebbe tornare a chiamarsi Esame di maturità.
Rispetto a tale questione occorre porsi almeno due interrogativi. Uno è relativo al senso di questo esame che conclude la scuola secondaria; l’altro è relativo alla legittimità della sua denominazione.
Iniziamo prendendo atto che, a quanto pare, saranno confermate le consuete due prove scritte. La prima destinata all’accertamento della padronanza della lingua italiana e delle capacità espressive e logico-linguistiche. La seconda concernente una disciplina che caratterizza lo specifico corso di studi. A questo proposito, i dubbi sul senso di tali prove sono legittimi. L’insegnante può compiere una stima fondata della preparazione dello studente soprattutto grazie a una serie di prove di valutazione distribuite lungo l’anno scolastico. Alla fine del percorso, per lo più l’insegnante dispone di dati sufficienti per una valutazione circostanziata. Non si vede cosa aggiunga un’ulteriore prova (un compito aggiuntivo di italiano o di un’altra disciplina). Perché dovrebbe avere un valore particolare? Sembra quindi che in questi termini il senso dell’esame finale sia scarso, e non si vede perché si debba considerarlo una prova di «maturità» rispetto all’intero percorso.
Per fare un passo in avanti, occorre tentare di capire quale significato attribuire al termine «maturità». In linea generale, per maturità possiamo intendere il pieno sviluppo delle qualità culturali e intellettuali inerenti a un certo ambito: maturità scientifica, maturità artistica, ecc. Si tratta di uno sviluppo che rappresenta l’esito complessivo di un intero corso di studi.
Per ragioni di coerenza, l’oggetto della valutazione di un esame che si denomina di «maturità» dovrebbe quindi essere il grado di maturità culturale e intellettuale raggiunto dallo studente. Tuttavia, il concetto di maturità viene solitamente inteso in modo generico, senza interrogarsi sul suo significato. Ad esempio, appare del tutto inadeguato ridurre tale maturità alla somma degli apprendimenti delle singole discipline del corso di studi (come di fatto si tende a fare). Parimenti non pare adeguato affidare la stima della maturità a un’interrogazione su alcune materie (probabilmente quattro), come sembra che sarà fatto con il nuovo colloquio orale.
Una concezione più impegnativa collega la maturità a un apprendimento di genere superiore, alla formazione di abiti mentali concernenti l’attitudine a organizzare il pensiero a partire dalle proprie conoscenze, a connettere tra loro tali conoscenze in funzione di un problema da affrontare e via dicendo. Una prova valida per stimare la maturità così intesa dovrebbe richiedere allo studente di trattare una tematica o un problema, formulando e argomentando tesi, e avvalendosi di conoscenze e concetti di più discipline (non necessariamente di tutte, ma soltanto di quelle pertinenti alla questione). Si potrebbe controbattere che a questo era finalizzato il colloquio pluridisciplinare finora praticato. Tuttavia, un colloquio è un modo molto discutibile di stimare il grado di padronanza di tale attitudine. Argomentare in maniera critica e personale una tesi su una determinata questione rappresenta un compito complesso, che richiede un’organizzazione del discorso laboriosa e sistematica. Soltanto l’espressione del pensiero in forma scritta può consentire davvero qualcosa del genere. Il colloquio potrebbe configurarsi piuttosto come una successiva discussione con la commissione di una prova scritta così concepita. Allora la prova di maturità potrebbe aggiungere qualcosa al percorso di studio: tanto una dimensione di valutazione meno praticata nel corso dell’anno, quanto un’esperienza formativa destinata a rendere lo studente più consapevole di sé, del grado di maturità intellettuale e culturale raggiunta. A queste condizioni — cioè se fosse indirizzato a stimare veramente la maturità culturale e intellettuale — tale esame potrebbe avere un senso e un valore. Certamente, una soluzione di questa natura aprirebbe un’altra serie di questioni, tutt’altro che semplici da affrontare. Mi limito ad accennare ad alcune.
Questa modalità di lavoro (testo argomentativo pluridisciplinare su una certa problematica) dovrebbe essere circoscritto al momento dell’esame? Oppure richiederebbe un ripensamento almeno parziale della didattica nel corso dell’ultima annualità? Come dovrebbe essere presentata la traccia dell’elaborato: le connessioni pluridisciplinari dovrebbero essere indicate a grandi linee o dovrebbe essere lo studente a individuarle? L’elaborato dovrebbe essere assegnato nel giorno dell’esame? E in questo caso, con possibilità di accesso a fonti o no? Oppure potrebbe essere scelto e approfondito precedentemente (del tipo, un mese prima dell’esame)? La stessa forma di valutazione della prova di maturità dovrebbe probabilmente essere riconsiderata. Forse, oltre a che a una votazione, o più che ad essa (vi sono già i voti di fine d’anno), si dovrebbe pensare a un giudizio critico articolato formulato dalla commissione sulla prova sostenuta. Ma su questo il discorso sarebbe lungo.
Rispetto a questi e ad altri problemi si potrebbe rispondere con una prima ipotesi da rendere oggetto di un’effettiva sperimentazione, così da correggerla e migliorarla progressivamente. Se si vuole definire l’esame finale come un esame di maturità, e si vuole che sia veramente dotato di senso, occorre considerare seriamente la questione di come si può veramente stimare (e promuovere) ciò che possiamo ragionevolmente intendere per «maturità».
Massimo Baldacci
-
1 Questo editoriale rappresenta una diversa versione di un intervento pubblicato sulla rivista on line «MicroMega» (24/07/2025).