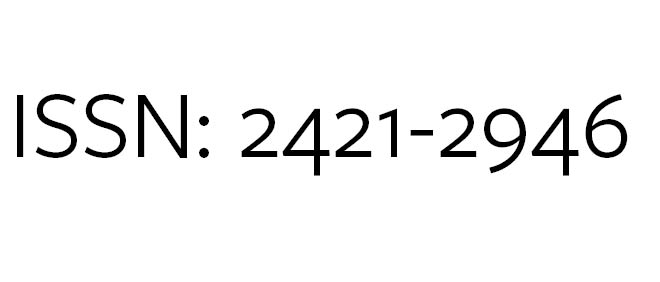Vol. 11, n. 2, ottobre 2025
APPROCCI INTERCULTURALI DELL’EDUCAZIONE
L’agire educativo in chiave interculturale
Farnaz Farahi1
Sommario
L’articolo si propone di ripensare la pedagogia integrando i valori dell’intercultura. Tale inclusione si rende necessaria per permettere alle varie agenzie educative di affrontare al meglio le criticità di cui è caratterizzata la società contemporanea. Per far sì che la pedagogia faccia propri i principi interculturali è opportuno però adottare un nuovo paradigma epistemologico di riferimento. Non un approccio coloniale, ma decoloniale al sapere; non un apprendimento statico, ma dinamico e flessibile della conoscenza.
Seguendo le linee teoriche — tra gli altri — di Cambi, Santerini, Gramsci, Zoletto, Lévinas, Freire, Bruner, Mariani e Mortari, l’articolo propone una visione dell’educazione in cui le differenze non sono semplicemente incluse nella pratica pedagogica, ma diventano esse stesse occasione di crescita e trasformazione attraverso l’incontro e il dialogo. Un’esperienza pedagogica interculturale e situata che, in definitiva, formi soggetti critici, consapevoli e aperti al cambiamento. Capaci ovvero di abitare non solo realtà complesse, ma anche di coltivare un pensiero generativo, in grado di produrre — a partire dell’infanzia — nuovi significati e opportunità di conoscenza.
Parole chiave
Pedagogia interculturale, Pensiero generativo, Agire educativo, Decostruzione, Pedagogia Postcoloniale.
intercultural approaches to education
Educational action from an intercultural perspective
Farnaz Farahi2
Abstract
The article aims to reconceptualize pedagogy by integrating the core values of interculturality. Such inclusion is necessary to enable various educational agencies to effectively address the challenges characteristic of contemporary society. However, in order for pedagogy to genuinely embrace intercultural principles, it is essential to adopt a new epistemological paradigm. This paradigm should be decolonial rather than colonial in its approach to knowledge; it should favor dynamic and flexible learning over static acquisition.
Drawing on the theoretical contributions of scholars such as Cambi, Santerini, Gramsci, Zoletto, Lévinas, Freire, Bruner, Mariani, and Mortari, the article proposes a vision of education in which differences are not merely incorporated into pedagogical practice, but rather serve as opportunities for growth and transformation through encounter and dialogue. This intercultural and situated pedagogical experience ultimately aims to cultivate critical, self-aware, and open-minded individuals. Capable not only of navigating complex realities but also of fostering generative thinking that produces — starting from childhood — new meanings and knowledge opportunities.
Keywords
Intercultural pedagogy, Generative thinking, Educational practice, Deconstruction, Postcolonial pedagogy.
Introduzione
Viviamo in una società segnata dalla complessità e dalla pluralità culturale (Santerini, 2010; Morin, 2023; Pinto Minerva, 2002). Si rende pertanto necessario un ripensamento della pedagogia affinché quest’ultima sia realmente in grado di rispondere alle nuove esigenze formative degli educandi. In questa prospettiva, l’integrazione dei valori interculturali rappresenta un passaggio imprescindibile (Santerini, 2010). Tale perfezionamento arricchisce l’educazione di quegli elementi — quali il dialogo, l’ascolto, l’accettazione dell’alterità — indispensabili agli individui per affrontare in modo efficace le trasformazioni sociali in atto (Callari Galli, 1996; Cambi, 2006a, 2006b).
Partendo da un’analisi dell’intercultura in chiave pedagogica e dall’identificazione di un adeguato paradigma epistemologico di riferimento, il presente contributo esamina gli elementi e i valori di cui è composto il processo di integrazione tra pratica educativa e prospettiva interculturale, ovvero: il pensiero decoloniale (Freire, 2002, 2014; Farahi, 2024; Zoletto, 2011), la decostruzione critica del sapere (Mariani, 2008) e la costruzione di uno nuovo spazio generativo della conoscenza (Bruner, 1992; Mortari, 2017, 2019).
Una prima rilettura in chiave pedagogica dell’intercultura
Il termine «intercultura» è dato «dal prefisso inter che equivale a interazione, scambio, messa in gioco, e dal sostantivo cultura, che implica il riconoscimento dei valori e della diversità» (Portera, 2013, p. 43). Si tratta di un concetto che apre a un legame tra universalismo e relativismo, aggiungendo nuove possibilità di incontro, confronto e interazione tra persone, culture e società (Portera, 2013; Maviglia, 2017).
Stante questa definizione, possiamo considerare l’intercultura come la risposta educativa alla società multiculturale e multietnica dei nostri tempi, da cui qualsiasi agenzia formativa è oramai caratterizzata (Pinto Minerva, 2002; Callari Galli, Ceruti e Cambi, 2016).
Secondo Cambi (2006, 2006a) lavorare in tale direzione significa approcciarsi alle strategie riguardanti l’infanzia — sia educative che didattiche — con una mentalità aperta e flessibile, oltrepassando i limiti del senso di appartenenza, per aprirsi alle risorse della differenza (Cambi, 2006). Una mentalità che ridia valore all’incontro inteso come spazio fisico e mentale, nonché riconoscimento e validazione dell’altro (Callari Galli, 1996; Cambi, 2006). Soltanto aprendosi a tali valori la pedagogia potrà riconoscere (e far riconoscere) non come ostacolo, ma come risorsa e occasione di crescita il multiculturalismo che contraddistingue la collettività (Morin, 2023).
Perché la pedagogia faccia propria la prospettiva interculturale, occorre che quest’ultima «si concretizzi in modelli educativi, didattici, organizzativi» (Santerini, 2010, p. 15) più specifici. Ovvero, adeguare standard formativi e educativi (di pedagogisti, insegnanti, educatori, allievi e educandi) a nuovi ideali: non una pedagogia diretta al particolare, ma, come detto, alla complessità (Callari Galli, Cambi e Ceruti, 2016; Morin, 2023). Un necessario neo-paradigma, quello basato sulla complessità, di matrice interculturale, che sappia ripensare tutti i saperi, la formazione dell’Io e della mente di educatori e educandi (Cambi, 2016).
Per complessità, in particolare, intendiamo il fenomeno «della problematicità, della concretezza e del rilievo culturale che ineriscono costitutivamente all’esperienza educativa» (Massa, 1990, p. 250). O, ancora, «un fascio assai articolato di discorsi, tra loro fortemente eterogenei. Essa raccoglie discorsi tecnici e pratici, scientifici e filosofici, normativi e descrittivi, presentando un volto di confusione “endemica”. Questo pluralismo interno non è però accidentale, anzi si delinea come costitutivo» (Cambi, 1986, p. 12) della contemporaneità.
Tale categoria […] si è imposta come categoria-chiave/caratterizzante/strutturale per il nuovo mondo (tecnologico, informatico, multiculturale, globalizzato, in costante cambiamento, de-ideologizzato — rispetto a ideologie-visioni del mondo forti e compatte —, in cui gli individui sono più consci del proprio ruolo, ma anche più soli e disorientati) che è già in atto o almeno in cammino. […] La pedagogia deve evidenziare il ruolo formativo (e in senso sociale e in senso soggettivo-personale), deve fissare le nuove competenze cognitive e le formae mentis richieste, e deve pure contrassegnare il nuovo tipo di socializzazione che viene ad attivarsi, sempre in relazione al paradigma della complessità, assunto come modello e regola (Cambi, 2016, pp. 136-137).
D’altronde, la concezione dell’Io quale entità soggettiva è da tempo in crisi (Morin, 2023), essendo stata sostituita dal cosiddetto «Io-multiplo» (Elster, 1991). L’Io contemporaneo non è più un nucleo omogeneo e immutabile, ma un’entità complessa, frammentata e dinamica, composta da molteplici sfaccettature, identità e ruoli che coesistono e si alternano (Cambi, 2006a; Elster, 1991). Bauman (2002) ne parla in termini di «modernità liquida» per sottolineare come la società di oggi sia entrata in una fase di estrema fluidità, instabilità e trasformazione continua.
Ne deriva che adottare la complessità interculturale nella pratica pedagogica odierna vuol dire costruire una nuova conoscenza epistemica che metta da parte l’attitudine a organizzare la conoscenza (Morin, 1999), per aprirsi invece a un sapere che accetti l’incompletezza e l’incertezza della società quali costitutivi irrinunciabili di qualsiasi forma di apprendimento e educazione (Bocchi e Ceruti, 1985; Bauman, 2002).
I principi cartesiani di analisi e riduzionismo non si addicono al sapere attuale, che richiede un approccio olistico. Nella ricerca dell’unità si mantiene però l’attenzione per le realtà conflittuali irriducibili sottese a ogni dinamica integrativa di tipo retroattivo, dialogico, ecologico. Il sapere di soggetti nel loro contesto storico-ambientale rigenera un umanesimo che non soffre di astrattezza formale (Morin, 1999, p. 47).
Quale cornice teorico-applicativa interculturale per l’educazione?
Definita la prospettiva interculturale come nuova cornice teorica per la pedagogia, indispensabile per affrontare la complessità sociale, è necessario domandarsi in che modo essa possa concretamente integrarsi nella pratica educativa quotidiana. Santerini (2010) afferma che si può parlare di approccio interculturale all’educazione nel momento in cui si comunica, attraverso la pratica pedagogica, rispetto e valorizzazione della diversità, sostenendo una ricerca di valori comuni con spirito critico, superando un atteggiamento relativistico (Santerini, 2021). Non si tratta, però, di dare all’educazione un’impostazione oggettiva, cioè «attribuibile dall’esterno a un gruppo, spesso sulla base di pregiudizi» (Santerini, 2010, p. 16), ma soggettiva.
Parlare di approccio interculturale soggettivo significa integrare nell’agire pedagogico una visione che consideri l’educando nelle sue specificità, «senza attribuirgli in modo stereotipato l’idea che si ha, quasi sempre superficiale o erronea, della sua “cultura”» (Santerini, 2010, p. 16). Una visione interculturale che modifichi non solo l’agire pedagogico in senso lato, ma la struttura stessa dell’organizzazione che lo presiede, le metodologie (educative e didattiche), le relazioni tra professionisti e famiglie, la prospettiva con cui guardare ai saperi, la quale deve divenire interdisciplinare e maggiormente sostenibile in termini finanche di giustizia (Santerini, 2010, 2018).
Tali aspetti, coniugati con la pratica professionale, devono inoltre essere realizzati in modo «flessibile […], temporaneo […] e con progetti individuali basati sulle competenze linguistiche» (Santerini, 2010, p. 23). Competenze che consentano non solo di agire nel quotidiano, ma anche di comprendere un testo, esprimersi in modo appropriato e scrivere con ricchezza lessicale e di vocabolario (Santerini, 2010; Baldacci, 2010).
Santerini (2010, 2018, 2021), in sintesi, identifica le dimensioni su cui deve essere definita la prospettiva interculturale dell’educazione (e della didattica) all’interno della complessità: una visione dinamica del concetto di cultura, dove la competenza poggia sull’interpretazione antropologica della realtà, piuttosto che sulla conoscenza di nozioni predeterminate; la necessità di integrare aspetti di riflessività, ponendo l’affettività come base per una relazione efficace; riconoscere che i diversi elementi sociali, personali e culturali sono in rapporto d’influenza reciproca; il bisogno non solo di promuovere uno spazio di tolleranza, ma uno «spazio terzo» di fiducia e reciproca trasformazione (Callari Galli, 1996); includere nell’educazione una dimensione etico-politica, per promuovere — in prospettiva — un’idea di cittadinanza non nazionalistica, ma globale e basata sull’interdipendenza e la comprensione pacifica tra i popoli (Santerini, 2010, 2017, 2018). Come afferma Fiorucci (2020),
l’orientamento interculturale nel contesto educativo ha l’obiettivo di definire un progetto intenzionale di promozione del dialogo e del confronto culturale rivolto a tutti, autoctoni e stranieri. In questo modo, le diversità (culturali, di genere, di classe sociale, biografiche, di orientamento politico, sessuale, ecc.) divengono un punto di vista privilegiato dei processi educativi, offrendo l’opportunità a ciascuno di svilupparsi a partire da ciò che è (Fiorucci, 2020, p. 42).
Assimilare l’intercultura all’interno dell’agire pedagogico significa allora:
- in primo luogo, superare la logica coloniale che ancora orienta molte pratiche educative per abbracciare una prospettiva decoloniale e postcoloniale, capace di mettere in discussione saperi e poteri consolidati (Farahi, 2024; Zoletto, 2011, 2016);
- in secondo luogo, decostruire le categorie tradizionali della conoscenza, nonché quelle egemoniche di potere — tipiche del pensiero coloniale — per generare nuove chiavi interpretative attraverso gli stessi strumenti critici offerti dall’intercultura (Mariani, 2008);
- infine, attivare una relazione educativa che sia generativa di significato (Bruner, 1992), che non includa semplicemente l’altro, ma accolga la domanda implicita che quest’ultimo porta con sé, trasformando l’incontro in un’occasione di crescita reciproca (Callari Galli, 1996; Catarci e Macinai, 2015). L’altro non è più ridotto a oggetto di inclusione o a elemento da gestire all’interno di cornici predefinite, ma si configura come soggetto che interpella, destabilizza e arricchisce il processo educativo (Fiorucci, 2020; Santerini, 2010).
Superare la logica coloniale della pedagogia
Analizziamo il primo punto, ovvero il superamento della logica coloniale. Il cosiddetto colonialismo è portatore di una mancanza di democraticità nei processi pedagogici, poiché caratterizzato da non-dialogo e passività che poco si adatta alla società complessa di cui sopra abbiamo riferito (Callari Galli, Ceruti e Cambi, 2016; Muraca, 2021). Adottare la logica coloniale vorrebbe dire abbracciare e fare propria quella contrapposizione tra classe dominante e classe subalterna che Gramsci (1975) ha teorizzato quale fondamento dell’egemonia culturale (Baldacci, 2018). Una contrapposizione che si declina in una distinzione binaria tra «noi» e «loro», dove l’altro — che sia una cultura, una lingua, un’identità etnica o sociale — viene rappresentato come inferiore, statico o irrimediabilmente differente (Gramsci, 1975). Secondo lo schema prospettato da Gramsci (1975), la classe dominante non si limita a esercitare il potere nei confronti del subalterno, ma agisce anche attraverso la neutralizzazione e l’annullamento dei valori — culturali e educativi — di quest’ultimo (Crehan, 2010).
La storia dei gruppi sociali subalterni è necessariamente disgregata ed episodica. È indubbio che nell’attività storica di questi gruppi c’è la tendenza all’unificazione sia pure su piani provvisori, ma questa tendenza è continuamente spezzata dall’iniziativa dei gruppi dominanti, e pertanto può essere dimostrata solo a ciclo storico compiuto, se esso si conchiude con successo. I gruppi subalterni subiscono sempre l’iniziativa dei gruppi dominanti, anche quando si ribellano e insorgono: solo la vittoria permanente spezza, e non immediatamente, la subordinazione. In realtà, anche quando paiono trionfanti, i gruppi subalterni sono in istato di difesa allarmata (Gramsci, 1975, nota C.Q. 25,2).
L’educazione, però, come afferma Freire (2002, 2014), si configura già di per sé quale strumento di libertà e, per tal motivo, si contrappone — per definizione — al colonialismo pedagogico, nonché a tutto ciò che questo comporta. Integrare i valori interculturali nella pedagogia significa di conseguenza trasformare il pensiero coloniale — parcellizzante, divisivo e categorizzante — in decoloniale. Dove per pensiero decoloniale si intende un agire pedagogico che fa propri i valori dell’accettazione, della diversità, della tolleranza (Muraca, 2021; Freire, 2002; Hall, 2006), smuovendo nuove occasioni di sviluppo sociale (Farahi, 2024). L’integrazione di questi elementi interculturali permette il superamento delle categorie egemoniche legate a logiche di potere tra oppressi e oppressori (Freire, 2002; Gramsci, 1975), per aprirsi, invece, a nuove forme di ricostruzione del sapere derivanti, piuttosto, dall’incontro delle diversità (Cambi, 2006a).
La pedagogia decoloniale va alla ricerca del «senso comune» gramsciano (Crehan, 2010), inteso non come sapere egemonico, non come «qualcosa di irrigidito e di immobile», ma come qualcosa che «si trasforma continuamente, arricchendosi di nozioni scientifiche e di opinioni filosofiche entrate nel costume» (Gramsci, 1975, Q: 2271, 76). Una modalità educativa che supera qualsiasi tentativo categorizzante degli esseri umani (Elamé, 2011), per aprirsi a forme di conoscenza che non semplificano la complessità, ma la affrontano e integrano nell’agire quotidiano in termini di valori, cittadinanza, eredità comune e apprezzamento dell’alterità (Said, 1979, 2004; Cambi, 2006a; Santerini, 2010).
Zoletto (2011, 2016), a riguardo, afferma che la teoria post-coloniale (Said, 1979, 2004) può sfidare le concezioni tradizionali dell’educazione, andando nella direzione di una pedagogia e di una scuola pienamente interculturali. L’autore, infatti, sostiene, in primo luogo, l’importanza di adottare un approccio non riduttivo verso la diversità che si manifesta nei contesti educativi contemporanei, in quanto territori socioculturalmente complessi (Zoletto, 2022). In secondo luogo, riferisce che adottare uno sguardo postcoloniale sul fenomeno educativo aiuta a cogliere la molteplicità dei discorsi e le intersezioni di genere, classe sociale, razza, età, che influiscono sui processi di soggettivazione di educandi con background migranti o postmigranti (Zoletto, 2016).
Sotto il profilo dell’agire educativo, la visione postcoloniale di Zoletto (2011, 2016) si traduce nella seguente proposta (Zoletto e Zanon, 2019):
- favorire l’acquisizione di chiavi di lettura utili a «cogliere e leggere la pluralità di linguaggi, differenze e relazioni presenti nelle classi odierne, nonché a vederli come altrettanti punti di forza dai quali partire per progettare percorsi di apprendimento/insegnamento inclusivi» (Zoletto e Zanon, 2019, p. 138);
- far acquisire agli educandi (e, in seguito, ai discenti) strumenti utili a gestire questa complessità e a organizzarla in forme di progettazione in grado di valorizzare i punti di forza di ogni allievo e allieva (Zoletto e Zanon, 2019);
- «prendere consapevolezza e, laddove possibile, sperimentare in prima persona la valenza inclusiva e interculturale che possono svolgere in tale prospettiva ambienti e pratiche tecnologicamente mediate, in particolare in contesti segnati da elevata complessità linguistica, sociale e culturale» (Zoletto e Zanon, 2019, p. 138).
La necessaria decostruzione del sapere pedagogico
Adottare la prospettiva interculturale e decoloniale sotto il profilo pedagogico, nei canoni educativo-applicativi sopra riportati, presuppone un altro passaggio imprescindibile: la decostruzione del sapere. Decostruire significa smantellare le categorie concettuali e i dispositivi educativi che riproducono, in modo più o meno implicito, logiche di gerarchia, esclusione e marginalizzazione (Mariani, 2008).
Attraverso la decostruzione si mette in discussione l’illusione di universalità che ha storicamente caratterizzato le epistemologie occidentali, aprendo la pedagogia al riconoscimento e alla valorizzazione di narrazioni e prospettive — interculturali — provenienti da contesti storicamente subalterni o silenziati (Said, 1979; Gramsci, 1975).
La via della decostruzione supera il logocentrismo della tradizione occidentale per accedere al pensiero della differenza radicale, posta come disseminazione, de-centramento (Mariani, 2008; Said, 1979, 2004).
Un sapere è tale per le sue regole analitiche, ma anche per i suoi connotati trascendentali, storico-culturali e per le strutture a-priori che assegnano a quel sapere un senso e una funzione, ovvero un compito e un orientamento. La decostruzione vuole smascherare questi fondamenti, renderli leggibili e disvelarli; essa agisce come un dispositivo preliminare per dissotterrare i pre-giudizi e far emergere le infrastrutture, i nascosti, i non-detti (Mariani, 2008, pp. 19-20).
Trasmutare la logica decoloniale e decostruzionista all’interno della pedagogia, più precisamente, comporta abbandonare la linearità dell’educazione, per aprirsi a sistemi circolari della relazione educatore-educando e insegnante-allievo (Baldacci, 2019). Nel paradigma della complessità interculturale il sapere non procede in modo unidirezionale dall’educatore all’educando — e, in linea più generale, dall’adulto al bambino.
Adottare questo pensiero riattualizzerebbe quell’errata logica coloniale fondata su uno squilibrio strutturale di potere e sul controllo del sapere da parte del «più forte» nei confronti del subalterno (Gramsci, 1975). Una prospettiva che, come abbiamo visto, mal si adatta all’odierno multiculturalismo pedagogico (Cambi, 2006a, 2006b). La decostruzione invita piuttosto a fare qualcosa di diverso, poiché
è considerata sia nella sua dimensione processuale e teorica del lavoro di riflessione sui propri costrutti culturali ed educativi, sia come prassi che spinge verso la capacità e la disposizione a mettersi in questione, a riconsiderare e rivalutare le proprie idee, opinioni, atteggiamenti, attraverso i processi di relativizzazione, di storicizzazione e di decentramento delle categorie concettuali (Vaccarelli, 2008, p. 4).
La critica decostruttiva dimostra che i confini del sapere sono ben più permeabili rispetto a quanto si creda e che, in funzione del multiculturalismo, qualsiasi insegnamento o pratica educativa deve essere considerato dinamicamente e non staticamente. I concetti stessi non sono monolitici, ma concatenazioni di significato che, una volta decostruiti, aprono a loro volta a nuovi significati (Bruner, 1992; Mariani, 2008). Non esistono verità assolute (Bauman, 2002), poiché ogni sapere è situato e, dunque, il proprio punto di vista deve essere rivisto — potremmo dire decostruito — costantemente in funzione dell’altro (Lévinas, 1998).
L’educazione e la didattica si configurano, in definitiva, come spazio interculturale, dialogico e relazionale, in cui il sapere non è precostituito, ma si costruisce nell’incontro (Callari Galli, 1996), nel confronto e nel riconoscimento dell’altro, in un processo di reciproco scambio (Sleeter e McLaren, 1995; Ulivieri, 1997).
Lo stesso Freire (2002) afferma che il tradizionale approccio educativo — secondo il quale l’apprendimento viene concepito come un insieme di conoscenze già definite e statiche, che l’educatore deposita nell’educando, il quale ha un ruolo puramente passivo e ricettivo — è oppressivo, funzionale e addomesticante.
Decostruirlo comporta intervenire sul piano teorico e pratico superando la trasmissione monodirezionale del sapere e riconoscendo la molteplicità dei punti di vista (Morin, 2001), nonché la capacità sia dell’educatore di influenzare l’educando, che dell’educando di trasformare l’educatore in una relazione, come anticipato, di natura circolare (Baldacci, 2019).
La pedagogia come spazio generativo
Decolonizzare e decostruire il sapere in senso interculturale, però, non basta. A partire dal confronto e dallo spazio di incontro (Callari Galli, 1996) occorre costruire, generare nuove forme di significati (Bruner, 1992; Lévinas, 1998). Instaurare percorsi di «aggiustamento della propria biografia disancorandosi da forme sociali storicamente stabilite» (Di Fraia e Risi, 2017, p. 54). Permettere all’educando, a partire dall’infanzia, di orientarsi, sperimentarsi e riadattarsi, in maniera autonoma, nell’incertezza della complessità (Formenti et al., 2017; Morin, 1999, 2023).
In un certo senso lo scopo dell’educazione dovrebbe essere quello di rivedere le concezioni errate e gli stereotipi che, a quanto sembra, prendono corpo in tutto il mondo durante i primi dieci anni di vita. Nello stesso tempo, tuttavia, l’educazione dovrebbe anche cercare di preservare le caratteristiche più notevoli della mente infantile: il suo amore per l’avventura, la sua generatività, la dovizia delle sue risorse, i suoi lampi di creatività e flessibilità (Gardner, 1993, p. 142).
L’azione pedagogica non deve essere una trasmissione nozionistica e categoriale di informazioni, ma un processo esperienziale, che si costruisce nel contatto diretto con il reale e con l’altro (Callari Galli, 1996). Per Dewey (1916, 1938), d’altronde, il soggetto apprendente — o, meglio, l’educando — è nell’esperienza relazionale che viene continuamente sollecitato a confrontarsi con la complessità, a mettere in discussione le proprie certezze e a ridefinire il proprio posizionamento nel mondo.
La generatività pedagogica, pertanto, comporta, oltre a una decolonizzazione e a una decostruzione del sapere nel senso interculturale sopra inteso, anche una formazione finalizzata al «disordine che si rinnova di continuo» (Mannese, Lombardi e Marigliani, 2023, p. 107).
La realizzazione di un progetto di vita, in quest’ottica, passa inevitabilmente attraverso un percorso esistenziale di orientamento che assuma i connotati della generatività e che, in quanto tale, favorisca la scoperta di sé e dell’altro come «fine e non mezzo», come «soggetto culturalmente modificabile» (Mannese, 2016), come individuo dotato di pensiero generativo e portato a muoversi verso una direzione, delineando su di sé un proprio progetto formativo (Batini e Del Sarto, 2005).
Una generatività che permetta all’educando di adattarsi alle mutevoli e incerte condizioni della società grazie ai meccanismi interculturali riflessivi, di confronto e dialogo (Bruner, 1992; Callari Galli, 1996).
Conclusioni
Il ragionamento fin qui condotto ci dirige ad alcune considerazioni finali.
L’apprendimento e l’educazione postmoderni non possono essere più concepiti come processi statici e autoreferenziali, finalizzati unicamente all’acquisizione di conoscenze o competenze. Al contrario, sono un insieme di azioni che prendono avvio dall’educatore-insegnante e si sviluppano nell’educando in modo dinamico-plastico (Santerini, 2010), epigenetico e trasformativo, congiungendo inevitabilmente elementi di matrice interculturale nei processi di apprendimento cognitivo (Bandura, 2012; Mannese, 2022).
Con il termine dinamico-plastico ci si riferisce alla capacità dell’apprendimento di modellarsi e adattarsi in funzione dei contesti, delle relazioni e delle differenze che lo attraversano (Santerini, 2010; Zoletto, 2011, 2022). La componente epigenetica, invece, mutuata dalle scienze biologiche, sottolinea come lo sviluppo dell’individuo non sia predefinito, ma influenzato e potenziato dall’ambiente, dalle esperienze e dall’incontro con l’alterità. L’elemento trasformativo, infine, è la vera e propria dimensione generativa dell’apprendimento che considera ogni conoscenza o competenza acquisita non come un punto di arrivo, ma come uno strumento per giungere a qualcos’altro, a livello sia individuale che sociale, in una logica di crescita continua (Callari Galli, 1996; Mannese, 2022).
In questo senso, l’unione dei valori interculturali — nonché della decolonizzazione e decostruzione del sapere — conducono a una pedagogia intesa come non-luogo del cambiamento di cui l’educatore/insegnante deve farsi facilitatore (Mannese, 2022). Uno spazio simbolico e educativo che non ha confini rigidi né forme predefinite, ma si costituisce come terreno aperto per generare nuove possibilità «liquide» (Bauman, 2002) di conoscenza, nonché di identità e convivenza (Mortari, 2017, 2019).
Un fare educativo interculturale e allo stesso tempo agentivo (Bandura, 2012) — capace di decostruire in modo continuo le forme tradizionali del sapere e immancabilmente sostenuto da politiche e reti territoriali integrate, prive di logiche coloniali — rappresenta la condizione necessaria per conferire alla relazione educativa un carattere di apprendimento generativo (Bruner, 1992). Solo così, e con gli approcci applicativi sopra identificati grazie a Santerini (2010, 2018; Zoletto, 2011, 2022), l’educando svilupperà le competenze per affrontare efficacemente le complesse sfide — presenti e future — della realtà contemporanea.
Bibliografia
Baldacci M. (2010), Curricolo e competenze, Milano, Mondadori.
Baldacci M. (2018), Oltre la subalternità. Praxis e educazione in Gramsci, Roma, Carocci.
Baldacci M. (2019), Trattato di pedagogia generale, Roma, Carocci.
Bandura A. (2012), Adolescenti e autoefficacia, Trento, Erickson.
Batini F. e Del Sarto G. (2005), Narrazioni di narrazioni. Orientamento narrativo e progetto di vita, Trento, Erickson.
Bauman Z. (2002), Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza.
Bocchi P. e Ceruti M. (a cura di) (1985), Le sfide della complessità, Milano, Feltrinelli.
Bruner J.S. (1992), La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Torino, Bollati Boringhieri.
Callari Galli M. (1996), Lo spazio dell’incontro. Percorsi nella complessità, Roma, Meltemi.
Callari Galli M., Cambi F. e Ceruti M. (2016), Formare alla complessità. Prospettive dell’educazione nelle società globali, Roma, Carocci.
Cambi F. (1986), Il congegno del discorso pedagogico, Bologna, CLUEB.
Cambi F. (2006a), Incontro e dialogo. Prospettive della pedagogia interculturale, Roma, Carocci.
Cambi F. (2006b), Abitare il disincanto. Una pedagogia per il postmoderno, Torino, Utet.
Cambi F. (2016), La complessità come paradigma formativo. In M. Callari Galli, F. Cambi e M. Ceruti, Formare alla complessità. Prospettive dell’educazione nelle società globali, Roma, Carocci.
Catarci M. e Macinai E. (a cura di) (2015), Le parole-chiave della Pedagogia Interculturale. Temi e problemi nella società multiculturale, Pisa, ETS.
Crehan K. (2010), Gramsci, cultura e antropologia, Lecce, Argo.
Dewey J. (1916), Democrazia e educazione, Roma, Anicia.
Dewey J. (1938), Esperienza e educazione, Milano, Raffaello Cortina.
Di Fraia G. e Risi E. (2017), Storie e percorsi tra tempo e identità. Le aspirazioni dei giovani in una ricerca narrativa. In F. Batini e S. Giusti (a cura di), Empowerment delle persone e delle comunità, Lecce, PensaMultimedia, pp. 58-64.
Elamé E. (2011), Il sé e l’altro: Per una pedagogia postcoloniale, «Formazione & Insegnamento», vol. 3, n. IX, pp. 203-216.
Elster J. (1991), L’io multiplo, Milano, Feltrinelli.
Farahi F. (2024), La mediazione interculturale e l’insegnante inclusivo come focus della pedagogia decoloniale, «Pedagogia e Vita», vol. 2, pp. 49-56.
Fiorucci M. (2020), Educazione, formazione e pedagogia in prospettiva interculturale, Milano, FrancoAngeli.
Formenti L., Luraschi S., Galimberti A. e Rossi M. (2017), Orientamento cooperativo: dalle storie di vita al sistema orientante. In F. Batini e S. Giusti (a cura di), Empowerment delle persone e delle comunità, Lecce, PensaMultimedia, pp. 72-79.
Freire P. (2002), La pedagogia degli oppressi, Torino, Gruppo Abele.
Freire P. (2014), Pedagogia dell’autonomia. Saperi necessari per la pratica educativa, Torino, Gruppo Adele.
Gardner H. (1993), Educare al comprendere. Stereotipi infantili e apprendimento scolastico, Milano, Feltrinelli.
Gramsci A. (1975), Storia della classe dominante e storia delle classi subalterne. In A. Gramsci, Quaderni dal carcere, Torino, Einaudi.
Hall S. (2006), Il soggetto e la differenza. Per un’archeologia degli studi culturali e postcoloniali, Roma, Meltemi.
Lévinas E. (1998), Tra noi, Milano, Jaca Book.
Mannese E. (2016), Saggio breve per le nuove sfide educative, Lecce, PensaMultimedia.
Mannese E. (2022), La progettazione educativa tra Orientamento e Lavoro. Generatività-Confine-Progettualità: I luoghi del cambiamento, «Attualità pedagogiche», vol. 4, n. 1, pp. 1-2.
Mannese E., Lombardi M.G. e Marigliani R. (2023), Il paradigma della pedagogia generativa tra orientamento e sviluppo dell’empowerment individuale, «EdaForum», vol. 20, n. 43, pp. 101-110.
Mariani A. (2008), La decostruzione in pedagogia. Una frontiera teorico-educativa della postmodernità, Roma, Armando.
Massa R. (1990), Istituzioni di pedagogia e scienze dell’educazione, Roma-Bari, Laterza.
Maviglia D. (2017), Intercultura e Critical Pedagogy. In M. Fiorucci, F. Pinto Minerva e A. Portera (a cura di), Gli alfabeti dell’intercultura, Pisa, ETS, pp. 373-382.
Morin E. (1999), La testa ben fatta, Milano, Raffaello Cortina.
Morin E. (2001), I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Milano, Raffaello Cortina.
Morin E. (2023), La sfida della complessità, Firenze, Le Lettere.
Mortari L. (2017), La sapienza del cuore. Pensare le emozioni, sentire i pensieri, Milano, Raffaello Cortina.
Mortari L. (2019), Aver cura di sé, Milano, Raffaello Cortina.
Muraca M. (2021), Colonialismo e decolonizzazione negli scritti di Paulo Freire, «Encyclopaideia — Journal of Phenomenology and Education», vol. 25, n. 61, pp. 81-96.
Pinto Minerva F. (2002), L’intercultura, Roma-Bari, Laterza.
Portera A. (2013), Manuale di pedagogia interculturale, Roma-Bari, Laterza.
Said E.W. (1979), Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli.
Said E.W. (2004), La pace possibile. Riflessioni, critiche e prospettive sui rapporti israelo-palestinesi, Milano, Il Saggiatore.
Santerini M. (2010), L’intercultura di «seconda generazione». In M. Santerini (a cura di), La qualità della scuola interculturale. Nuovi modelli per l’integrazione, Trento, Erickson, pp. 11-36.
Santerini M. (2017), Donne immigrate e nuova cittadinanza democratica, «Pedagogia Oggi», vol. XV, n. 1, pp. 25-37.
Santerini M. (2018), Educazione sostenibile e giustizia in educazione, «Pedagogia Oggi», vol.XVI, n. 1, pp. 71-82.
Santerini M. (2021), Educazione alla cittadinanza e complottismo. Dal sospetto al pensiero critico, «Pedagogia Oggi», vol. XIX, n. 2, pp. 22-29.
Sleeter C.E. e McLaren P. (a cura di) (1995), Multicultural education, critical pedagogy and the politics of difference, Albany, Suny Press.
Ulivieri S. (a cura di) (1997), L’educazione e i marginali, Firenze, La Nuova Italia.
Vaccarelli A. (2008), Dal razzismo al dialogo interculturale. Il ruolo dell’educazione negli scenari della contemporaneità, Pisa, ETS.
Zoletto D. (2011), Pedagogia e studi culturali. La formazione tra critica postcoloniale e flussi culturali transnazionali, Pisa, ETS.
Zoletto D. (2016), La prospettiva teorica postcoloniale alla prova dei banchi di scuola italiani, «From the European South», n. 1, pp. 43-49.
Zoletto D. e Zanon F. (2019), I molti linguaggi delle classi eterogenee. Riflessioni a partire dall’esperienza del Laboratorio di educazione interculturale e crossmediale dell’Università di Udine, «Educazione Interculturale. Teorie, Ricerche, Pratiche», vol. 17, n. 2, pp. 135-146.
Zoletto D. (2022), Comunità educanti e complessità: Spunti in prospettiva pedagogico-interculturale, «Formazione & Insegnamento», vol. XX, n. 2, pp. 404-410.
Vol. 11, Issue 2, October 2025