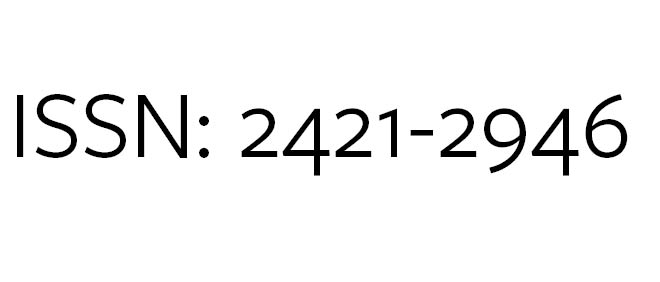Vol. 11, n. 2, ottobre 2025
MODELLI EDUCATIVI
La «sindrome degli antenati» di A.A. Schützenberger
Fenomenologia della famiglia attraverso il realismo magico di Márquez
Santina Carrozza1
Sommario
La famiglia è l’agenzia educativa primaria ai legami in disparità e in parità di potere con un carattere formativo specifico e determinante, sia per i figli che per tutti i membri. Nel mondo occidentale, nonostante i vari cambiamenti che nel tempo ha subito, la famiglia, nel contesto sociale, resta di fondamentale interesse, in quanto luogo di appagamento dei bisogni primari e di riproduzione dei valori di costruzione della propria identità. È indiscutibile che per la maggior parte degli esseri umani la famiglia rappresenti la prima carezza che accoglie nel mondo, nei gesti con cui i genitori dimostrano il loro amore, accudiscono le loro creature, le consolano nel pianto e, d’altra parte, dalla famiglia proviene la prima educazione. Alla luce di tutto ciò risulta evidente come vasta e profonda sia stata l’influenza delle varie strutture familiari nelle società che si sono succedute e l’esistenza della famiglia è all’origine di un’ampia zona della coscienza etico-sociale dell’umanità. Non è quindi casuale che intorno alla famiglia si muovano estese e intense manifestazioni della mente umana, quali la letteratura, il cinema e il teatro. E in effetti il cinema, la letteratura e il teatro da sempre sono specchio, se non addirittura i precursori, dei tempi e della società, e inevitabilmente raccontano identità e trasformazioni.
Parole chiave
Identità familiari, Sindrome degli antenati, Letteratura e famiglia, Genosociogramma, Legami trangenerazionali.
EDUCATIONAL MODELS
The «Ancestors’ Syndrome» by A.A. Schützenberger
Exploring Family Phenomenology through the Magical Realism of Márquez
Santina Carrozza2
Abstract
The family is the primary educational agency in the links of inequality and equal power with a specific and decisive training character, both for the children and for all members. In the Western world, despite various changes that have occurred over time, the family remains of fundamental interest in the social context, as a place for satisfying primary needs and reproducing values to build one’s own identity. It is indisputable that for most human beings the family represents the first caress that welcomes in the world, in the gestures with which parents show their love, care for their creatures, console them in tears, On the other hand, the family is where the first education comes from. In light of all this, it is evident how vast and profound the influence of various family structures in the societies that have succeeded each other has been, and the existence of the family is at the origin of a wide area of the ethical-social consciousness of humanity. It is not by chance that the family is surrounded by extensive and intense manifestations of the human mind, such as literature, cinema and theatre. And indeed the cinema, literature, theatre have always been mirrors, if not even precursors, of times and society, and inevitably tell about identities and transformations.
Keywords
Family identities, Ancestor syndrome, Literature and family, Genosociogram, Trans-generational links.
Premessa
Il luogo intrinseco della cura, il contesto originario in cui le relazioni iniziano ad assumere valore continua, indubitabilmente, a essere la famiglia, non limitata, ovviamente alle sole figure genitoriali, ma che comprende il rapporto con tutti i membri di cui è composta, permettendo al bambino, sin da subito, di sperimentare l’esistenza e il confronto con un mondo altro da sé. La famiglia può, pertanto, essere descritta come un sistema di «relazioni primarie» a cui spetta naturalmente il cosiddetto «primato educativo»: all’interno di essa il bambino acquisisce consapevolezza di una diversità di tipo generativo, in grado di garantirgli un elevato stato di benessere, grazie al quale ha l’opportunità di strutturare efficacemente la propria identità. D’altra parte, la famiglia, interagendo con l’ambiente esterno, tende inevitabilmente a modificare le proprie strutture interne e, viceversa, a influire in maniera significativa sull’ambiente stesso; «pertanto, famiglia e ambiente instaurano un reciproco rapporto di interdipendenza e scambio continuo di materia ed energia. Questa dinamica conferisce alla famiglia un carattere unico, irripetibile, che muta nelle diverse fasi della sua storia» (Cerrocchi e Dozza, 2018).
Osservando l’universo familiare da questa angolazione ci si accorge che esso ha confini molto meno definiti, più sfumati, in cui si innestano nuove esperienze di vita fatte di separazione, unione e ricomposizione. Ciò richiede un’indagine attenta e multiprospettica, che sappia rendere conto della sua complessità, senza tuttavia mai tradire l’intramontabile funzione generativa e trasformativa che la famiglia da sempre porta con sé (Marzullo, 2022). Questa pluralità di forme riflette inevitabilmente i profondi cambiamenti della società contemporanea, dando spazio a strutture familiari eterogenee:
Al di là delle diverse rappresentazioni, ciò che è certo è che la famiglia non è un’entità naturale come alcuni ideologicamente la leggono, ma un’istituzione storico-culturale che si evolve nelle forme e nelle funzioni in rapporto ai mutamenti economici, sociali e culturali, assumendo, come in questi ultimi decenni, una fisionomia plurale — monoparentale, separata, allargata, etero o omosessuale — e una struttura instabile, aperta e permeabile all’esterno, con legami fluidi, orizzontali, più intimi e personali all’interno (Sarsini, 2018).
Dunque, qualunque sia oggi la forma in cui si concretizza la struttura familiare, la responsabilità genitoriale deve comunque essere definita dagli ideali di cura, dal sostegno e dalla considerazione per le attitudini dei figli, dalla presenza e dall’impegno a introdurre in una realtà in cui, oltre all’affermazione individuale, trovino il loro spazio anche la dimensione affettiva ed emozionale, l’apertura all’altro, il rispetto delle regole come strumento di comprensione del reale, l’educazione al bello e alla sua scoperta in ogni ambito dell’espressione umana.
Identità familiari e «sindrome degli antenati»
Il processo di conoscenza di sé, dunque, non può prescindere da una rilettura della propria esperienza relazionale all’interno della famiglia, che per tale ragione si configura come «dispositivo pedagogico originario» (Massa, 1987), inteso come spazio di formazione e progetto educativo in sé (Marzullo, 2022).
Dal punto di vista epistemico tale costrutto, introdotto, tra gli altri, da Bertolini nel 1957 con il suo L’esistere pedagogico, assume il paradigma relazionale che rappresenta la condizione umana nelle sue connotazioni primordiali e imprescindibili: il tempo e i rapporti. L’essere inizia a esistere nel momento in cui prende forma nella relazione col mondo. Questa visione assume come punto prospettico l’esperienza umana, il momento relazionale, ossia l’autentico e concreto luogo di incontro tra il soggetto e il mondo.
La famiglia costituisce, quindi, il punto di partenza — sul e dal quale — si costruiscono e ricostruiscono funzioni, relazioni nonché l’identità dell’individuo (Dozza e Frabboni, 2012). Il compito formativo principale della famiglia è quello dell’educazione all’affettività, componente ineludibile nella costruzione dell’identità personale di ogni essere (Frabboni e Pinto Minerva, 2003).
Com’è noto, il costrutto familiare si struttura in relazioni più elementari, come quelle di coppia, genitore-figlio, tra fratelli, nonni-nipoti, e assume complessità attraverso i diversi legami generazionali e intergenerazionali. Inoltre, «favorisce la contaminazione e/o sintesi delle tradizioni e dei valori sociali e culturali, specialmente nelle famiglie miste per provenienza di classe o appartenenza a gruppi etnici. Questi elementi sono trasmessi alle nuove generazioni» (Cerrocchi e Dozza, 2018).
I vincoli familiari non si limitano al presente o a un passato recente ma si estendono attraverso più generazioni, dando vita a quella che la Schützenberger definisce la «sindrome degli antenati»: uno studio multigenerazionale sulla famiglia che considera sia gli eventi critici nell’asse orizzontale, legati ai compiti di sviluppo attuali della famiglia, sia quelli sull’asse verticale, correlati agli eventi affrontati dagli antenati nelle varie generazioni.
Anne Anceline Schützenberger, terapista e analista francese, analizza il ruolo degli antenati nella trasmissione di traumi psicologici:
Siamo meno liberi di quanto crediamo. Pertanto, possiamo riconquistare la nostra libertà e svincolarci dalla ripetizione capendo ciò che accade, afferrando questi fili nel loro contesto e nella loro complessità. Possiamo così vivere la «nostra» vita, e non quella dei nostri genitori o dei nostri nonni, o di un fratello morto — ad esempio — che noi «rimpiazziamo», consapevolmente o a nostra insaputa (Schützenberger, 1993).
La «sindrome degli antenati», conosciuta anche come «sindrome transgenerazionale» o «Psicogenealogia», si riferisce alla trasmissione inconscia di traumi, segreti, lutti non elaborati e dinamiche familiari disfunzionali dalle generazioni precedenti a quelle successive.
Secondo la Schützenberger eventi significativi e spesso dolorosi vissuti dagli antenati possono influenzare la vita e la salute mentale, i comportamenti e persino le scelte dei discendenti, anche se questi ultimi non ne sono consapevoli o non hanno ricevuto racconti diretti di tali eventi.
Una sorta di lealtà familiare inconscia spinge i membri di una famiglia a ripetere schemi o dinamiche vissute dai loro antenati pur non essendone consapevoli, mentre il «non detto», i segreti familiari, i tabù e le comunicazioni non esplicite generano dei «fantasmi familiari» che possono influenzare i discendenti in maniera sottile ma potente.
A questi si aggiunge il concetto di «Doppio» che spiegherebbe come date di nascita, di morte, o eventi significativi ripetuti a distanza di generazioni diventino sintomatici di tale sindrome.
Lo psichiatra Ivan Boszormenyi-Nagy, fondatore della terapia familiare, a tal proposito introduce il concetto di «giustizia familiare»:
Il più importante «debito» della «lealtà familiare» è quello che ciascun bambino contrae nei confronti dei suoi genitori, per l’amore, l’affetto, le cure, la fatica e le attenzioni che egli riceve dalla nascita fino al momento in cui diviene adulto. Il modo per saldare i propri debiti è transgenerazionale, ossia ciò che abbiamo ricevuto dai nostri genitori lo rendiamo ai nostri figli (Boszormenyi-Nagy e Spark, 1973).
La Schützenberger, però, evidenzia come il trauma trasmesso sia più potente di quello effettivamente subito. A dimostrazione di quanto affermato, l’autrice utilizza il genosociogramma, una sorta di albero genealogico che incorpora gli eventi importanti della vita e il loro contesto emotivo, per comprendere meglio i legami tra le generazioni.
Analizzando il genosociogrammma insieme a un terapeuta, il soggetto si rende conto che il mondo non è iniziato con i suoi genitori, ma che questi ultimi sono il frutto di un mondo che esisteva prima di loro. Quindi bisogna analizzare i rapporti in una prospettiva transgenerazionale, per scoprire le proprie origini e le motivazioni di certi traumi irrisolti. Il genosociogramma è quindi un mezzo di conoscenza di sé, della propria famiglia e delle ripetizioni familiari invisibili (Schützenberger, 1993).
Esso però va interpretato con le dovute cautele Perché soggetto alla sensibilità e all’esperienza del terapeuta che rischia di focalizzarsi in maniera eccessiva su specifici eventi
Anche alcuni tra i più affermati studiosi italiani, tra i quali il noto psicologo e pedagogista Michele Corsi, hanno sottolineato in maniera inequivocabile come la condizione umana sia caratterizzata da un flusso costante che tiene conto delle tre principali dimensioni temporali:
[…] ognuno di noi è un intreccio in costante divenire tra passato, presente e futuro: il passato è un bagaglio del quale a volte avvertiamo la gravezza, o all’interno del quale custodiamo una cassetta degli attrezzi per riparare ai danni del presente; il presente è la dimensione stanziale che attesta il nostro con-sistere, il nostro esistere con l’altro e per mezzo dell’altro, fin dalla venuta, nella «gettatezza»; il futuro è il luogo dell'altrove, della presenza non ancora presente, del bagaglio leggero, o della paura, ímaái del tutto sopita, di un eterno ritorno del passato. Ognuno di noi è «stanziato» e al contempo, «passeggero»: ciascuno, difatti, proviene e, per sentieri impervi, diviene nel provenire. Tra il fardello del passato e il carico del futuro, ognuno di noi permane nonostante le mutate condizioni di vita: «stanzia», per così dire, quale forma-uomo nel divenire delle forme. Il presente, pertanto, è l’essenza del progetto: il progettare prende forma in un tempo presente, il quale, dando forma al progetto, è già, nella sua essenza, futuro (Corsi e Stramaglia, 2009, p. 7).
I legami familiari attraverso lo sguardo di G. García Márquez
Traslando questa disamina su un piano puramente letterario, risulta particolarmente interessante analizzare alcuni passi di uno dei romanzi più iconici del Novecento, Cent’anni di solitudine, la cui traduzione giunse in Italia nel 1968. Un anno storicamente importante, con riferimento a una generazione desiderosa di trovare stimoli per le proprie battaglie anche nel pensiero letterario.
Questa la grandezza del capolavoro del premio Nobel Gabriel García Márquez, quella di offrire una sequenza straordinaria di simbolismi, incastonata in differenti piani di lettura, riuscendo a divenire una sorta di specchio che consente da sempre ai lettori di riconoscersi pur non essendo un romanzo generazionale o politico nella maniera più precisa. Capitolo dopo capitolo trova spazio la storia dei Buendía, famiglia che vive in una cittadina immaginaria della Colombia, Macondo. Un’opera intensa e seducente, che trae forza dalla sublimazione delle radici e dei costumi, spostandosi continuamente tra realtà e leggenda.
Il patriarca, Jose Arcadio Buendía, è fondatore di Macondo. Qui si intrecceranno le storie di sette generazioni, tra innumerevoli personaggi. Ursula Iguarán, moglie di Jose, riuscirà a posare il suo sguardo su quasi su tutti i membri della famiglia. Il mondo proposto da Márquez si estende in un tempo circolare, colmo di possibilità per ricominciare. L’intera famiglia si fa rappresentazione di un messaggio ben chiaro, di un modo di vivere che costringe a tenere conto del passato di ciascuno pur continuando a lottare per il proprio destino.
Uno dei personaggi senza dubbio più emblematici in questa drammatica vicenda è Rebeca, una bambina di non più di undici anni condotta a Macondo da commercianti di pellame per conto d’ignoti, ai quali viene dato l’incarico di affidarla a José Arcadio Buendìa: «Tutto il suo bagaglio era composto dal bauletto della roba, da una poltroncina a dondolo di legno con fiorellini colorati dipinti a mano e da un sacco di tela che faceva un continuo rumore di cloc cloc cloc, dove portava le ossa dei suoi genitori».
Nella lettera è scritto che Rebeca è una cugina lontana di Ursula, figlia di Nicanor Ulloa e Rebeca Montel, sebbene nessuno dei due Buendía si ricordi di avere un qualche parente con quel nome; sempre nella lettera gli viene chiesta la carità di seppellire cristianamente i poveri resti dei genitori della piccola:
Dato che in quel tempo non c’era cimitero a Macondo, perché fino a quel momento non era morto nessuno, in attesa che ci fosse un luogo degno per seppellirle, conservarono il sacco con le ossa; per molto tempo diedero fastidio dappertutto e si intoppavano dove meno si supponeva, sempre con il loro chiocciante chioccolare di gallina covaticcia. Passò molto tempo prima che Rebecca si integrasse alla vita della famiglia. Si sedeva sulla poltroncina a dondolo nell’angolo più appartato della casa, e si succhiava il dito. [...] A Rebeca piaceva soltanto mangiare la terra umida del patio e i calcinacci che staccava dai muri con le unghie. Era evidente che i suoi genitori, o chiunque l’avesse allevata, l’avevano rimproverata per quell’abitudine, perché lo faceva di nascosto e con coscienza di colpa, cercando di conservare le razioni per mangiarle quando nessuno la vedesse.
La bambina, inoltre, porta con sé il contagio della peste dell’insonnia:
La cosa più temibile della malattia dell’insonnia non era l’impossibilità di dormire, dato che il corpo non provava alcuna fatica, bensì la sua inesorabile evoluzione verso una manifestazione più critica: la perdita della memoria. Significava che, quando il malato si abituava al suo stato di veglia, cominciavano a cancellarsi dalla sua memoria i ricordi dell’infanzia, poi il nome e la nozione delle cose, e infine l’identità delle persone e perfino la coscienza del proprio essere, fino a sommergersi in una specie di idiozia senza passato.
Un giorno arriva in paese lo zingaro Melquìades, ripudiato dalla sua tribù per la sua «fedeltà alla vita», e offre da bere a José Arcadio Buendía una pozione che riporta alla luce i suoi ricordi. Melquìades «era stato nella morte, effettivamente, ma era tornato perché non aveva potuto sopportare la solitudine». Anni dopo le parole di Pilar Ternera, un’indovina, cartomante, alla quale Rebeca si rivolge, sveleranno il mistero che avvolge la sua esistenza:
Non sarai mai felice finché i tuoi genitori resteranno insepolti. Rebeca rabbrividì. Come nel ricordo di un sogno vide se stessa entrare in casa, piccola piccola, col baule e la poltroncina a dondolo di legno e un sacco il cui contenuto non aveva mai visto. [...] «Non capisco» disse Rebeca. Pilar Ternera parve sconcertata: «Nemmeno io, ma le carte dicono così». Rebeca si preoccupò così tanto per l’enigma che lo raccontò a Josè Arcadio Buendìa e questi la rimproverò perché credeva alle carte, ma si diede comunque al silenzioso compito di ispezionare armadi e bauli, spostare mobili, girare letti e guardare sotto le assi del pavimento, per trovare il sacco con le ossa. Non ricordava di averlo più visto dai tempi della ristrutturazione. Chiamò in segreto i muratori e uno di loro rivelò di aver murato il sacco in qualche camera perché lo intralciavano nel lavoro. Dopo vari giorni di auscultazioni, con l’orecchio incollato alle pareti, percepirono un cloc cloc profondo. Spaccarono in muro e le ossa erano lì nel sacco intatto. Lo seppellirono il giorno stesso in una tomba senza lapide [...]. Passando dalla cucina le diede un bacio sulla fronte: «Levati le cattive idee dalla testa» le disse. «Sarai felice».
Per la Schützenberger, infatti, «la ripetizione non è una fatalità. Comprendere le dinamiche transgenerazionali, portare alla luce i segreti e i traumi del passato, può permettere di interrompere i cicli di ripetizione e di avviare un processo di riparazione». Dal punto di vista affettivo e relazionale il personaggio di Rebecca si presta a una serie di riflessioni e considerazioni riguardanti la fase adolescenziale e il distacco dalle figure genitoriali, distacco che avrà come conseguenza l’affermazione della propria personalità.
Nel caso specifico questo passaggio è investito da una serie di difficoltà derivanti dal mistero che avvolge le origini della ragazza, ancora impegnata nella ricerca delle proprie radici familiari e affettive. Ciò la costringe a vivere ancora come una bambina piena di fragilità rese simbolicamente all’interno del romanzo con la sua ossessione per il mangiare la terra, la madre terra, e per il succhiarsi il dito come gesto di autoconsolazione infantile. Il personaggio di Rebecca non può non indurre a ulteriori riflessioni che riguardano il non detto familiare: la giovane, a sua insaputa, si trascina dietro il peso — soprattutto simbolico — del sacco contenente le ossa dei suoi genitori che continua a «fare rumore» e a essere d’intralcio non solo per la sua persona, ma anche per quanti la circondano.
Per molto tempo Rebecca continua a soffrire anche se i Buendía cercano come possono di prendersi cura di lei, ma quelle povere ossa continuano a «fare rumore» anche dopo essere state murate all’interno della casa. Oltretutto la giovane porta a Macondo la terribile «peste dell’insonnia», le cui conseguenze più gravi sono la vera e propria perdita della memoria, della propria identità, in ultimo.
Proprio perché Rebecca simbolicamente incarna una sorta di «non detto»: l’impossibilità di strutturare una memoria della propria storia personale, delle proprie radici, a causa di un segreto indicibile. Gli strani comportamenti di cui si rende protagonista segnalano forse l’urgenza di considerare con maggiore attenzione la comunicazione non verbale e l’impatto dell’estrinsecazione emotiva che si manifesta attraverso il linguaggio del corpo o un silenzio a tratti rivelatore.
La «Cripta» e il «fantasma»
Il personaggio di Rebeca di fatto può essere ricondotto al concetto della «cripta» e del «fantasma» dei due psicanalisti freudiani N. Abraham e M. Török. Secondo questi studiosi un comportamento atipico, una particolare espressione psicosomatica, addirittura una malattia o un delirio allucinatorio non sono che la manifestazione dell’esistenza di una circostanza indicibile vissuta in passato dai nostri antenati (Abraham e Török, 1993).
Secondo questa teoria un vissuto oltremodo doloroso, o di cui ci si deve vergognare, troppo ingombrante e difficile per essere affrontato, è destinato alla dimenticanza, all’oblio, come accade per coloro che vengono contagiati dalla «peste dell’insonnia» e dal conseguente «morbo della memoria». Le origini di Rebeca rimangono sconosciute, come sconosciuto per lei è il contenuto del suo sacco.
Nonostante ciò, il corpo di Rebeca dice della sua profonda sofferenza e dell’estremo bisogno di ricongiungersi alle proprie origini, alle proprie radici come un albero con la madre terra. Il corpo di Rebeca, quindi, diventa una sorta di cripta in cui è drammaticamente custodito un segreto, che si aggira nel cuore della giovane come un fantasma rumoroso, come il sacco delle ossa dei suoi genitori che continuano a fare «cloc-cloc» dandole fastidio, essendo un intralcio al divenire della sua esistenza. Questo fantasma così ingombrante non è altro che il frutto di un lutto ineffabile che viene sepolto segretamente all’interno di una «cripta»: il suo cuore.
Riprendendo la teoria della Schützenberger, «questi fantasmi familiari non sono spiriti, ma piuttosto impronte psichiche, cariche emotive non elaborate, che si trasmettono di generazione in generazione». Anche la solitudine di cui parla Márquez è una «condizione mentale» che i discendenti di José ereditano e a loro volta si tramandano attraverso le generazioni: è una specie di «introversione psicologica», che passa di padre in figlio, come una sorta di risolutezza irrequieta, indirizzata, però, a imprese senza speranza di un futuro.
Lo scrittore associa il concetto di solitudine all’incapacità dell’uomo di amare e di offrirsi agli altri e tale condizione lo affianca per l’intera sua vita. Un sentimento da cui non ci si riesce a liberare e, dunque, con cui è necessario confrontarsi lealmente. Portare alla luce e comprendere le dinamiche transgenerazionali diventa, in ultima analisi, fondamentale per liberarsi dalle ripetizioni inconsce dei fardelli del passato familiare, permettendo all’individuo di vivere la propria vita in modo più autonomo e consapevole.
È urgente, dunque, considerare approcci innovativi all’educazione familiare, che vadano oltre le fallimentari conferenze tipiche delle scuole per genitori degli anni Sessanta. La natura sfuggente e «fluida» delle relazioni vissute nella contemporaneità accresce il bisogno di riconoscere la famiglia come porto sicuro da cui poter ripartire. Dunque la Schützenberger ci invita a considerare la nostra storia familiare come una trama complessa di legami e influenze che vanno al di là della nostra esperienza individuale, e a riconoscere come il passato, se non affrontato e profondamente compreso, possa continuare a plasmare il nostro presente poiché, riprendendo il pensiero di Jung, «Ciò che non è venuto alla luce come coscienza ritorna come destino».
Bibliografia
Abraham N. e Torok M. (1993), La scorza e il nocciolo, a cura di L. Russo e P. Cupelloni. Trad. it. a cura di F. Ortu, Roma, Borla.
Bertolini P. (1988), L’esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata, Firenze, La Nuova Italia.
Boszormenyi-Nagy I. e Spark G.M. (1988), Lealtà invisibili. La reciprocità nella terapia familiare intergenerazionale, Roma, Astrolabio Ubaldini.
Cerrocchi L. e Dozza L. (a cura di) (2018), Contesti educativi per il sociale. Progettualità, professioni e setting per le età della vita, Milano, FrancoAngeli.
Corsi M. e Stramaglia M. (2009), Dentro la famiglia. Pedagogia delle relazioni educative familiari, Roma, Armando.
Dozza L. e Frabboni F. (a cura di) (2012), Lo sguardo dei nonni. Ritratti generazionali, Milano, FrancoAngeli.
Frabboni F. e Pinto Minerva F. (2003), Introduzione alla pedagogia generale, Roma-Bari, Laterza.
Márquez G.G. (1967), Cien años de soledad, Buenos Aires, Editorial Sudamericana. Trad. it., Cent’anni di solitudine, a cura di E. Cicogna, Milano, Mondadori, 1996.
Marzullo R. (2022), Abissi e disarmonie. Analisi pedagogica delle relazioni disfunzionali, Milano, FrancoAngeli.
Massa R. (1987), Educare o istruire? La fine della pedagogia nella cultura contemporanea, Milano, Unicopli.
Sarsini D. (2018), La pedagogia generale e le sue frontiere. In Pedagogia generale. Identità, percorsi, funzione, Roma, Carocci.
Schützenberger A.A. (1993), Aïe, mes aïeux!, Paris, Desclée de Brouwer. Trad. it., La sindrome degli antenati. Psicoterapia transgenerazionale e i legami nascosti nell’albero genealogico, Roma, Di Renzo Editore, 2004.
Vol. 11, Issue 2, October 2025