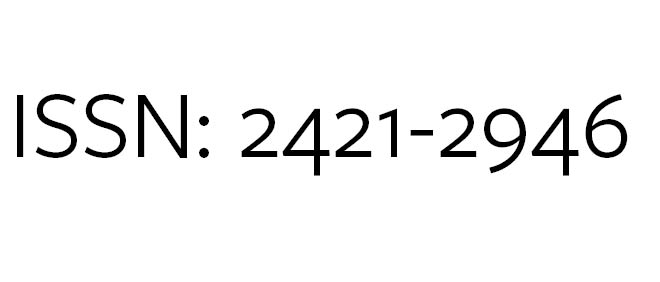Vol. 11, n. 2, ottobre 2025
Modelli di organizzazione scolastica
Copioni organizzativi e leadership educativa
La prospettiva dell’Analisi Transazionale
Andrea Bobbio1
Sommario
L’articolo tratta le possibili applicazioni dell’Analisi Transazionale (AT) — e della sua declinazione all’interno dei «campi speciali», extraclinici — nell’ambito dell’analisi organizzativa nei contesti scolastici, con particolare riferimento alla funzione del dirigente scolastico quale attore di trasformazione profonda e di cambiamento dei paradigmi che orientano le prassi e il «clima morale» dell’istituzione. A partire dal concetto di «copione organizzativo» si analizzeranno i fenomeni di resistenza al cambiamento tipici dei contesti collegiali del mondo della scuola prospettando specifiche categorie ermeneutiche utili a comprendere i meccanismi di difesa e le dinamiche che contrassegnano il funzionamento dei gruppi. I quattro copioni identificati mirano a ricomprendere i comportamenti base delle organizzazioni mettendoli in relazione con la valorizzazione, strategica o meno, delle risorse, del tempo e delle competenze umane a disposizione dell’istituzione. Tale compito, in particolare, investe il dirigente il quale è chiamato a coniugare, attraverso la sua leadership educativa, istanze di natura differente: bisogno di stabilità e di cambiamento; bisogni individuali e collettivi; istanze creative e di regolazione. L’analisi proposta, oltre a valorizzare le ricerche elaborate nel contesto AT, si ricollega agli studi proposti nel contesto statunitense da Sergiovanni e, in Italia, da Scurati.
Parole chiave
Dirigente scolastico, Leadership, Copione organizzativo, Pedagogia delle organizzazioni, Pedagogia della scuola.
MODELS OF SCHOOL ORGANIZATION
Organizational Scripts and Educational Leadership
The Transactional Analysis Perspective
Andrea Bobbio2
Abstract
The article deals with the possible applications of Transactional Analysis — and its declination within the extra-clinical «special fields» — in the sphere of organisational analysis in school contexts with particular reference to the function of the school manager as an actor of profound transformation and change of the paradigms that orient the practices and the «moral climate» of the institution. Starting from the concept of «organisational script», the phenomena of resistance to change typical of the collegiate contexts of the school world will be analysed, proposing specific hermeneutic categories useful for understanding the defence mechanisms and dynamics that mark the functioning of groups. The four scripts identified aim to encompass the basic behaviours of organisations by relating them to the valorisation, strategic or otherwise, of the resources, time and human skills available to the institution. This task, in particular, concerns the school manager who is called upon to combine, through his or her educational leadership, instances of a different nature: the need for stability and change; individual and collective needs; creative instances and others of regulation. The proposed analysis, in addition to valorising the research elaborated in the A.T. context, is linked to the studies proposed in the American context by Sergiovanni and, in Italy, by Scurati.
Keywords
Head teacher, Leadership, Organisational script, Organisation pedagogy, School pedagogy.
Introduzione
Come rileva Gianbattista Bufalino, le ricerche sul contesto «educazionale» inteso quale spazio di «servizio» rispetto a quello educativo sono ancora poco diffuse, per lo meno in Italia:
L’impegno verso l’elaborazione di una specifica teoria sulla leadership nel contesto scolastico e, quindi, l’affermazione autonoma di questo campo di studi non si è concretizzato in filoni di ricerca consolidati o sistematici, configurando un «ritardo» del dibattito italiano rispetto ai tradizionali discorsi sulla leadership educativa. Difatti, nonostante il recente e crescente interesse, i pochi contributi di area pedagogica faticano a declinare piste di ricerca continue e sistematiche, mentre il caso italiano appare quasi del tutto assente dal dibattito pedagogico internazionale nel campo dell’educational leadership (Bush, 2014). Di contro, la riflessione italiana sulla leadership educativa è ben rappresentata — solo per citarne alcuni — dai lavori dei sociologi Roberto Serpieri e Emiliano Grimaldi, o dalle ricerche di area manageriale ed economica di Tommaso Agasisti (Politecnico di Milano) o di Angelo Paletta (Università di Bologna) — quest’ultimo uno degli ispiratori dell’integrazione degli approcci di school effectiveness e performance management, attraverso i modelli della leadership per l’apprendimento (per esempio, Paletta, 2015) — o, ancora, in ambito professionale, dai contributi del compianto ispettore Cerini (Bufalino, 2021, p. 84).
A seguito di tale latenza di carattere euristico, l’esigenza di uno studio pedagogico circa la caratterizzazione educativa della dirigenza scolastica è sempre più avvertito, soprattutto a seguito delle complessità crescenti cui deve farsi carico la scuola oggi, compressa tra i suoi mandati istituzionali (alfabetizzazione culturale, istruzione) ed esigenze sociali di altra natura (intercultura, coesione sociale, sviluppo delle soft skills, integrazione tra cognitivo/non cognitivo, educazione permanente) (Castoldi e Chiosso, 2021; Nosari e Guarcello, 2024).
A tali condizioni di difficoltà si assommano poi problematiche intrinseche all’organizzazione stessa, connesse alla sua specificità istituzionale: la scuola non è un’impresa economica, come mostrano i concetti di management scolastico specifici quali structural looseness (rilassatezza strutturale), loosey coupled system (sistema a legami lenti) e contingency management (management delle contingenze) e ciò comporta l’adozione di paradigmi e di euristiche particolari, che non siano meri adattamenti di schemi o algoritmi aziendalistici (Scurati, 1996, 2000).
All’interno di un tale quadro di peculiarità concettuale, infine, si situa la necessità di un’adeguata teorizzazione della nozione di leadership educativa in relazione all’esercizio della funzione dirigenziale.
Segnatamente, come rileva Scurati, essa significa esercizio di «un ruolo fondamentale nel rivestire i processi di professionalizzazione dei docenti di significati umani e di possibilità di valorizzazione degli insegnanti» (Scurati, 1982, p. 4); è «azione formativa» (Scurati, 2002, p. 4), direzione pedagogica. Da qui la considerazione che
non [sia] pensabile per la leadership educativa un fondamento burocratico, carismatico o produttivistico; comunità educativa richiama e richiede una leadership educativa; esiste un rapporto genetico tra la comunità educativa e la direzione scolastica come azione formativa. Pertanto, le concezioni tecniche e manageriali devono essere sempre subordinate ai bisogni umani e le azioni devono essere sempre al servizio di scopi umani (Sergiovanni, 1987, p. 127; Falanga, 2021, p. 157).
Uno dei temi principali sui quali si concentra l’attuale discussione sulla leadership educativa attiene al governo delle dinamiche connesse al rinnovamento dell’«istituzione scuola» a fronte delle trasformazioni indotte tanto dal rinnovamento della normativa quanto dalla società nel suo complesso. In tali frangenti, il dirigente, per orientare il cambiamento in termini produttivi, avverte l’urgenza di acquisire competenze plurime rispetto a specifiche pratiche di pianificazione e di gestione dell’ecosistema formativo che gli è stato affidato.
Tra di esse: la diagnosi organizzativa, la capacità di condurre i gruppi, l’attitudine alla facilitazione comunicativa, tutte abilità che possono essere inscritte in un’ottica di vera e propria «clinica della formazione» (Riva, 2004; Palma, 2017). A tale proposito l’Analisi Transazionale (AT) ha elaborato talune tecniche (riflessive e terapeutiche) che possono essere utilizzate dal dirigente e dal middle management della scuola in chiave tanto formativa quanto diagnostica e trasformativa.
Leadership e diagnosi organizzativa
Spesso le organizzazioni, comprese quello scolastiche (Scurati, 2003; Bobbio, 2008), presentano caratteristiche ricorrenti, persistenti nel tempo, che le qualificano permanentemente come ambiti di crescita effervescenti, stimolanti e produttivi (Scurati e Bobbio, 2008). Altre volte, invece, le immagini associate a tali istituzioni sono di segno opposto e sono contrassegnate, nei vissuti collettivi, da sentimenti negativi che le dipingono come ambienti stagnanti, luoghi in cui l’innovazione stenta ad affermarsi e in cui i potenziali individuali non trovano adeguato riconoscimento istituzionale.
In altri frangenti ancora, l’impasse evolutiva sembra localizzarsi in una traiettoria di crescita istituzionalmente disorganizzata, in cui il rinnovamento e la regressione si succedono schizofrenicamente senza approdare a consolidate imago gruppali fonti di stabili e positive identificazioni collettive. All’interno di tali situazioni — che condizionano il benessere organizzativo della scuola intesa come istituzione collettiva e che influenzano la sua efficacia in termini educativi — il dirigente scolastico è chiamato a operare agendo una leadership che è tanto più facilitante o confusiva (e quindi, alla lunga, potenzialmente efficace o controproducente) quanto più intercetta in profondità il copione delle organizzazioni e mira a modificarlo intenzionalmente.3
Quest’ultimo costrutto collettivo — il copione — come quello di natura individuale, teorizzato originariamente da Eric Berne (1966) e poi perfezionato dai suoi successori, è un piano di vita inconscio basato su decisioni prese a un qualunque stadio dello sviluppo, che inibiscono la spontaneità e limitano la flessibilità nel risolvere problemi e nel relazionarsi agli altri (Erskine, 1980). Per l’istituzione il copione è un momento necessario di identificazione, significa «esserci» in adattamento a un ambiente e a un gruppo sociale (Dagostino, 1991). Il copione condiziona diacronicamente gli atteggiamenti dei gruppi, il loro modo di gestire le relazioni intersoggettive e gerarchiche (quindi la comunicazione e i «giochi» psicologici interni), il modo di disporre delle risorse dell’organizzazione e di strutturare il tempo in vista degli obiettivi statutariamente previsti dalla mission dell’istituzione stessa.
Un contratto di liberazione dal copione rappresenta il tentativo di raggiungere una nuova scelta identificatoria, più idonea e adeguata, che aggiunge altre opzioni trasformative lungo le linee di forza già presenti nell’impresa. Una tale scelta, emancipatoria, decostruttiva, difficilmente è l’esito di un processo spontaneo, pianificato dall’organizzazione stessa in base a una spinta «dal basso». Il più delle volte è invece la risultante di un evento traumatico (incidenti, dimissioni improvvise, tensioni ingestibili, boicottaggi), successivamente rielaborato collettivamente, oppure l’esito di un cambio di leadership (o di una crescita qualitativa di quella presente), fattore che porta l’irruzione di una nuova cultura organizzativa4 all’interno dell’istituzione e quindi produce un «accomodamento di paradigma», per dirla con Piaget (Gattico, 2001, pp. 2-3).
La ristrutturazione di un ciclo formativo, l’adozione di nuove indicazioni didattiche, l’irrompere di diverse modalità di gestione del lavoro e della didattica possono essere altrettanti eventi destabilizzanti che possono stressare i copioni delle organizzazioni ponendoli di fronte a scenari nuovi da essi non previsti. Tali eventi, se ben governati da un’adeguata leadership e accompagnati da idonee politiche gestionali, possono essere fattori forieri di adattamenti positivi e di modificazioni profonde in seno alla cultura organizzativa delle scuole o dell’istituto generando nuovo benessere, tanto nel personale quanto negli alunni e nelle famiglie (Scurati et al., 1995, 1996). Non sempre, tuttavia, le risorse per promuovere e incanalare questo livello di innovazione sono a disposizione del dirigente; occorre, pertanto, segnalare strumenti specifici, di ausilio alla leadership, che possono aiutarlo a diagnosticare correttamente talune disfunzioni e profilare le corrispondenti linee di intervento (Cannavale e Castagna, 2018). L’Analisi Transazionale, a tal proposito, ha approntato dispositivi specifici, tanto sul più generale piano della didattica (Amenta, 1999, 2020) quanto su quello della consulenza, della formazione e del coaching.
La tabella 1, in particolare, correla le linee d’intervento con i principali concetti AT di riferimento (De Ambrogio e Santarelli, 2020, p. 3).
Tabella 1
Linee di intervento e costrutti AT
|
Linee di intervento |
Consulenza |
Formazione |
Coaching |
Concetti AT di riferimento |
|
X |
Culture organizzative Copioni organizzativi |
||
|
X |
X |
X |
Teoria dei ruoli Copioni organizzativi |
|
X |
X |
Contratti triangolari Distanza psicologica Transazioni, giochi, carezze |
|
|
X |
Transazioni Carezze Giochi Spinte e fattori di successo |
||
|
X |
Tecniche berniane |
||
|
X |
OKness Confini interni OKness tridimensionale |
||
|
X |
OKness OKness tridimensionale Contaminazioni |
||
|
X |
Contratti, distanza psicologica, posizioni di vita, fattori di successo |
||
|
X |
X |
X |
Contratti 3P OKness OKness tridimensionale |
|
X |
X |
Contratti Leadership negoziale 3P Confini esterni |
|
|
X |
X |
X |
Contratti OKness tridimensionale |
|
X |
X |
Contratti, posizioni di vita, spinte e fattori di successo |
|
|
X |
X |
X |
Svalutazioni, fattori di successo |
|
X |
Copioni organizzativi Culture organizzative Carezze, giochi |
L’insieme degli ambiti di intervento proposti si dispiega dal piano individuale e di coaching a quello formativo e consulenziale (Bobbio e Procopio, 2022), abbracciando tanto il campo supervisivo (Olivieri, 2024; Belardi e Wallnöfer, 2007) quanto quello della più generale progettualità dell’istituzione.
In particolare, si tratta di evidenziare come l’investimento in questi ambiti concorra, di solito nel medio-lungo termine, a migliorare le prestazioni dell’intero sistema educativo con ripercussioni positive sul clima relazionale e sull’ atmosfera morale scolastica. Ad esempio, come rileva Elisa Zobbi,
in uno studio empirico condotto in Indonesia, su un campione di 618 insegnanti, emerge come con relazioni positive si faccia riferimento al grado di condivisione di pratiche, di disponibilità al supporto dimostrata e ricevuta e di consenso in merito a obiettivi comuni e mission scolastica. La collegialità, rappresentando un fattore che contribuisce al miglioramento dell’AMS, rintraccia, nuovamente, nella leadership dirigenziale un ruolo determinante nell’influenzare dinamiche promotrici di benessere collettivo. Tale processo, che avviene incoraggiando la collaborazione e la distribuzione di ruoli e responsabilità, permette la costruzione di fiducia e il coinvolgimento attivo dell’équipe. Ciò promuove negli insegnanti non solo una maggior motivazione, ma anche la percezione di essere abili nel fornire e ottenere supporto e competenti nell’affrontare situazioni sfidanti. Anche i beginner teacher risultano favorevolmente influenzati da climi scolastici positivi (Zobbi, 2021, p. 252).
Tale dinamica virtuosa alimenta processi di rinnovamento tanto delle pratiche didattiche quanto dei rapporti tra singoli e gruppi di lavoro rigenerando i legami tra i diversi sottosistemi operativi agenti all’interno dell’organizzazione. Tale processo, nella prospettiva AT, avviene sulla base di autorizzazioni e permessi —provenienti dalla leadership interna o da un formatore esterno (counselor) — che agiscono come messaggi di sblocco delle impasse comunicative e come fonti di neutralizzazione di spinte e ingiunzioni, cioè di messaggi bloccanti e disfunzionali provenienti dal livello latente dell’organizzazione stessa (De Ambrogio, Dondi e Santarelli, 2017). Gli esiti di tali interventi trovano un loro effetto tanto a livello individuale quanto sul piano collettivo; tra gli epifenomeni più evidenti di tale miglioramento, con Maslow, possiamo individuare:
[...] percezione della realtà più chiara ed efficace; maggiore disponibilità all’esperienza; accresciuta integrazione, globalità e unitarietà della persona; maggiore spontaneità ed espressività; funzionamento completo; vivacità; un sé reale; un’identità personale salda; autonomia; singolarità; maggiore obiettività, distacco e trascendenza rispetto al sé; recupero della creatività; capacità di fondere concretezza e astrattezza; struttura democratica di carattere (1971, pp. 158-159).
Persone e organizzazioni
L’Analisi Transazionale applicata alle organizzazioni individua, per lo più, strategie per equilibrare i diritti degli individui e i bisogni dell’organizzazione con la consapevolezza che un sistema complesso, gestito democraticamente, si presenta come un «sistema di incoerenze» in cui il punto di bilanciamento tra posizioni antinomiche si presenta sempre come provvisorio o non definitivo (Romei, 1994). A tal proposito, le aree di criticità segnalate da Julie Hay possono essere ricomprese in 4 dimensioni:
- Le Strategie, che comprendono, ad esempio, una visione chiara del futuro desiderato, tradotta in una mission che ha un numero limitato di principi chiave, è scritta in un linguaggio comprensibile a tutti ed è stata sviluppata per raggiungere degli obiettivi attraverso un processo che include il maggior numero possibile di persone.
- Le Strutture, che devono essere progettate affinché le persone possano dimostrare spirito d’iniziativa e prendere decisioni che aiutino l’organizzazione a rendere efficaci le proprie strategie. Può accadere che una struttura organizzativa non si accordi con le strategie; può succedere quando viene stabilita una nuova direzione strategica ma rimane intatta la vecchia struttura organizzativa. Ad esempio, la mission di un’organizzazione può essere sviluppata in modo da comprendere un’innovazione, però con una struttura strettamente gerarchica. Quando tutti i livelli hanno considerato una nuova idea, questa non è più innovativa perché un concorrente l’ha perfezionata prima.
- I Sistemi, che devono essere progettati in modo da rinforzare sia la strategia sia la struttura. Inoltre, i sistemi spesso non vengono toccati quando sono attuati altri cambiamenti. Una multinazionale, ad esempio, ha cambiato la propria struttura in modo da conferire un potere maggiore alle persone, ma è rimasto operativo un sistema che autorizza solo manager di un certo livello a prendere decisioni definitive riguardo alle spese. Così, i dipendenti assunti da poco hanno più responsabilità, ma non viene loro conferito un livello di autorità corrispondente.
- La Sicurezza, che in questa metafora indica la sicurezza emotiva. I dipendenti si sentono liberi di essere chiari ed espliciti riguardo alle loro preoccupazioni? Credono che l’organizzazione sia onesta con loro? La sicurezza emotiva non implica la sicurezza del lavoro, ma crea un’atmosfera in cui queste problematiche possono essere discusse apertamente (2010, p. 41).
Le richiamate 4 aree di cui si compongono le organizzazioni sono implicate nella definizione dei copioni elencati nella tabella 2. Da essa si desume come, nella relazione tra le specifiche forme dell’organizzazione, gli stili di management, i fini dell’istituzione e i rapporti tra i diversi piani della community (etico, cognitivo, affettivo e sociale), si giochi un sottile equilibrio che consente, a ogni contesto, di essere un ambiente formativo efficace oppure un luogo di relazione patogeno e alienante. In particolare, è possibile stabilire una relazione tra il copione organizzativo di un’istituzione e gli aspetti strutturali che la compongono. Ne emerge come tra il copione vincente (che comporta il conseguimento dell’obiettivo dichiarato) e il copione perdente (che comporta il fallimento della mission) si conchiudano gli esiti più banali dei copioni non perdente e non vincente, entrambi sfumature di una struttura inadeguata e inefficiente, ove la mera sopravvivenza degli operatori e dei loro «benefici secondari» è il fine implicito dell’organizzazione.
Tabella 2
I copioni organizzativi
|
COPIONI ORGANIZZATIVI |
||||
|
ASPETTI |
VINCENTE |
NON PERDENTE |
NON VINCENTE |
PERDENTE |
|
Linea di vita |
Riuscita Sviluppo Rispetto |
Instabilità Debolezza Alti e bassi |
Sopravvivenza Mediocrità Fare pietà |
Fallimento Declino Rifiuto |
|
Stile di management |
Democratico Partecipativo |
Autocratico Paternalista |
Ambiguo Incostante |
Qualunque (laisser faire) Alienato |
|
Risultati |
Forte produttività Alta qualità Costi poco elevati |
Media produttività Qualità fluttuante Costi medi |
Produttività e qualità medio- bassa Costi medio-alti |
Produttività bassa Qualità bassa Costi elevati |
|
Clima organizzativo |
Salute Motivazione Creatività Rispetto Partecipazione |
Stress Motivazione occasionale Competizione Manipolazione |
Angoscia Insicurezza Confusione |
Apatia Passività Mancanza di comfort Tossicità |
|
Struttura organizzativa |
Piana Flessibile Contano le persone, non le posizioni occupate |
Piramidale Rigida Formale Contano solo le posizioni occupate |
Non chiara, in costante cambiamento Le persone e/o le posizioni contano solo occasionalmente |
Non definita Non sembrano contare né le persone, né le posizioni |
|
Presa di decisioni |
Condivisa |
Centralizzata al vertice |
Ingiustamente ripartita |
Anarchica |
|
Soluzione di problemi |
Iniziativa attiva Per consenso |
Attiva Unilaterale Individuale |
Per reazione Qualche volta in gruppo, qualche volta individuale |
Mancanza di reazione Non c’è soluzione ai problemi |
|
Relazione tra gruppi |
Partnership Collaborazione |
Competizione |
Accomodamenti |
Evitamento Mutuo rifiuto |
Tratta da Bobbio, 2005, pp. 256-257.
Un altro evidente indicatore relativo al funzionamento del copione organizzativo è rappresentato dalla gestione del tempo.
A tal proposito, è ben noto che la costruzione dell’orario di funzionamento delle classi costituisce un banco di prova anche dei rapporti di forza e delle gerarchie all’interno del gruppo docente. Esistono contesti dove il tempo è considerato una risorsa, è utilizzato in modo flessibile e sempre ben ponderato rispetto agli obiettivi dell’organizzazione (ma venendo incontro ai bisogni degli operatori). In altri, invece, è concepito come un bene da dissipare o come uno strumento attraverso il quale esercitare un controllo paranoide da parte dell’organizzazione (spesso dalle figure apicali) sui propri membri: si corre o si rallenta troppo, in tutti i modi i ritardi (negli acquisti, nel disbrigo delle pratiche burocratiche, nella risposta alle istanze degli studenti e dei genitori) concorrono ad abbassare la qualità dell’offerta formativa tanto sul piano della didattica quanto su quello dell’erogazione dei servizi di segreteria e amministrazione.
Conclusioni
La professionalità del dirigente scolastico, lungi da essere una qualità di natura meramente tecnica-aziendalistica, presenta riverberi evidenti sul piano della pedagogia del lavoro e delle organizzazioni (Bocca, 1999; Rossi, 2008).
La leadership agita dai dirigenti scolastici spazia all’interno di un ampio spettro di repertori sotto l’influenza di fattori contingenti che mettono in gioco continuamente e stressano differentemente il bagaglio personale di ogni singolo leader: empatia, carisma, visione, disponibilità, umiltà, etica, responsabilità, doti comunicative, team working, problem solving orientamento ai risultati (Maviglia e Bertocchi, 2022).
Il piano dei valori, in particolare, interagisce con i modelli di leadership i quali, a loro volta, devono fare i conti con le pregresse culture organizzative. Queste ultime costituiscono per il dirigente un terreno di decostruzione e di negoziazione continua in cui va evitato tanto il conflitto infruttuoso e permanente quanto l’immobilità, dovuta alle resistenze strutturali e alla ritrosia al cambiamento. L’obiettivo di una leadership efficace è infatti duplice e riconducibile alle funzioni di bonding e di bridging:
Il leader rinforza i legami interni dell’organizzazione per determinare l’identità del progetto formativo, per creare «valore aggiunto» e rinforzare le motivazioni dei collaboratori e degli utenti uscendo dal concetto burocratico di «partecipazione» e, contemporaneamente, legge i bisogni del contesto per organizzare la risposta della scuola ed esportare il miglioramento sistematizzando e diffondendo le pratiche di successo, che costituiscono un indicatore forte della capacità della scuola di generare cultura a partire dalla pratica quotidiana (Ribolzi, 2020, p. 109).
Nello stesso tempo, all’interno di una leadership efficace, si compenetrano tanto i codici paterni quanto quelli materni offrendo al contempo, al singolo e all’organizzazione, struttura (ovvero legge, impalcatura genitoriale) e autorizzazioni (a essere se stessi, a provare situazioni nuove, a crescere, a essere creativi) (Fornari, 1976; Recalcati, 2024).
D’altra parte, la funzione del dirigente è anche quella di prospettare una vision complessiva che, dal momento diagnostico, approdi a un coerente disegno progettuale. Ciò implica che anche la supervisione e la formazione permanente convergano in un processo di crescita continua che si dispiega secondo un piano armonico che raccorda tanto lo sviluppo dell’organizzazione quanto quello personale. In particolare, il piano di formazione dell’istituzione scolastica
non è da ridurre a uno schematico processo di aggiornamento professionale, anch’esso ricorrentemente e staticamente definito, ma è da considerare come un processo informativo che, mentre consente il continuo aggiornamento professionale, rispetto alle correnti necessità dell’impresa, fornisca le stimolazioni al destinatario (persona o impresa) poiché possa autonomamente interpretare i processi di innovazione, non soltanto adeguandosi ad essi, ma anche promuovendoli direttamente, sapendoli guidare e assorbire continuamente come componente stabile ed efficace delle strategie dell’impresa (Giuli, 1999, p. 257).
Ne consegue che il dirigente scolastico è un agente di riequilibratore di dinamiche contrastanti: è chiamato a bonificare la comunicazione intra e inter-istituzionale, evidenziare le incoerenze tra sistemi interagenti a livelli di complessità diversi, stimolare patti e alleanze tra stakeholder portatori di istanze complesse (Pati, 2019), promuovere processi di innovazione territoriale coniugando una prospettiva micropedagogica (Demetrio, 2020) con una coscienza più globale ed estesa dei fenomeni in gioco. In questo senso,
la ricerca educativa per la dirigenza scolastica deve considerarsi necessaria; è perciò importante seguire la ricerca scientifica nelle sue diverse articolazioni, tenersi informati sui suoi esiti e sulle sue ricadute nel concreto della progettazione didattica, stimolare i docenti all’utilizzo dei risultati della ricerca stessa, interagire con i ricercatori, stimolare la ricerca a scuola per esempio organizzando progetti-pilota, visitare scuole che hanno di già applicato i risultati della ricerca d’interesse (Falanga, 2021, p. 154).
Insomma, occorre recuperare quella vis sapienziale che connotava il direttore didattico vecchio stampo declinando tale competenza in una prospettiva nuova: in tal senso il dirigente è chiamato a essere un vero attore pedagogico capace di farsi aiutare nella gestione della sua leadership e di tenere conto, nell’atto del decidere e del progettare, della pluralità delle variabili in campo attraverso uno sguardo umanistico tanto sulla scuola quanto sulla società.
Bibliografia
Amenta G. (1999), Il counseling in educazione, Brescia, La Scuola.
Amenta G. (2020), Gestire il disagio a scuola, Brescia, Scholè.
Belardi N. e Wallnöfer G. (2007), La supervisione nelle professioni educative, Trento, Erickson.
Berne E. (1966), Principles of group treatment, Oxford, Oxford University Press. Trad. it., Principi di terapia di gruppo, Roma, Astrolabio, 1972.
Bobbio A. (2005), Bambini culture persona. Analisi di pedagogia dell’infanzia, Brescia, La Scuola.
Bobbio A. (2008), Lineamenti di pedagogia della scuola. Problemi. Dimensioni e prospettive, Milano, Vita e Pensiero.
Bobbio A. e Procopio R. (2022), Il counseling educativo. Teorie. Strumenti. Dimensioni, Milano, San Paolo.
Bobbio A. e Scurati C. (a cura di) (2008), Ricerca pedagogica e innovazione educativa. Strutture, Linguaggi, Esperienze, Roma, Armando.
Bocca G. (1999), La produzione umana. Studi per un’antropologia del lavoro, Brescia, La Scuola.
Bufalino G. (2021), Cesare Scurati. Lo sguardo sull’educazione. In P. Calidoni, D. Felini e A. Bobbio (a cura di), Cesare Scurati. Sguardi sull’educazione, Milano, FrancoAngeli, pp. 82-94.
Calidoni P., Falanga M., Fiorin I. e Scurati C. (1995), La funzione dirigente nella scuola primaria, Brescia, La Scuola.
Cannavale D. e Castagna M. (2018), L’analisi transazionale organizzativa, Milano, FrancoAngeli.
Castoldi M. e Chiosso G. (2021), Quale futuro per l’istruzione? Pedagogia e didattica per la scuola, Milano, Mondadori Libri.
D’Agostino L. (1991), Cultura d’azienda e leadership: una lettura secondo l’A.T. In Atti del Convegno Nazionale di Analisi Transazionale, Venezia, 12-14 aprile 1991. https://digilander.libero.it/liziadagostino/P%2004%20Cultura%20d%27azienda%20e%20leadership%20-%20una%20lettura%20secondo%20l%27A.T..rtf (consultato il 3 ottobre 2025).
De Ambrogio U., Dondi A. e Santarelli G. (a cura di) (2017), Analisi transazionale e cambiamento nelle organizzazioni, Milano, Prospettive Sociali e Sanitarie.
De Ambrogio U. e Santarelli G. (2020), Organizzazioni agili e analisi transazionale, Milano, Eureka.
Demetrio D. (2020), Micropedagogia. La ricerca qualitativa in educazione, Milano, Raffaello Cortina.
Erskine R. (1980), Script cure: Behavioural, intrapsychic and physiological, «Transactional Analysis Journal», vol. 10, n. 2, pp. 102-106.
Falanga M. (2021), Comunità formative e dirigenza pedagogica. In P. Calidoni, D. Felini e A. Bobbio (a cura di), Cesare Scurati. Sguardi sull’educazione, Milano, FrancoAngeli, pp. 145-162.
Fornari F. (1976), Simbolo e il codice. Dal processo psicoanalitico all’analisi istituzionale, Milano, Feltrinelli.
Gattico A. (2001), Jean Piaget, Milano, Mondadori.
Giuli (1999), Scenario di riferimento per un piano di sviluppo regionale della formazione continua. In F. Cambi e M. Contini (a cura di), Investire in creatività. La formazione professionale nel presente e nel futuro, Roma, Carocci.
Hay J. (2010), L’analisi transazionale nelle organizzazioni: idee e opinioni, «Quaderni di Psicologia», vol. 54, pp. 26-43.
Katz D. e Kahn R.L. (1966), The social psychology of organizations, New York, Wiley.
Maslow H. (1962), Towards a psychology of being, Princeton, D. Van Nostrand Company. Trad. it., Verso una psicologia dell’essere, Roma, Astrolabio, 1971.
Maviglia M. e Bertocchi L. (2022), Burocrate, manager, factotum. Le maschere del dirigente scolastico, Roma, Armando.
Nosari S. e Guarcello E. (2024), Quali skills per l’umano, Milano, Mondadori Libri.
Olivieri F. (2024), La supervisione pedagogica. Un modello di intervento, Roma, Carocci.
Palma (2017), Consulenza pedagogica e clinica della formazione, Milano, FrancoAngeli.
Pati L. (2019), Scuola e famiglia. Relazione e corresponsabilità educativa, Brescia, Scholé.
Recalcati M. (2024), Il vuoto e il fuoco. Per una clinica psicoanalitica delle organizzazioni, Milano, Feltrinelli.
Ribolzi L. (2020), Crescere nella società. Lineamenti di sociologia dell’educazione, Milano, Mondadori Libri.
Riva M.G. (2004), Studio «clinico» sulla formazione, Milano, FrancoAngeli.
Romei P. (1994), Attori e organizzazione: il caso scuola, «Dirigenti Scuola», vol. 3, n. 3, pp. 36-43.
Rossi B. (2008), Pedagogia delle organizzazioni. Il lavoro come formazione, Milano, Guerini e Associati.
Schein E.H. (1984), Verso una nuova consapevolezza della cultura organizzativa. In P. Gagliardi (a cura di), Le imprese come cultura, Torino, Isedi, 1986.
Scurati C. (1982), Professionalizzazione: Ancora, «Direzione e Scuola», vol. 2, n. 3, pp. 3-4.
Scurati C. (1996), Il dirigente. In C. Scurati (a cura di), Volti dell’educazione, Brescia, La Scuola, pp. 227-262.
Scurati C. (2000), La leadership educativa nella scuola: ipotesi e discussioni. In F. Susi (a cura di), Il leader educativo. Le logiche dell’autonomia e l’apporto del dirigente scolastico, Roma, Armando, pp. 155-182.
Scurati C. (2002), Il cuore e lo scheletro, «Dirigenti Scuola», XXII.
Scurati C. (2003), Pedagogia della scuola, Brescia, La Scuola.
Zobbi E. (2021), Io e l’altro: L’atmosfera morale scolastica come luogo di relazioni e sviluppo di sé. Una ricerca esplorativa su concezioni e interventi, «Annali online della Didattica e della Formazione Docente», vol. 13, n. 21, pp. 249-262.
-
1 Professore associato di Pedagogia Generale e Sociale, Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste.
-
2 Associate Professor of General and Social Pedagogy, University of Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.
-
3 Richiamiamo qui la definizione di Katz e Kahn (1966) per cui «l’essenza organizzativa della leadership è costituita dall’incremento dell’autorità sopra e al di sopra di un’acquiescenza passiva, in accordo con la routine direttiva dell’organizzazione».
-
4 La cultura organizzativa è l’insieme coerente di assunti fondamentali che un dato gruppo ha inventato, scoperto o sviluppato imparando ad affrontare i suoi problemi di adattamento esterno e di integrazione interna e che hanno funzionato abbastanza bene da poter essere considerati validi e perciò tali da essere insegnati ai nuovi membri come il modo corretto di percepire, pensare, sentire in relazione a quei problemi (Schein, 1984).
Vol. 11, Issue 2, October 2025