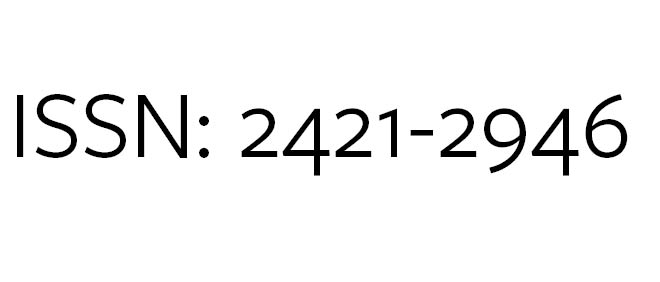Vol. 11, n. 1, aprile 2025 — pp. 1-6
EDITORIALE
L’esigenza di laicità in un mondo di integralismi
Stiamo attraversando un’epoca in cui assistiamo al risorgere di integralismi religiosi e ideologici, di radicalismi etnici, di nazionalismi sovranisti e identitari, di pulsioni totalitarie. Si tratta di fenomeni in gran parte legati alle dinamiche di una globalizzazione che si è snodata secondo l’ideologia neoliberista. Ciò ha innescato uno sviluppo economico planetario diseguale e interdipendente al tempo stesso, mentre le logiche del mercato e del consumismo hanno creato una pressione verso un’omologazione globale, scatenando reazioni di varia natura.
Rispetto al risorgere dei suddetti fenomeni riemerge anche il valore di una cultura laica. Ed entro questo quadro anche la pedagogia laica è chiamata a riprendere consapevolezza di sé e del proprio compito storico.
Ma che cosa è la laicità?
Per tentare una risposta, possiamo dare uno sguardo d’insieme al concetto di laicità. A questo scopo, userò uno schema analitico articolato secondo i seguenti aspetti:
- il nucleo del concetto;
- le sue implicazioni concettuali;
- le sue opposizioni concettuali (e le false opposizioni);
- le sue distinzioni concettuali;
- le sue affinità concettuali;
- i suoi principali ambiti d’applicazione in campo pedagogico.
Per ciascuno di questi aspetti mi limiterò a un rapido cenno e in ogni caso l’analisi proposta ha valore meramente ipotetico.
Il nucleo del concetto di laicità consiste nei suoi tratti fondamentali. A questo proposito, il tratto cruciale può essere ravvisato nel concetto di autonomia reciproca tra le diverse sfere dell’attività umana (si veda Abbagnano, 1998). Consiste, cioè, nell’esigenza che tali attività si svolgano secondo propri intrinseci principi, anziché secondo regole imposte dall’esterno. Storicamente, l’esigenza di tale autonomia reciproca ha riguardato prima di tutto il rapporto tra la sfera statale e quella religiosa. Da questo punto di vista, si tratta di evitare tanto l’ateismo di Stato, quanto lo stato teocratico, garantendo la vicendevole indipendenza e autodeterminazione di Stato e Chiesa.
Questo concetto d’autonomia è articolabile secondo la duplice dimensione negativa e positiva che riguarda il concetto di libertà (cfr. Veca, 1990; Bobbio, 1995). La stessa laicità è anzi formulabile anche nei termini di un atteggiamento mentale caratterizzato dalla libertà del pensiero (cfr, Boniolo, 2008), intesa ovviamente come comprensiva della sua manifestazione pubblica.
In senso negativo, come libertà del pensiero da impedimenti o costrizioni esterne al pensiero, siano esse di natura religioso-confessionale o di carattere politico-ideologico. In senso positivo, come libertà di pensiero nel campo della ricerca, della conoscenza e della discussione pubblica; come libertà di critica e di messa in discussione di qualsiasi questione.
Una tale libertà deve trovare in se stessa il suo stesso limite, il proprio principio di autodisciplina nel non pretendere di possedere la verità più di quanto lo possano pretendere gli altri. E questo anche rispetto alla stessa laicità, che per essere coerente deve ammettere che di essa si possa discutere soltanto laicamente, senza pretese di verità assoluta. Il nucleo concettuale proposto ha perciò soltanto il valore di un’ipotesi.
Le implicazioni del concetto riguardano le conseguenze derivabili dal suo nucleo. La caratterizzazione di quest’ultimo genera impegni e conseguenze che secondo una prospettiva semantica inferenzialista (cfr. Brandom, 2002) vengono a essere strettamente legate al significato stesso del concetto.
Tali implicazioni riguardano innanzitutto la tutela del pluralismo (di idee, opinioni, orientamenti culturali, ecc.) e la valorizzazione delle differenze (di genere, cultura, ecc.) in quanto costitutive della stessa pluralità e apertura della società. Si estendono inoltre all’idea della tolleranza, non intesa secondo il linguaggio comune come mera sopportazione, ma ricondotta alle sue fonti storico-culturali, ai trattati di Locke e di Voltaire, e dunque declinata in direzione della coesistenza pacifica e dello sforzo di comprensione tra diversi in un contesto pluralista (che trova il proprio limite nel rifiuto dell’intolleranza).
Ciò conosce il proprio prolungamento nel valore del dialogo, improntato al rispetto delle idee diverse dalla propria, al confronto civile delle opinioni e allo sforzo di comprensione reciproca. Uno sforzo che può portare a raggiungere intese e accordi almeno parziali, o a un avvicinamento delle posizioni, o comunque a capirsi meglio. Tutto ciò raggiunge il proprio culmine e compendio nell’idea di democrazia, intesa non come mera modalità di governo, ma come forma di vita associata in cui regnano i suddetti valori: le differenze, il pluralismo, la tolleranza e il dialogo. Una comunità di libera discussione e di liberi dubitanti. Tale dovrebbe essere una comunità laica, aperta e democratica.
Le opposizioni concettuali rispetto alla nozione di laicità aiutano a intenderne il senso, chiarendolo ex adverso (cfr. Sartori, 2011). A questo proposito, la laicità — come l’abbiamo presentata sopra — si oppone a una serie di altri concetti e posizioni. Si oppone al dogmatismo — alla pretesa di possedere certezze indubitabili, che quindi ci si rifiuta di mettere in discussione — contro il quale fa valere un atteggiamento critico e antidogmatico. Si oppone all’intolleranza, al rifiuto pregiudiziale e intransigente verso idee diverse dalle proprie, legato alla certezza di possedere la verità assoluta, contro cui sostiene l’ideale della tolleranza. Si oppone all’integralismo, all’idea che un dato sistema di credenze dogmatiche possa essere imposto a tutti e diventare così la base della vita sociale della comunità, contro cui fa valere i diritti di libertà. Si oppone, infine, al totalitarismo: a qualsiasi sistema politico-ideologico che tenda a reprimere la libertà di pensiero e la sua libera manifestazione pubblica, contro cui propugna l’ideale della democrazia.
Al tempo stesso si devono considerare le false opposizioni, che portano a fraintendere il concetto di laicità. A questo proposito, rappresenta un’opposizione falsa e immotivata quella tra laicità e fede religiosa. Essere laici non è incompatibile con l’essere credenti, almeno in linea di principio si può essere l’uno e l’altro. La condizione è che si tenga ferma l’esigenza di autonomia tra le diverse sfere dell’attività umana, ossia il non cercare di fare della propria fede un principio di eteronomia che subordina le altre sfere (e gli altri soggetti) a quella religiosa-confessionale.
Si potrebbe obbiettare che all’atto pratico questo è difficile, ma si può rispondere che non per questo è impossibile. E non si deve perciò confondere un’eventuale opposizione di fatto, che ha un carattere contingente, con un’incompatibilità di principio, di natura necessaria.
Le distinzioni concettuali rispetto a nozioni che possono essere viste come affini aiuta a rendere più chiaro il concetto di laicità.
A questo proposito una prima distinzione deve essere compiuta rispetto a un malinteso laicismo (cfr. Scoppola, 1978), posto come atteggiamento antireligioso e/o anti-ecclesiastico, che tende a cadere in una forma di intolleranza speculare a quella degli integralismi religiosi.
In uno Stato laico, la religione è una libera questione privata del singolo cittadino. E la laicità presuppone la libertà di religione, e ne rappresenta anzi la garanzia. Di più, la laicità implica un atteggiamento di dialogo con (e tra) le religioni, finalizzato alla ricerca di intese. Ovviamente, questo vale anche per il rapporto tra la pedagogia laica e quella cattolica.
Un’altra distinzione va fatta rispetto al relativismo. O almeno rispetto alla versione forte di quest’ultimo, secondo la quale non solo non vi sono verità o valori assoluti, ma tutte le idee e/o tutti i valori sono equivalenti e quindi indifferenti.
A questo proposito, il pluralismo di cui si fa garante la laicità non implica il relativismo in senso forte. La laicità, sebbene ostile a pretese verità assolute, inclina piuttosto verso una forma di problematicismo.
L’idea è che si possa distinguere tra idee migliori e peggiori soltanto con la libera discussione, volta alla ricerca di intese e stipulazioni che aspirano soltanto alla ragionevolezza, e mantengono perciò un carattere provvisorio e rivedibile.
Infine, si deve distinguere la laicità da una malintesa neutralità. La neutralità dello Stato rispetto alle varie confessioni religiose e il principio di autonomia che innerva la laicità non implicano una neutralità intesa come tendenza a non schierarsi nelle questioni della vita sociale. Richiede soltanto che il laico prenda posizione in base al proprio autonomo giudizio, sulla scorta della ragione e della libera discussione.
Una pedagogia laica è perciò incline a scelte militanti, secondo un’etica dell’impegno e della responsabilità. Al tempo stesso si devono considerare le affinità del concetto, la sua parentela con altre nozioni che tendono ad arricchirne il senso. A questo proposito si deve prendere in esame almeno l’affinità tra pensiero laico e pensiero progressista. L’anello di congiunzione è rappresentato dall’esigenza dell’emancipazione, che rappresenta il principio fondamentale del progressismo e che trova un nesso significativo con l’istanza della libertà del pensiero come asse della laicità.
Certamente, non si può identificare laicità e progressismo, in quanto possono esistere anche forme di pensero laico moderato o conservatore. Infatti, tali forme, pur assumendo il principio di autonomia tra le sfere dell’attività umana e quello della libertà di pensiero, limitano il processo di emancipazione. Tale limitazione, ad esempio, viene compiuta restringendo l’emancipazione al campo dei diritti civili e politici, ed escludendo così dal suo raggio quello dei diritti sociali o indebolendo la portata di questi ultimi. Tuttavia, il nesso storico tra laicità e progressismo appare significativo.
Veniamo infine ai principali ambiti di applicazione pedagogica del concetto di laicità. Tali ambiti riguardano per lo meno la ricerca pedagogica, le istituzioni formative e i processi educativi (si veda Pontecorvo, 2008).
Per quanto riguarda la ricerca pedagogica, il principio di laicità si fa valere nell’esigenza dell’indipendenza della ricerca da ingerenze confessionali o politico-ideologiche, e nella sua autonomia in base a principi epistemologici e metodologici intrinseci alla sua logica interna.
A questo proposito, vale la celebre risposta di Laplace a Napoleone, in sintesi: nella scienza dio non è un’ipotesi necessaria. Si badi bene, questa posizione non rappresenta una confutazione dell’esistenza di dio, e nemmeno una mancanza di rispetto. Delimita, invece, l’autonomia della sfera scientifica rispetto a quella religiosa. Per quel che concerne le istituzioni formative, e la scuola in particolare, la laicità si esprime nell’esigenza dell’indipendenza di tale istituzione da ingerenze confessionali o ideologiche, e in quella dell’autonomia nella definizione di curricoli e ordinamenti scolastici secondo principi culturali e scientifici intrinseci all’istruzione e all’educazione, e non asserviti a qualche posizione ideologica o confessionale. Infine, relativamente ai processi educativi, vale il principio di libertà di insegnamento sancito dall’art. 33 della Costituzione, libertà che trova il suo limite unicamente nell’essere ordinata alla realizzazione del diritto universale all’istruzione affermato dal successivo art. 34.
Massimo Baldacci
Bibliografia
Abbagnano N. (1998), Laicismo. In Id., Dizionario di filosofia, Torino, Utet.
Bobbio N. (1995), Eguaglianza e libertà, Torino, Einaudi.
Boniolo G. (2008), Introduzione. In G. Boniolo (a cura di), Laicità, Torino, Einaudi.
Brandom R.B. (2002), Articolare le ragioni, Milano, Il Saggiatore.
Cives G. (1978), La filosofia dell’educazione in Italia oggi, Firenze, La Nuova Italia.
De Mauro T. (2005), Scuola e cultura laica. In G. Preterossi (a cura di), Le ragioni dei laici, Roma-Bari, Laterza.
Habermas J. (1986), Il discorso della Modernità, Roma-Bari, Laterza.
Kant I. (1997), Che cos’è l’illuminismo, Roma, Editori Riuniti.
Locke J. (2005), Lettera sulla tolleranza, Roma-Bari, Laterza.
Nataf A. (1999), Il libero pensiero, Roma, Editori Riuniti.
Pontecorvo C. (2008), Laicità e istruzione. In G. Boniolo (a cura di), Laicità, Torino, Einaudi.
Preterossi G. (a cura di) (2005), Le ragioni dei laici, Roma-Bari, Laterza.
Sartori G. (2011), Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali, Bologna, il Mulino.
Scalfari E. (a cura di) (2004), Dibattito sul laicismo, Roma, Biblioteca di Repubblica.
Scoppola P. (1978), Laicismo. In Enciclopedia Europea, vol. 6, Milano, Garzanti.
Veca S. (1990), Cittadinanza, Milano, Feltrinelli.
Voltaire (1994), Trattato sulla tolleranza, Roma, Editori Riuniti.
Zanone V. (1990), Laicismo. In N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino (a cura di), Dizionario di politica, Torino, Utet.