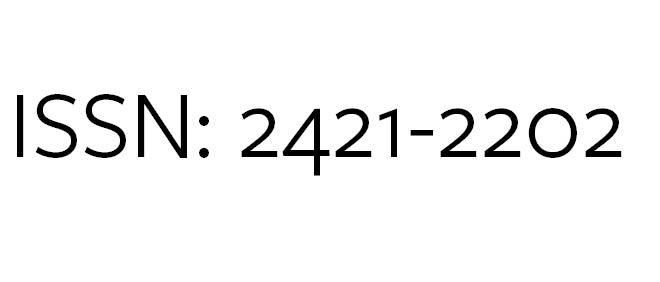Studi e ricerche / Invited Articles
Relazioni consulenziali “di processo”
“Process” consulting relationshipMassimo Bellotto
Università degli Studi di Verona
Christian Colautti
Laboratorio per il Lavoro e la Persona
Sommario
Le relazioni consulenziali “di processo” sono pratiche trasformative finalizzate allo sviluppo delle organizzazioni e delle persone. Sono fondate sul presupposto che facilitare l’apprendimento abbia a che fare con lo sviluppo della consapevolezza e il supporto riguardo al metodo (processo) piuttosto che sulla trasmissione di contenuti o l’apprendimento di una soluzione. Nel lavoro presentato viene problematizzato il concetto di consulenza di processo attraverso una riflessione sui possibili assunti che orientano le prassi consulenziali. In particolare si fa riferimento alle possibili teorie implicite del consulente per ciò che riguarda l’organizzazione, il processo, l’apprendimento, la relazione. Nell’ipotesi dell’Autore queste teorie implicite danno vita a diverse pratiche di consulenza, quindi è opportuno che vengano chiarite ed esplicitate.
Parole chiave
consulenza di processo; relazione d’aiuto; apprendimento; coaching.
Abstract
“Process” consulting relationships are transformative practices for the development of organisational systems and people. They are based on the supposition that facilitating learning deals with developing awareness and consciousness and with support regarding the method (process), rather than with the transmission of contents or solution learning. In this article the concept of process consultation has been turned into a problem through a reflection (meditation) on the possible assumptions that orient consulting praxis. In particular, we refer to all the possible implicit theories of the consultant as far as the organisation, the process, the learning and relations are concerned. In the author’s hypothesis these implicit theories generate different consulting practices, so it’s appropriate that these are made explicit and clarified.
Keywords
process consultation; helping relationship; learning; coaching.
Premessa
La consulenza cosiddetta di processo è una prassi trasformativa finalizzata all’evoluzione di un sistema organizzativo e delle persone che in questo sistema vi lavorano.
Come tale è in buona e affollata compagnia, soprattutto di questi tempi di inaudita voracità per proposte innovative e attrattive. Queste ultime, spesso a scapito della ricerca di soluzioni sensate.
Il counseling, il coaching, la consulenza filosofica, la formazione “innovativa”, nelle sue contaminazioni artistiche, avventuristiche e animative, solo per indicarne alcune, sono pratiche di intervento organizzativo che hanno l’obiettivo di aiutare le persone e i sistemi organizzativi a crescere, evolvere, trasformarsi in modo coerente alle finalità professionali e istituzionali.
Ma allora, in che cosa la consulenza cosiddetta di processo è diversa? Qual è la sua specificità?
A questa domanda si può tentare una risposta formale: la consulenza di processo è finalizzata ad aiutare le persone ad affrontare e risolvere un problema, senza però fornire una soluzione precostituita, bensì accompagnandole ad attivare le proprie risorse interne ed esterne per addivenire a una soluzione. Così, ad esempio, si esprime Schein (1999) che distingue la consulenza di processo dal consulto esperto, o da ciò che egli chiama relazione d’aiuto del tipo “medico-paziente”.
In tal senso, la consulenza cosiddetta di processo si distingue da altre forme di aiuto consulenziale in quanto centrata sul modo di procedere anziché sul contenuto della soluzione. È ciò che Rogers (1961) aveva già anticipato nella sua “terapia centrata sul cliente”, sostenendo che l’aiuto che può essere dato a colui che porta un problema è innanzitutto quello di aiutarlo ad aiutarsi. Nulla di nuovo quindi, a prima vista, nella proposta di Schein (1999) di una consulenza focalizzata sul processo anziché sul contenuto, anche se nella proposta di questo autore la relazione consulenziale è arricchita e contaminata da spunti teorici di derivazione psicodinamica e antropologica (ad esempio, con il costrutto di cultura organizzativa), rispetto alla prospettiva prevalentemente umanista di Rogers (1961). Il merito di Schein (1999) su questo tema è inoltre quello di avere saputo interloquire con manager e consulenti d’azienda sulla possibilità di un intervento clinico nel mondo professionale e organizzativo, senza necessariamente doverlo caratterizzare in senso terapeutico. Cosa questa di non poco conto.
La distinzione tra contenuto e processo è stata proposta in Italia in modo chiaro ed esplicito, e forse per la prima volta, nei primi anni novanta da Bruscaglioni (1991). Nel suo lavoro La gestione dei processi nella formazione degli adulti (Bruscaglioni, 1991) egli affronta in modo analitico la distinzione tra contenuto e processo, e in modo molto chiaro e articolato esplicita ciò che egli intende per “processo”: le componenti emozionali dell’atteggiamento, la motivazione e l’energia “straordinaria” necessarie all’apprendimento di nuove competenze, la consapevolezza di sé e del proprio ruolo, il vissuto psicologico (consapevole e inconsapevole) legato al processo di apprendimento e cambiamento (che egli chiama “posizione soggettiva”), le relazioni interpersonali e mentali. L’ambito esplorato è quello della formazione, ma ciò non toglie che l’analisi possa essere applicata più in generale alle pratiche consulenziali, di cui per altro la formazione d’aula potrebbe essere uno dei contesti di applicazione.
La specificità sembra quindi definita: la consulenza di processo sostiene i professionisti nell’affrontare i loro problemi (organizzativi, gestionali, psico-sociali), senza fornire direttamente la soluzione, ma supportandoli nell’analisi, nella diagnosi e nella generazione di alternative.
Illusoriamente la disanima sullo specifico della consulenza di processo può dirsi conclusa. Ma, per l’appunto, solo illusoriamente.
Infatti, anche il counseling, nel dichiarato di chi lo pratica, aiuta le persone ad aiutarsi. Anche il coaching potrebbe non essere (e spesso di fatto non lo è) centrato esclusivamente sul contenuto e le tecniche comportamentali, ma sul supporto alla diagnosi e alla ricerca di una soluzione. Ma anche la formazione, quando ad esempio l’aula si caratterizza come workshop e viene gestita in modo per l’appunto consulenziale.
Se è così, allora possiamo provvisoriamente concludere che la consulenza cosiddetta di processo non è una specifica pratica consulenziale, ma è piuttosto un modo di essere (e di fare) all’interno delle diverse relazioni di consulenza, siano esse maggiormente centrate sulla persona (come ad esempio nel counseling professionale), sul ruolo (nel coaching), sull’apprendimento di specifiche capacità (in aula). Una distinzione concettuale tra counseling e coaching si può trovare nel lavoro di Ferrario (1996).
Detto in altro modo, una consulenza è di “processo” nella misura in cui il suo aiuto non riguarda la trasmissione di contenuti e tecniche, ma è di supporto all’esplicitazione e individuazione di modalità coerenti ed efficaci di procedere. Ciò per altro è detto in modo esplicito dallo stesso Schein (1999), il quale sostiene che non si tratta di una tecnica o di una serie di interventi diretti a facilitare il lavoro con gruppi di persone. Non è neanche un modello di consulenza applicata agli interventi organizzativi. Si tratta piuttosto di una filosofia di “aiuto”, ovvero di una tecnica o metodologia per favorire la cooperazione cliente e consulente (Schein, 1999).
Ma se la consulenza di processo è una filosofia, a quali presupposti per l’appunto filosofici si può ispirare per essere coerente alle finalità che dichiara? Detto in altro modo, a quali assunti di “verità” si appoggia? Da quale teoria della conoscenza è orientata? Questi assunti come supportano e vincolano il processo di trasformazione della persona che si intende aiutare?
Questi interrogativi forse ci aiutano a problematizzare il tema della consulenza cosiddetta di processo e a porre la questione al di là e prima delle scelta tecniche e metodologiche. Si tratta cioè di analizzare i presupposti teorici ed epistemologici che sostengono la o, faremo meglio a dire, le consulenze di processo, per individuarne le specificità, le contraddizioni, le opportunità di impiego all’interno delle relazioni professionali e organizzative.
Cercheremo in questo modo di fare chiarezza su ciò che in modo esplicito o più frequentemente implicito fonda la relazione consulenziale cosiddetta di processo. La nostra, innanzitutto.
Il modo di guardare all’organizzazione
La consulenza di processo, quando rivolta al supporto di progetti di sviluppo professionale e organizzativo, si confronta con un primo assunto spesso implicito, che è quello relativo alla natura (nel senso di origine, finalità, modalità evolutive e trasformative) dell’esperienza organizzativa.
Sia che l’intervento riguardi il sistema organizzativo nel suo complesso, sia che riguardi una parte o soltanto una singola persona, il consulente attiva una relazione d’aiuto avendo “in mente” una certa idea di organizzazione.
Le nostre esperienze con persone che lavorano nelle e con le organizzazioni ci portano a pensare, nel possibile reciproco fraintendimento, che il pensiero circolante sull’esperienza organizzativa oscilli tra una concezione razionale e oggettivante e una concezione maggiormente soggettuale: la prima è prevalente sulla seconda. Più di rado è presente una concezione che integra queste due visioni, secondo un approccio teorico che Maggi (2003) definisce dell’“agire organizzativo”.
Nel primo caso l’organizzazione è pensata come un sistema finalizzato e razionale, a sua volta contenuto in un sistema più ampio (caratterizzato in senso economico, politico, psico-sociale, culturale), al quale le persone devono in qualche modo adattarsi, pur con ampi margini di discrezionalità e innovazione. Con ciò non intendiamo sostenere che in questo modo di guardare alle organizzazioni venga esclusa una dimensione soggettiva, emotiva, irrazionale. Tuttavia, all’interno di questo pensiero tali dimensioni sono considerate una devianza, un intoppo, una varianza da tenere sotto controllo.
L’orizzonte per il giusto disporsi (adattarsi) e dettato da mission, vision e strategie. Il paradigma, implicito o esplicito, è quello funzionalista: le risorse vanno scelte e orientate in funzione dell’obiettivo istituzionale. In tal senso la spontaneità degli atteggiamenti e dei comportamenti va ricondotta alla convenzionalità delle competenze ritenute più adeguate per la realizzazione del fine istituito.
Un modo diverso, che oscilla verso una concezione che definiamo soggettuale, pensa invece all’esperienza organizzativa come all’incontro di progettualità. Un sistema organizzativo è uno spazio, non tanto fisico ma psico-sociale e antropologico, generato da un processo di accomunamento. Le persone, ciascuna con un proprio progetto di vita personale e professionale, relazionandosi in modo integrativo e interdipendente per uno scopo istituito, danno origine a un sistema transpersonale (Lo Verso, 1994).
Questo sistema finalizzato di relazioni “attraversa” le persone cognitivamente e affettivamente. Le persone, pur prendendone parte, possono non esaurirsi nel sistema, ma mantenere aperta la loro potenzialità generativa per rifondare ricorsivamente il proprio progetto personale e, contemporaneamente, quello organizzativo. Pensare in questo modo alle organizzazioni significa considerare l’esperienza organizzativa come movimento espressivo o, come ci ha suggerito Elliott Jacques (1970), come momento concepitivo e creativo dell’accoppiamento tra mondo interno e mondo esterno.
Il lavoro diventa, in questa accezione, il modo per esprimere la propria affettività, per entrare in relazione e poter dire di sé, della propria capacità e incapacità, sensazione di competenza e incompetenza (Lampignano, 2005).
Di qui un diverso modo di intendere lo sviluppo e l’evoluzione, che difficilmente possono trovare una sintesi.
Nel primo caso, lo sviluppo delle persone è legato ai concetti di funzionalità e sopravvivenza del sistema organizzativo; nel secondo, alla possibilità di esistere, ovvero di porsi simbolicamente ed espressivamente in rapporto col mondo (Napolitani, 2002).
Posta in questi termini, assume un significato diverso anche il concetto di efficacia e “salute” organizzativa. Se per Schein (1985, 1999) è evidente che la consulenza di processo consente di intervenire “terapeuticamente” nelle organizzazioni, in riferimento alla promozione della consapevolezza e della funzionalità del comportamento rispetto agli obiettivi, non è invece chiaro se ciò abbia a che fare con la capacità di mantenere coerenze oppure, paradossalmente, con l’esatto contrario. Se accettiamo ad esempio di pensare alle organizzazioni come a un accomunamento di progettualità, potremmo dire che l’organizzazione si “ammala” non quando non riesce a realizzare in modo efficace ed efficiente il proprio obiettivo, ma quando l’eccedenza di finalizzazione e di “istituzione” fa perdere al sistema la propria capacità espressiva e concepitiva. Il fine della consulenza di processo sarebbe quindi in questa ipotesi non di ristabilire coerenze, ma di aprire a nuove possibilità, partendo dall’assunto che l’obiettivo istituzionale del sistema organizzativo non è l’orizzonte di senso al quale funzionalmente adattarsi, ma è esso stesso espressione del senso che le persone co-costruiscono nella loro relazione con l’ambiente.
Lavorare per l’efficacia, l’efficienza e la salute dei sistemi organizzativi vorrebbe dire quindi, primariamente, facilitare il riconoscimento delle eccedenze istituzionali e ristabilire la capacità progettuale ed espressiva degli individui.
Pur scegliendo di operare secondo una logica cosiddetta di processo, il consulente si troverebbe a percorre strade molto differenti. Il solo fatto di proporsi come consulente di processo non è sufficiente a identificare che cosa il consulente abbia intenzione di fare per lo sviluppo del sistema organizzativo. È necessario che nella sua proposta venga esplicitata la sua “teoria” organizzativa, da intendersi non tanto come bagaglio culturale e nozionistico sullo studio dei fenomeni organizzativi, ma come “sistema nella mente” che orienta il modo con cui egli guarda e interviene nell’organizzazione.
Il “processo” che è oggetto della consulenza
Anche potendo tener conto della specificità della consulenza di processo derivante dalla teoria implicita di organizzazione da parte del consulente, ciò non chiarisce quali siano i “processi” sui quali egli intenda intervenire.
La specificità dell’intervento cosiddetto di processo è da riferirsi a nostro avviso alla teoria, all’epistemologia, all’approccio, alla scuola a cui il consulente fa riferimento, in modo esplicito oppure implicito.
Nel lavoro di Schein (1985, 1999), ad esempio, è abbastanza esplicito il riferimento a un approccio psico-sociale, per cui i processi sui quali la consulenza interviene sono riconducibili alle dinamiche intrapsichiche, interpersonali e gruppali; l’origine di queste dinamiche è in parte consapevole, riconducibile a processi cognitivi, in parte inconsapevole, in quanto legata ad assunti culturali profondi, in parte inconscia, dando vita a meccanismi difensivi, di transfert e contro-transfert. Le discipline di riferimento sono quelle della psicologia sociale, in particolare a orientamento psicodinamico, dell’antropologia culturale, della sociologia, soprattutto in riferimento ai rituali dell’interazione sociale.
Sono questi riferimenti, a nostro avviso, che caratterizzano la proposta dell’autore, molto di più che la semplice definizione di consulenza di processo. Per questo motivo ci sembra corretto riformulare la domanda e chiederci: a che tipo di consulenza di processo fanno riferimento i consulenti quando ne parlano o quando la utilizzano nelle loro pratiche di intervento?
In riferimento alle prassi consulenziali ci sembra che una prima distinzione si possa fare tra un approccio che considera il comportamento professionale come espressione prevalentemente razionale e un approccio che invece tiene conto anche delle dinamiche irrazionali, o più propriamente emotivo-affettive. Utilizziamo intenzionalmente la parola “irrazionale” per radicalizzare la differenza con ciò che in genere viene definito “razionale”. Quest’ultimo è da intendersi come sinonimo di consapevole, prevedibile, comprensibile, prescrivibile. L’irrazionale ha invece a che fare con l’inconsapevole, il non prevedibile, l’emergente, il non conoscibile.
Molti interventi consulenziali di gestione e sviluppo delle cosiddette “risorse umane” nel nostro Paese fanno riferimento a modelli razionali di derivazione cognitivista-comportamentista e si ispirano a logiche tendenzialmente prescrittive, con enfasi sui comportamenti. Spesso ciò coincide con un’impostazione di intervento che parte dalle strategie aziendali (business strategy) alla quale viene fatta derivare una strategia di gestione delle persone (people strategy), in genere supportata da una mappatura delle competenze. L’impostazione rimane la medesima anche quando alla razionalità viene accostata l’emotività. Quest’ultima infatti, soprattutto con riferimento all’intelligenza emotiva nella sua versione golemaniana, è legittimata nella misura in cui può essere compresa nella sfera del razionale e del consapevole: dell’intelligenza del logos, per l’appunto.
Più di recente, nella pratica consulenziale organizzativa sembra farsi strada un approccio maggiormente costruttivista, facilitato in ambito manageriale e organizzativo anche da alcuni preziosi contributi, tra i quali quello di Weick (1995), sul sensemaking nei contesti professionali aziendali. Secondo questo approccio, la consulenza non si può limitare a spiegare, persuadere o prescrivere il modo giusto di fare le cose, ma deve aiutare le persone a dare senso alla propria esperienza organizzativa e a costruire significati condivisi al fine di meglio cooperare per la realizzazione degli obiettivi istituzionali.
Siamo comunque nel regno del razionale, anche se l’approccio costruttivista tenta di sostituire all’oggettività dell’organizzazione la soggettività dell’organizzare.
Altri approcci comprendono invece nel loro ambito di intervento anche la sfera emotivo-affettiva. Molti professionisti e società di consulenza di matrice psico-sociale o psicoanalitica, fanno riferimento a dinamiche affettive, anche inconsce, presenti a livello intrapsichico, interpersonale, gruppale o istituzionale.
In questo secondo caso l’irrazionale non fa semplicemente riferimento a dimensioni inconsapevoli o emotive bensì, più specificamente, ad aspetti affettivi inconsci del comportamento individuale e collettivo. L’enfasi in questi casi è sulla differenziazione tra “scena manifesta” e “scena nascosta”, sulla presa di consapevolezza di meccanismi di difesa inconsci, sul rapporto tra mondo interno e mondo esterno, sull’esperienza organizzativa come luogo di riattualizzazione di angosce primarie e di matrici interne, ma anche come possibilità di apertura, generatività e nuovi concepimenti.
Su questo versante, l’analisi e la distinzione potrebbe ulteriormente continuare, dovendo distinguere tra coloro che considerano l’inconscio come luogo caotico del rimosso da riportare all’ordine della razionalità, secondo l’ortodossia freudiana, o quanti invece lo considerano una fucina generativa del non ancora, portatore di nuovi concepimenti creativi, secondo un’accezione junghiana. O ancora tra una concezione di mente individuale e una concezione di mente relazionale. Eccetera eccetera.
Non entriamo qui nel merito del dibattito teorico ed epistemologico e tanto meno nella diatriba tra orientamenti, scuole, maestri di riferimento. Ci preme però portare l’attenzione sulle differenze sostanziali che le diverse teorie, epistemologie, orientamenti e scuole implicano nella prassi consulenziale e sulla definizione e identificazione di “processo”. Tutto ciò che viene detto è detto da un osservatore a un altro osservatore, che potrebbe anche essere se stesso (Maturana & Varela, 1980). Teorie diverse sottendono sguardi diversi, e di conseguenza modi differenti di aiutare le persone all’interno delle organizzazioni.
Anche per questo, la semplice definizione di consulenza di processo non è sufficiente a descriverne logiche, finalità e variabili di intervento.
L’idea di apprendimento
Uno degli scopi della consulenza cosiddetta di processo è quello di fare in modo che il cliente impari a imparare (Schein, 1999). La relazione d’aiuto, così pensata, ha quindi a che fare con l’apprendimento, anche se questo è in relazione al come più che al cosa, al processo appunto, anziché al contenuto.
Nella consulenza di processo l’apprendimento riguarda prevalentemente lo sviluppo di consapevolezza e l’esplicitazione di automatismi impliciti. Per dirla con Bateson (1972), potremmo dire che una delle la finalità della relazione consulenziale è soprattutto quella di apprendere a disabituarsi.
La relazione consulenziale propone un percorso di apprendimento finalizzato a comprendere il problema e a trovare e implementare soluzioni adeguate e possibili. Questa ricerca si può muovere su di un continuum, che va dall’apprendimento su come applicare una certa soluzione suggerita dal consulente (consulto esperto), allo sviluppo di capacità discrezionali e di autonomia in modo da poter scegliere tra più alternative, fino alla necessità di imparare a disimparare e a muoversi in modo non difensivo nell’incertezza.
Vista dall’angolatura dell’apprendimento, l’aiuto consulenziale può essere pensato, progettato e realizzato sulla base di un modello a cui tendere e conformarsi, oppure sulla base di un processo esplorativo, la cui meta si delinea e costruisce attraverso il processo stesso.
È su questo continuum che si possono disporre le diverse concezioni di consulenza di processo.
A un estremo del continuum poniamo un tipo di relazione consulenziale che ha sullo sfondo modalità educative e di aiuto che possiamo definire di insegnamento, ancorché su questioni complesse e articolate. Siamo di fronte a problemi che vengono affrontati “come se” le soluzioni da adottare fossero già “modellizzate”, sperimentate, note. In un certo qual modo siamo di fronte a modalità consulenziali tendenzialmente “difensive”, dove l’aiuto è finalizzato a intervenire sul problema attraverso modalità e strumenti già predisposti, preparati, collaudati. In questo senso il termine difensivo fa riferimento al fatto che l’apprendimento ha primariamente la funzione di riparare consulente e cliente dall’ansia dell’incertezza generata dalla situazione problematica (Bellotto, 1992). Apprendere ha qui il senso di imparare e acquisire modalità, strumenti e tecniche tendenzialmente certe, per ripararsi quanto possibile dall’eventualità di un risultato incerto.
All’altro estremo del continuum abbiamo a che fare con modalità di apprendimento “esplorative”, dove le soluzioni da adottare sono possibili, da sperimentare, da inventare. L’apprendimento che risponde a una logica esplorativa è finalizzato a intervenire sul problema attraverso modalità e strumenti solo in parte conosciuti, e in parte ancora da pensare, da scoprire. In questo senso il termine esplorativo fa riferimento al fatto che l’apprendimento è un processo di ricerca ed esplorazione del possibile, che mette in conto varianze non prevedibili e inaudite. Apprendere significa qui cercare, consentirsi di imparare, per intraprendere percorsi il cui punto di arrivo è da costruire. La distinzione qui operata tra apprendimento difensivo e apprendimento esplorativo (Bellotto, 1992), rimanda in parte alla distinzione proposta da Schein (1985, 1999) tra identification process (apprendimento per identificazione rispetto a un modello) e scanning process (apprendimento per analisi ed esplorazione).
La relazione consulenziale può oscillare tra questi due estremi. Nella misura in cui propone una logica di apprendimento difensivo essa assume una valenza formativo-addestrativa; attiva soluzioni note il cui esito dipende prevalentemente dall’applicazione di un modello; fa riferimento a un impianto teorico ed epistemologico oggettivo-interpretativo; operativamente si avvale di schemi di interpretazione consolidati; fa uso di schede, questionari, tracce di intervista che consentano la raccolta strutturata di dati, per poter mettere a disposizione del cliente una spiegazione o, al più, una interpretazione del fenomeno osservato, e la soluzione corrispondente.
Quando invece la relazione consulenziale dà vita a sistemi di apprendimento esplorativi assume una valenza trasformativa; presidia il processo consulenziale secondo logiche e modalità note, ma lascia che la diagnosi e la soluzione del problema siano l’esito finale di una comune ricerca e scoperta, tra cliente e consulente (Schein, 1999). Fa riferimento a un impianto teorico ed epistemologico clinico ermeneutico; operativamente si avvale di colloqui non strutturati; utilizza la relazione tra consulente e cliente come fonte di conoscenza, per poterla mettere circolarmente e ricorsivamente a disposizione del processo consulenziale, in attesa del profilarsi di una soluzione possibile.
In ogni caso, in entrambe le concezioni, la relazione consulenziale non può prescindere da una fase iniziale di apprendimento esplorativo, che consenta di ricercare nella domanda esplicita del cliente i bisogni talvolta impliciti, le variabili non evidenti, per consentire l’individuazione della soluzione più appropriata. Riteniamo che coloro che operano secondo la cosiddetta consulenza di processo, pur con le distinzioni che stiamo cercando di evidenziare, non possano prescindere dal differenziare tra analisi dei bisogni e analisi della domanda (Carli & Paniccia, 2003).
Ciò è valido sia in riferimento al processo di apprendimento che si intende promuovere sul versante del sistema cliente, sia in riferimento a ciò che il consulente deve apprendere e conoscere nella relazione per poter essere d’aiuto.
Nel caso del consulente ci riferiamo alla necessità di apprendere dall’esperienza e di alimentare la propria conoscenza anche attraverso l’esplorazione di ciò che non conosce, e quindi della propria “ignoranza”. Valutare la propria ignoranza è proprio ciò che garantisce l’autenticità dell’apprendimento e la “produzione” di conoscenza generata dalla relazione con il cliente. Al contrario se il consulente sovrappone i propri assunti culturali e operativi alla realtà del cliente, egli tende a riprodurre il proprio modello, correndo il rischio di allontanarsi dalla possibilità di comprendere.
L’esplorazione rimanda a ciò che non si conosce: in genere si esplora un territorio non conosciuto. Nella relazione consulenziale ciò è valido per il cliente, che può essere accompagnato a esplorare “nuovi territori”, nuovi modi di fare e pensare. Ma è vero anche per il consulente, che spesso deve abbandonare la certezza dei propri modelli e utilizzare anche “l’ignoranza”, i propri errori e i motivi per cui li ritiene tali, come strumento per apprendere: tanto più il consulente cerca una vicinanza con il “territorio” del cliente, con la sua cultura e sensibilità, tanto più deve abbandonare il proprio territorio conosciuto. D’altra parte, per poter essere davvero di aiuto è opportuno incontrare il cliente lì dove egli si trova (Lampignano, 2005), per quanto quel luogo ci appaia impervio e difficile da attraversare.
Tuttavia, come già detto, l’esplorazione del nuovo è accompagnata da sentimenti di smarrimento e di incertezza, che vanno riconosciuti, contenuti ed elaborati. In tal senso, c’è spesso il rischio che l’applicazione di un modello risponda più a esigenze di contenimento dell’ansia che non alla ricerca di una soluzione opportuna. L’ansia del consulente, innanzitutto.
La modalità esplorativa, pur essendo a nostro avviso un presupposto delle relazioni consulenziali trasformative, non è spesso facile da adottare, soprattutto in presenza di richieste pressanti di risultati a breve termine. La capacità del consulente è quella di contenere l’ansia, propria e del cliente, di accompagnarne l’elaborarazione e di farne oggetto di apprendimento. E ciò non tanto attraverso la certezza di modelli preparati e noti, ma attraverso la sicurezza di confini e setting esterni e interni rigorosi (Cofano, 1996) all’interno dei quali ricercare la soluzione più idonea e vicina al problema posto dal cliente.
Quale “relazione” di consulenza?
Uno dei presupposti della relazione consulenziale è la necessità di agire con e all’interno di un sistema. E ciò non tanto nel senso di intervenire al servizio di un sistema (familiare, istituzionale, organizzativo, …) e delle sue relazioni, ma di attivare risorse, capacità, conoscenze del cliente e del consulente, che si integrano assumendo carattere di sistema. Per il consulente lavorare con e all’interno di un sistema significa osservare, ascoltare, riconoscere e aiutare il cliente a dare senso al processo: renderne possibile una partecipazione attiva all’interno della relazione (Garuti, 1997).
Da questo punto di vista la relazione consulenziale è una relazione parziale, che nasce dalla complementarietà dei contributi del consulente e del cliente. Il consulente porta nel sistema le proprie conoscenze, capacità e metodologie professionali, mettendole al servizio delle informazioni, delle conoscenze e delle capacità del cliente, finalizzandole alla soluzione del problema. Non si tratta infatti di indicare unilateralmente la diagnosi e la soluzione, ma di creare relazioni e interdipendenze utili che consentano a entrambi di arrivare al risultato auspicato. Nella relazione consulenziale possiamo quindi dire che il tema del conoscere pone quello del “riconoscere” l’altro come soggetto attivo e portatore di una propria visione.
Ma che cos’è che si tratta di ri-conoscere nella reazione consulenziale? Verso che cosa è orientato questo “conoscere nuovamente” e da altri punti di osservazione? Che cos’è che deve essere riattraversato, esplicitato e reso noto e a chi?
Il tema della relazione consulenziale pone necessariamente il tema della relazione tout court. La relazione viene prima delle rispettive individualità oppure ci sono individualità distinte, in ultima analisi quella del consulente e del cliente, che danno vita secondariamente ad una relazione?
Anche su questo punto ci troviamo di fronte a delle alternative di pensiero, e quindi di azione, che hanno forti implicazioni pragmatiche sulla relazione d’aiuto che si intende attivare.
Pensare alla relazione tra consulente e cliente come a un incontro tra individualità significa avere un’idea “oggettivante” di soggetto: il cliente è “là fuori” e deve essere conosciuto per come egli è e per le caratteristiche che possiede. Per il consulente è possibile conoscere il cliente nella misura in cui egli si “toglie” dalla relazione, e quest’ultima non deve essere influenzata dalla sua soggettività. Secondo questa ipotesi, la ricercata neutralità è ciò che consente una corretta interpretazione di quanto portato dal cliente, anche di ciò che egli affettivamente trasferisce su consulente (transfert). Quest’ultimo, se ha maturato una buona consapevolezza di sé, può al massimo riconoscersi un’emozione, un movimento affettivo, come conseguenza del movimento affettivo del cliente (contro-trasfert).
Secondo questo modo di pensare e di operare, facilitare il cambiamento significa promuoverlo sul versante del cliente, che ha esplicitato un bisogno, ad esempio una situazione di disagio che vuole modificare.
Diversamente, pensare alla relazione tra consulente e cliente secondo una visione relazionale, significa lavorare primariamente proprio sulla relazione. In tal senso la relazione precede l’individualità di ciascuno: il consulente non può conoscere se non la relazione con il cliente, e viceversa. Ciò che entrambi possono sapere l’uno dell’altro può essere solo e soltanto la relazione tra di loro. Non c’è un cliente “là fuori” che deve essere conosciuto, ma c’è una relazione che si dà e che reciprocamente stimola coloro che vi partecipano. Per il consulente è possibile conoscere il cliente nella misura in cui si “mette” nella relazione e si lascia attraversare dai pensieri e dalle emozioni che essa genera. Questa imprescindibile implicazione è ciò che consente al consulente una corretta comprensione di quanto suscitato dal cliente: sia di ciò che il cliente affettivamente trasferisce su consulente (transfert), sia di ciò che quest’ultimo trasferisce sul cliente come movimento affettivo di risposta (contro-transfert), sia di ciò che si agita nel consulente come movimento affettivo proprio, nato dalla risonanza prodotta proprio dalla relazione col cliente (co-transfert). Ovviamente, anche in questa ipotesi, tutto ciò può essere riconosciuto dal consulente nella misura in cui egli ha maturato una buona consapevolezza di sé.
Secondo questo modo di pensare e di operare, facilitare il cambiamento significa promuoverlo non tanto sul versante del cliente o del consulente, ma della relazione. L’evoluzione e la trasformazione sono possibili nella misura in cui il cliente fa esperienza con il consulente di una relazione diversa, insolita, nuova.
Questo secondo modo di intendere la relazione consulenziale può a nostro avviso essere più autentico, nel senso proprio e pieno che questa riesce a veicolare. È autentico ciò che è nuovo ed emerge nella relazione consulenziale come superamento di codici di pensiero e di comportamento abituali. È autentico ciò che non è la semplice ripetizione (inconsapevole) del “passato”, né del passato del cliente, né del passato del consulente.
Dare vita a una relazione consulenziale autentica è molto spesso difficile poiché essa è per sua natura una relazione “sbilanciata”, soprattutto sul versante psicologico, in quanto c’è qualcuno in difficoltà che chiede aiuto (il cliente) e c’è qualcun altro potenzialmente in grado di fornire una soluzione (il consulente).
Tuttavia, il consulente è in grado di aiutare autenticamente il cliente nella misura in cui riesce a ristabilire con lui un rapporto di reciprocità e di pariteticità, dando a quest’ultimo pari dignità nella ricerca della soluzione, pur nella differenza dei ruoli.
A tale proposito, è importante e necessario, per il consulente ma anche per il cliente, riconoscere la propria parzialità, svincolandosi da un’idea di onnipotenza che fa sentire gli interlocutori capaci di gestire “da soli” la relazione d’aiuto.
Il consulente deve essere capace di vivere l’altro come vincolo e opportunità, indispensabile per il proprio lavoro consulenziale (Varchetta, 1991). Non è utile per il consulente, in una buona relazione d’aiuto, né avere interlocutori passivi, che “dipendono” nelle loro decisioni e azioni da ciò che egli pensa e dice, né interlocutori “direttivi”, che ritengono di sapere già qual è il problema e la soluzione, e chiedono al consulente l’avvallo o il supporto esecutivo. E ciò non è una questione “etica”, ovvero non ha a che fare con il rispetto delle persone. E non è nemmeno una questione “politica”, nel senso che non si tratta di decidere chi è che “comanda”. È semplicemente più utile a creare le condizioni affinché entrambi possano capire e comprendere il problema e arrivare a una soluzione.
La consulenza cosiddetta di processo è a nostro avviso tanto più efficace quanto più riesce a creare uno “spazio partecipativo” all’interno del quale cliente e consulente concorrono alla costruzione di un lavoro comune. Uno spazio partecipativo in cui cliente e consulente si sentono parte e tutto, avvertendone la responsabilità e la possibilità di contribuire al risultato.
Essere partecipi alla relazione consulenziale significa essere in grado di rappresentarsi, cognitivamente e affettivamente, come soggetti parziali, mancanti, e quindi accettare la propria parzialità e sopportare la “ferita narcisistica” che ogni scoperta di mancanza produce.
Tuttavia, essere parte di un sistema, partecipare alla relazione consulenziale, significa anche sentire di poter contribuire alla diagnosi e alla soluzione; essere in grado di rappresentarsi, cognitivamente e affettivamente, come portatori di “possibilità”, di cose da dire e da fare, di energie, di conoscenze e di competenze di cui l’altra parte non dispone.
In tal senso il lavoro del consulente è spesso anche e soprattutto un lavoro di empowerment nei confronti del cliente, per aiutarlo a sviluppare sentimenti di autostima, di padronanza, di possibilità di contribuzione, per essere parte attiva all’interno della relazione d’aiuto. La relazione consulenziale agisce su un sentimento di carenza unito ad un sentimento di speranza e di miglioramento, per poter costruire e alimentare relazioni “interdipendenti” e integrate, più “potenti” della somma delle parti, per il raggiungimento degli obiettivi per i quali la relazione è stata costituita.
La consulenza di processo e il primato della domanda
La consulenza di processo si fonda sul primato della domanda. È indispensabile per il consulente fare domande prima di dare indicazioni e risposte. Questo tipo di relazione consulenziale ha a che fare soprattutto con l’interrogare-interrogarsi, il chiedere. Il consulente deve interrogare, domandare, raccogliere informazioni: solo così è in grado di conoscere e operare in modo utile e sensato per il cliente.
Un errore che spesso attraversa il processo di consulenza ha a che fare con la passività dell’interlocutore nella fase di diagnosi: l’urgenza da parte del consulente di mostrare la propria esperienza ha la meglio sulla curiosità di capire chi ha realmente di fronte. In questi casi il colloquio assume maggiormente le caratteristiche di un’intervista anziché di un dialogo in cui entrambi, consulente e cliente, possano essere parte attiva del sistema.
Una delle finalità, senz’altro la prima in ordine temporale, è di costruire con il cliente la diagnosi, aiutando l’interlocutore a mettere in parole il senso soggettivo delle cose e facilitandolo nella ricostruzione della sua prospettiva, della sua “teoria”.
Dare per scontato di sapere già la risposta, di poter formulare l’interpretazione o la diagnosi senza aver bisogno del cliente, pone il consulente o in una posizione “esterna” alla relazione, o in una posizione “superiore”, di esperto che sa già e non ha bisogno di conoscere ulteriormente. Ciò ha l’effetto di separare il problema dalla persona che lo porta, sottraendo al sistema consulenziale buona parte delle conoscenze, delle capacità e delle potenzialità offerte e portate dal cliente. Egli si illude e collude con un’idea immaginaria di onnipotenza del consulente, e ciò ha l’effetto di soddisfare illusoriamente il suo bisogno di rassicurazione.
Il cliente, ponendosi alle dipendenze di un consulente “esperto”, può evitare il disagio di sentirsi troppo a lungo portatore di una mancanza: mancanza che in questo modo finisce per connotarsi secondo i vissuti del difetto. Oppure, al contrario, trova nel consulente la possibilità di saturare il difetto secondo modi e tempi noti, mutuati dall’esperienza del consulente.
In questo modo la relazione si muove secondo l’assunto implicito di non doversi chiedere niente (il consulente sa già ciò che serve sapere e ciò che deve essere fatto!).
Ma se il cliente non si interroga, non destruttura anche solo temporaneamente le proprie certezze, se non intraprende egli stesso un percorso di ricerca e di riflessione, non può in realtà mobilitare le energie necessarie per dare vita a un reale processo di trasformazione: interrogarsi sul mondo è un’altra cosa rispetto al pensare di avere già le risposte (Volpe, 1998). E se ciò è valido per il cliente, lo è altrettanto per il consulente. Anch’egli infatti, se non chiama a raccolta la sua curiosità, se non si interessa, nel senso proprio di mettersi in mezzo alle cose, rischia di proporre le sue ripetizioni e di ancorare il cambiamento al proprio modo di fare e pensare, senza agganciarlo dalla realtà del cliente.
L’interrogativo, il punto di domanda che poniamo alla fine delle nostre riflessioni dubbiose, è il gancio con cui possiamo afferrare la realtà, soprattutto quando sembra nascondersi, celarsi, sfuggire. Chiedere e chiedersi, porre e porsi quesiti, domandare è il modo più efficace per rimanere saldamente ancorati alla realtà del problema, non così com’è “oggettivamente”, ma nella prospettiva con cui è guardato dal nostro interlocutore e da noi stessi.
L’interrogativo è anche l’apertura al dubbio, all’incertezza, al senso non compiuto delle cose: alla mancanza, come abbiamo già detto. Tuttavia, “la mancanza, il vuoto, se non fa paura e se non produce la spinta a riempirlo comunque e subito, può contenere in sé la possibilità di creare il nuovo” (Basili et al., 1990, p. 43).
La relazione consulenziale talvolta manca di efficacia non perché il consulente non ha buone risposte, ma perché spesso non ha buone domande. E le domande sensate, come ci ricorda Bateson (1972), sono quelle che spesso fanno emergere “coincidenze imbarazzanti”, coincidenze che vanno contro l’ovvio, il già noto, l’apparentemente oggettivo. Domande che stupiscono, turbano, emozionano, che costringono a pensare.
“Porsi delle domande è utile senza la fretta di far affiorare le risposte” (Pagliarani, 2001, p. 15). E allora anche il silenzio, come suggerisce ancora Schein (1999), può essere un intervento: rimanere in silenzio continuando a osservare ciò che accade, restando in posizione di ascolto: sospendere attivamente lo sguardo. Ciò che riusciamo a vedere e a sentire mentre ci sforziamo di rimanere in silenzio ci rivela spesso proprio quelle informazioni che ci servono per dare una risposta più utile al cliente (Schein, 1999). L’aiuto che il consulente offre non può nascere solo da una conoscenza già costruita e prevista, ma si cerca e si costruisce in due, consulente e cliente, attraverso una complice attenuazione della potenza di ciascuno e il rinforzo del reciproco ascoltarsi (Varchetta, 1991).
Conclusioni
Nella prassi consulenziale con le organizzazioni, soprattutto con quelle maggiormente esposte sul mercato, vige il primato dell’efficacia. Di conseguenza, è serio e degno di attenzione, soprattutto economica, ciò che consente di raggiungere gli scopi. Meglio se contenendo i costi, ovviamente.
L’abitudine a organizzare il pensiero e l’azione sulla base dello schema logico mezzi-scopi è un tratto culturale proprio della società occidentale (Bateson, 1972), e ancor di più delle organizzazioni di lavoro, ma è come se ogni tanto ce ne dimenticassimo, data la potenza e l’attraente semplicità di questo modo di guardare alle cose.
Le attuali e future organizzazioni pongono problemi nuovi e inauditi, come la responsabilità sociale, la convivenza civile dentro e fuori dalle fabbriche o dagli uffici, la sopravvivenza dell’ecosistema ambientale. Problemi complessi ai quali può essere inopportuno e talvolta collusivo dare risposte fondate su presupposti semplicistici.
Il criterio “efficacia-efficienza dei mezzi in funzione di scopi” è per l’appunto un presupposto semplicistico.
La consulenza cosiddetta di processo è uno dei modi con cui è possibile aiutare i sistemi organizzativi a evolvere e trasformarsi, anche facendosi carico di problemi nuovi che nel nostro ecosistema complesso andiamo disvelando.
Tuttavia, questa modalità di aiuto e supporto, se interpretata in modo radicale, è una proposta “debole” e nella maggior parte dei casi aiuta il committente a porsi delle buone domande più che a darsi delle risposte. In ogni caso, fa del bisogno espresso un’occasione di interrogazione (ermeneutica), che può con buona probabilità ma non con certezza condurre all’individuazione di una soluzione appropriata.
Se il criterio dell’efficacia organizzativa ed economica è l’unico metro con cui si misura la validità della consulenza di processo si rischia di chiudere prematuramente il nascere di un pensiero. E molti pensieri che nascono oggi nelle organizzazioni, o in certe loro “nicchie ecologiche”, sono ancora immaturi per poter mostrare la loro forma e forza. Sono pensieri, ma anche affetti, che hanno bisogno di un contenitore, possibilmente non rigido, che consenta loro di maturare e magari concepire nuove possibilità.
La consulenza di processo, a certe condizioni, può legittimamente proporsi come contenitore idoneo a far maturare pensieri non ancora pensati, nelle persone come nelle organizzazioni.
Proprio per questo, e a maggior ragione, è opportuno riconoscerne le caratteristiche intrinseche e fare i conti con ciò che implicitamente veicola: questa è la riflessione che si è voluto proporre in queste pagine.
Riteniamo che essere d’aiuto nei sistemi organizzativi complessi, abbia a che fare soprattutto col preservare i nostri interlocutori dall’auto-inganno, dalle finte scorciatoie (inconsapevoli), dall’univocità di pensiero. La consulenza di processo può essere quella pratica dialogica di accompagnamento, che dà voce alla plurivocità dei sistemi (esterni come interni). È una pratica che può essere di aiuto per far luce sul proprio “procedere”, tenendo alta l’attenzione e la “veglia”, per non cedere alla sonnolenza e all’abitudine, alla ripetizione.
Abbiamo cercato, in questa riflessione di problematizzare il tema della consulenza di processo, proprio per non essere tentati dalle facili scorciatoie, come ad esempio quella di non esplicitare la teoria, l’epistemologia, la concezione di aiuto, apprendimento, relazione di cui ciascuno di noi è portatore nel momento in cui si dispone a un lavoro consulenziale.
La consulenza cosiddetta di processo ha quasi sempre a che fare con l’esplicitazione, la presa di coscienza e l’elaborazione di meccanismi impliciti. È pertanto opportuno che coloro che propongono questa pratica consulenziale, i consulenti, siano il più possibile riflessivi e consapevoli dei propri “meccanismi” impliciti che intervengono nella relazione d’aiuto.
Il senso quindi di interrogarsi sull’idea di organizzazione, di apprendimento, di relazione ha a che fare proprio con questa esigenza di chiarezza e consapevolezza, che è necessaria innanzitutto da parte del consulente. Tuttavia, poiché la committenza ha un ruolo importante nel condizionare le logiche e le modalità dell’intervento consulenziale,
è opportuno che anch’essa si interroghi sui modi in cui pensa allo sviluppo delle persone e dei sistemi.
E se il consulente le trascura o le lascia sullo sfondo, in nome di una sedicente efficacia pragmatica, rischia di essere un professionista poco adeguato alle richieste dei nostri tempi. E se il committente, da parte sua, non si interessa e non si cura di capire con quali teorie e modelli sta pensando allo sviluppo delle sue persone e alla scelta della consulenza, non è soltanto un efficace pragmatico, ma forse uno che pensa poco. Forse conviene tener conto di ciò che ci ha insegnato Kurt Lewin (1951): non c’è nulla di più pratico di una buona teoria.
Bibliografia
Basili, A., Burlini, A. M., Fornaia, K., Giacobbi, S., Pagliarani, L., Pescara, R., & Sorrentino, L. (1990). Glossario di psicoterapia progettuale. Milano, Italia: Guerini e Associati.
Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Bellotto, M. (1992). Funzione difensiva e funzione esplorativa del metodo dei casi. FOR, 17/18, 54-61.
Bruscaglioni, M. (1991). La gestione dei processi nella formazione degli adulti. Milano, Italia: FrancoAngeli.
Carli, R., & Paniccia, M. R. (2003). Analisi della domanda. Bologna, Italia: il Mulino.
Cofano, L. (1996). Setting e gruppoanalisi: Note introduttive. Rivista Italiana di Gruppoanalisi, 9(1), 25-55.
Ferrario, M. (1996). Méntore e rapporto di mentorato: Un modello e un punto di vista sull’applicabilità nella società di oggi. In P. Mottana (Ed.), Il mentore come antimaestro (pp. 74-75). Bologna, Italia: Clueb.
Garuti, M. G. (1997). Working in and with groups: Cultural references. In F. Avallone, J. Arnold, & K. de Witte (Eds.), Feelings work in Europe. Milano, Italia: Guerini e Associati.
Jacques, E. (1970). Work, creativity, and social justice. London, UK: Heinemann Educational.
Lampignano, A. (2005). Formarsi attraverso l’attualità. Roma, Italia: Borla.
Lewin, K. (1951). Field theory in social science: Selected theoretical papers. New York: Harper & Row.
Lo Verso, G. (Ed.). (1994). Le relazioni soggettuali. Torino, Italia: Bollati Boringhieri.
Maggi, B. (2003). De l’agir organisationnel. Toulouse, France: Octarès.
Maturana, H., & Varela, F. (1980). Autopoiesis and cognition. Dordrecht, Netherlands: Reidel.
Napolitani, D. (2000). Formazione e trasformazioni negli sviluppi gruppoanalitici. Rivista Italiana di Gruppoanalisi, 3, 1-13.
Pagliarani, L. (2001). Educazione sentimentale. Milano, Italia: Guerini e Associati.
Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. A therapist's view of psychotherapy. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.
Schein, E. H. (1985). Organizational culture and leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Schein, E. H. (1999). Process consultation revisited: Building the helping relationship. Reading, MA: Addison-Wesley-Longman.
Varchetta, G. (1991). Ascoltando Primo Levi. Milano, Italia: Guerini e Associati.
Volpe, V. (1998). Il metodo di lavoro consulenziale a servizio della partecipazione. L’impresa al Plurale. Quaderni della Partecipazione, 2, 24-29.
Weick, K. (1995). Sensemaking in organisations. London, UK: Sage.
Autore per la corrispondenza
M. Bellotto. Tel. +39 0458028797 Indirizzo e-mail: massimo.bellotto@univr.it Università degli Studi di Verona, Via San Francesco, 22, 37129 Verona, Italia
© 2015 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo effettuata, se non previa autorizzazione dell'Editore.