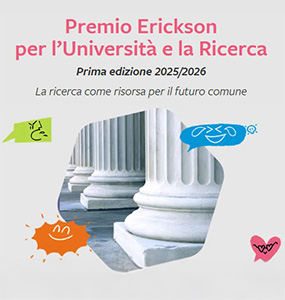Vol. 2, n. 1, Luglio 2025
Donne senza dimora tra partecipazione e processi di advocacy
Una ricerca qualitativa in Caritas Bergamasca
Tecla Belometti1
Sommario
Il fenomeno dell’homelessness, con le sue molteplici dimensioni, è al centro di un crescente interesse nelle politiche sociali, in particolare per quanto riguarda la partecipazione attiva delle persone senza dimora nella costruzione dei propri percorsi di supporto. Questo studio esplora i processi di partecipazione e advocacy all’interno di uno spazio destinato alle donne senza dimora nella città di Bergamo, con l’obiettivo di comprendere come queste dinamiche si manifestano e possano essere valorizzate per promuovere un cambiamento significativo. I risultati indicano che, sebbene i processi di advocacy siano ancora embrionali, essi rappresentano importanti occasioni di ripresa di voce per le donne coinvolte. La ricerca sottolinea l’importanza di un lavoro sociale che integri un approccio relazionale e partecipativo, che vada oltre la mera assistenza, riconoscendo e valorizzando le risorse individuali delle donne. Tuttavia, la mancanza di risorse adeguate e di un quadro progettuale strutturato ostacola la realizzazione piena di questo approccio. Il lavoro mette in evidenza la centralità della relazione e dell’ascolto, proponendo un modello che favorisca l’inclusione e il riconoscimento delle donne senza dimora come soggetti attivi nella società. La ricerca, pur consapevole dei suoi limiti, prova ad aprire la strada per ulteriori sviluppi di pratiche di advocacy che, a partire dalle esperienze dirette, possano influenzare nuove prospettive nella progettazione delle politiche sociali.
Parole chiave
Donne senza dimora, Advocacy, Lavoro sociale relazionale, Progettazione partecipata, Politiche sociali.
Homeless women between participation and advocacy processes
A qualitative study in Caritas Bergamasca
Tecla Belometti2
Abstract
The phenomenon of homelessness, with its many dimensions, is at the center of growing interest in social policies, particularly regarding the active participation of homeless individuals in the construction of their own support pathways. This study explores the processes of participation and advocacy within a space dedicated to homeless women in the city of Bergamo, with the aim of understanding how these dynamics manifest and how they can be enhanced to promote meaningful change. The results indicate that, although advocacy processes are still in their early stages, they represent important opportunities for these women to regain their voice. The research emphasizes the importance of social work that integrates a relational and participatory approach, going beyond mere assistance, while recognizing and valuing the individual resources of the women. However, the lack of adequate resources and a structured project framework hinders the full realization of this approach. The paper highlights the centrality of relationships and listening, proposing a model that fosters inclusion and recognition of homeless women as active subjects in society. While acknowledging its limitations, the research aims to pave the way for further developments in advocacy practices that, based on direct experiences, can influence new perspectives in the design of social policies.
Keywords
Homeless women, Advocacy, Relational Social Work, Participatory planning, Social policies.
Introduzione
Il fenomeno dell’homelessness emerge come un tema attuale sulla scena nazionale e internazionale anche a fronte dei recenti studi in merito (Milaney et al., 2020; Steele, 2017) e di una nuova attenzione nel campo delle politiche sociali, aprendo lo sguardo su nuove prospettive che prevedono la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti interessati nella costruzione dei percorsi di riflessione e di aiuto (Folgheraiter, 2011; Henwood et al., 2015). L’analisi del fenomeno parte dalla necessaria ricerca di una definizione, la quale ci porta a una riflessione sulle varie sfaccettature e manifestazioni dell’homelessness, comprendendone gli intrecci con le traiettorie di povertà estrema e di emarginazione sociale, arrivando a un dialogo necessario con i diritti prospettati e mancati anche all’interno della visione comunitaria del fenomeno, la quale spesso attiva meccanismi di allontanamento e pregiudizio (Leonardi, 2021). La Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.PSD) considera la persona senza dimora come «un soggetto in stato di povertà materiale e immateriale, portatore di un disagio complesso, dinamico e multiforme, che non si esaurisce alla sola sfera dei bisogni primari ma che investe l’intera sfera delle necessità e delle aspettative della persona, specie sotto il profilo relazionale, emotivo e affettivo».3 Si tratta di una definizione che restituisce complessità e umanità a questo fenomeno e alle persone che ne sono coinvolte, riportando al centro la dimensione relazionale e dei bisogni individuali. Non ci si ferma infatti a descrivere la situazione di disagio in cui vivono queste persone come afferente alla mancanza di un’abitazione intesa come «tetto», ma alla più complessa mancanza di un luogo dove prendersi cura di sé e delle relazioni con gli altri. Bisogna riconoscere però che quella delle persone senza dimora è spesso una popolazione eterogenea e diversificata, e ciò rende più complesso trovare una definizione univoca. A livello internazionale troviamo come strumento di riferimento per definire il fenomeno la classificazione ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion), elaborata dall’Osservatorio europeo sull’homelessness (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2015). Si tratta di una classificazione che parte dal considerare tre aree costitutive dell’abitare:
- Area fisica: disposizione di uno spazio abitativo adeguato con diritto di esclusività;
- Area sociale: avere la possibilità di coltivare in quello spazio relazioni autentiche e soddisfacenti;
- Area giuridica: avere un titolo legale riconosciuto che ne permetta il pieno godimento.
È dall’intreccio di queste tre aree che si vengono a individuare alcune categorie
di grave esclusione abitativa, grazie a uno sguardo che cerca di dare completezza al fenomeno, riconoscendone le diverse sfaccettature di vulnerabilità.
Un ulteriore aspetto fondamentale viene riscoperto anche in quelle che sono le dimensioni relazionali che coinvolgono e accompagnano questo fenomeno, parlando di diritti e responsabilità collettive sulla scia di un diritto all’abitare che rende necessaria anche una partecipazione comunitaria (Lodi Rizzini, 2013). Il fenomeno, analizzato nella sua prospettiva globale, richiede però nelle traiettorie comunitarie di sapersi spostare anche verso una dimensione di genere (Juhila, 2009), tenendo conto delle dinamiche di violenza e vittimizzazione alle quali le donne senza dimora sono sottoposte quotidianamente, e mettendo in luce traiettorie di vita spesso ignorate sulla scena pubblica, politica, economica e sociale (Milaney et al., 2020). Tale sfaccettatura di genere nell’approccio al fenomeno si riscopre parallela a un ragionamento sulla dimensione della cura, grazie a un’attenzione nuova a un fenomeno che rischia spesso di rimanere ai margini non solo del pensiero ma anche dell’azione sociale, ridando centralità alle dimensioni della sicurezza e dell’ascolto, che si rendono necessarie per un agire che sappia muoversi in un’ottica di protezione e di relazionalità, riconoscendo nella dimensione del gruppo la possibilità di una rete che si metta a supporto di queste storie di vita (Huber et al., 2022). Questi aspetti di ascolto, relazione e cura si pongono come cardine di un equilibrio tra quelle che sono le dimensioni di aiuto e controllo. La dimensione dell’aiuto si pone nel lavoro sociale come un agire intenzionale che mira ad accompagnare e a facilitare l’azione di una persona altra da noi ritenuta ottimale per il benessere; quando si parla di controllo ci proiettiamo invece in un’azione intenzionale che mira a impedire o ostacolare azioni agite da altri e ritenute dannose per il benessere (Raineri, 2007). Si tratta di un intreccio necessario di prospettive che nel metodo del Relational Social Work (Folgheraiter, 2011) vanno a costruirsi attorno a un’etica della cura che si rende necessaria per agire una dimensione del controllo che non cada fine a sé stessa, ma sappia inserirsi in una più ampia progettazione di aiuto. Si tratta di un’etica della cura che diviene reciprocità di cura nel momento in cui gli operatori, di fronte a un problema sociale, cercano di intercettare la cura già esistente nei soggetti interessati e coinvolti in una determinata storia di vita, mettendosi in asse con la care emergente e divenendo a loro volta espressione di care nella costruzione di una relazione di aiuto (Folgheraiter, 2011, 2016). Si apre dunque una riflessione necessaria sulla costruzione di progetti di aiuto che vertano sulla reciprocità e sulla partecipazione, per meglio comprendere come la frequenza a spazi dedicati alle donne senza dimora possa favorire o meno l’espressione autentica delle voci di queste donne, a partire dai meccanismi di accesso. Il tema dell’ascolto viene dunque ripreso nell’analizzare contesti che permettono di arrivare ai temi dell’advocacy e della partecipazione, possibilità prospettate in accompagnamento a una ristrutturazione dell’agire professionale in ambito sociale, che permetta un ripensamento dei servizi, in una ricostruzione sociale dell’altro che consenta dignità e diritti in un obiettivo di riconoscimento (Juhila, 2009). Tale ristrutturazione parte da nuove prospettive che passano dalla relazione, da un lavoro sociale in ottica anti-oppressiva e che si pone come essenza della reciprocità (Dominelli, 1998, 2017; Folgheraiter, 2011; Krumer-Nevo, 2021a). Lo stesso concetto di advocacy viene riletto in una prospettiva che prova a mettere al centro le esperienze e le prospettive proprio di queste donne, riscoprendo l’importanza della motivazione e della restituzione del potere decisionale, per dare un motore al cambiamento. Wright e Jaffe (2014) definiscono l’advocacy come un’azione che consiste nell’usare la propria voce per parlare in nome di qualcuno che da solo non riesce a farlo. Si tratta tuttavia di un termine controverso, dalla difficile traducibilità in italiano senza perdere i significati di senso che lo accompagnano. Si tratta di parlare a sostegno e ridare voce a persone e gruppi fragili che rischiano di non essere considerate dagli operatori e da chi dovrebbe prendersi cura di loro anche per la condizione di vulnerabilità nella quale si trovano, e per la mancanza di informazione e consapevolezza su quelli che sono i loro diritti. (Calcaterra, 2014). Si apre quindi il tema di un cambiamento possibile che parta dal riconoscimento di forme nuove e spesso non riconosciute di ripresa di voce e di partecipazione che muovono i primi passi all’interno dei servizi e rendono possibile nonché necessario l’ampliamento di una riflessione più strutturata in merito, a partire da una ricerca che sappia rendersi fertile per il riconoscimento di queste nuove prospettive (Curry-Stevens, 2012; Juhila, 2008). Lo studio in questione nasce dal desiderio di comprensione dei processi di partecipazione e di advocacy, che possono rendersi possibili all’interno dei servizi territoriali destinati a queste donne, per meglio capire come tali meccanismi siano percepiti e vissuti dall’interno. Lo sguardo che emerge nell’analisi di tale bacino è critico e attuale, a partire da una prospettiva concreta sulle prime esperienze e i primi servizi che portano le donne senza dimora e i professionisti interessati a muoversi tra partecipazione e processi di advocacy.
Il contesto della ricerca: Caritas Bergamasca e Spazio Irene
Nel 2014 in Italia le persone senza dimora risultano essere 50.724. Così emerge dal Piano di ricerca nazionale promosso da fio.PSD, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Caritas Italiana e Istat (Istat, 2014). Dai risultati della terza edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni svolta nell’autunno 2021 invece il numero ammonta a 96.197 (Istat, 2021). Questo drastico aumento dei numeri non è però dovuto a un’esponenziale crescita del fenomeno, bensì dallo svolgimento di una più accurata indagine, grazie a strategie che hanno permesso di raccogliere i dati in maniera più precisa, aiutando a far emergere un fenomeno che per anni è rimasto nell’ombra, così come le persone che lo vivono, le quali spesso divengono gli «invisibili della strada» quando non ci sono documenti e diritti a segnare la loro presenza sul territorio (Leonardi, 2021). Delle 96.197 persone censite nel 2021 inoltre, 30.832 sono donne, eppure a questa componente, ancora più sottostimata della componente maschile, come affermato da Fio.PSD e dai servizi interessati, si dà ancora meno attenzione. Dai dati dell’indagine Istat del 2014 si stima che le donne in Italia rappresentino il 14,3% delle persone senza dimora, di cui il 54% è rappresentato da donne straniere e si concentrano in un’età media di circa 45 anni. Il 28% ha un lavoro, quasi sempre nell’economia sommersa, che permette loro di guadagnare in media 330 euro al mese, insufficienti per fuoriuscire dalla condizione di disagio e povertà in cui si trovano. Tra le cause scatenanti si riconosce per il 27,6% dei casi la presenza di forme di disabilità, dipendenze da alcool e sostanze e di malattie croniche; nel 49,7% dei casi la perdita del lavoro, o di un lavoro stabile; nel 70% dei casi la condizione è riconducibile a rotture famigliari. I dati sulla violenza sono scarsi e non sono in grado di fornire un quadro esatto del fenomeno, ma circa il 47% dei servizi che si occupano di persone senza dimora dichiarano di avere in carico donne vittime di violenza, che necessitano di interventi di protezione, accoglienza e tutela specifici; aprendo la strada a una riflessione che richiede di tenere in considerazione anche questa componente spesso sottostimata e invisibile (Bretherton, 2020; Guide for Developing Effective Gender-Responsive Support and Solutions for Women Experiencing Homelessness, 2021). All’interno di tale panoramica nazionale, la presente ricerca vuole provare a fornire un quadro su quella che è la situazione delle donne senza dimora che usufruiscono dei servizi nella città di Bergamo.
I risultati della terza edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni svolta nell’autunno 2021 da Istat fornisce per la prima volta statistiche Comunali sulla presenza di persone senza dimora nei diversi territori. Si tratta di cifre che si presentano come maggiormente accurate rispetto a quelle condivise negli anni precedenti, ma che continuano a sottostimare un fenomeno che si dimostra difficile da rilevare con precisione soprattutto nella sua componente femminile. Tale Censimento rileva la presenza di 949 persone senza dimora sul suolo bergamasco, di cui 433 donne, fornendo un rapporto uomini-donne meno sbilanciato rispetto al dato nazionale. Nonostante l’inesattezza delle stime tali dati si pongono alla base di riflessioni che evidenziano l’assenza anche nel contesto bergamasco di servizi rivolti alle donne senza dimora, capaci di attenzioni specifiche alla loro componente di genere e ai loro vissuti di violenza e vittimizzazione (Bretherton, 2017; 2020). A Bergamo, infatti, nel 2021 l’unico servizio dedicato alla specificità delle donne senza dimora risulta essere il Dormitorietto, dormitorio femminile gestito da Caritas Bergamasca in collaborazione con l’Istituto delle Suore Poverelle, provvisto di 7 posti letto per la notte, minimi rispetto ai numeri rilevati e agli ulteriori non rilevati relativi alle donne prive di una casa o di una casa adeguata sul territorio bergamasco. Le riflessioni sull’inadeguatezza dei servizi proposti si espandono a seguito della pandemia da covid-19, portando al nascere di una nuova consapevolezza su un fenomeno che rimane spesso nell’ombra anche sulla scena internazionale (Bova, 2022; Guide for Developing Effective Gender-Responsive Support and Solutions for Women Experiencing Homelessness, 2021), e contribuendo nei mesi successivi all’ideazione e all’apertura di un servizio nuovo: Spazio Irene.
Spazio Irene è un servizio nato nel settembre 2021 all’interno di Caritas Bergamasca. Si tratta di uno spazio aperto settimanalmente ogni lunedì presso il Galgario, ex-convento nel centro città. Nasce come servizio specificatamente rivolto alle donne che vivono o che si sono trovate a vivere nella condizione di non avere una dimora, o una dimora adeguata, costituendosi come spazio libero dove queste donne possono accedere alla presenza di un’operatrice e di alcune volontarie. Irene dal greco significa pace, o tempo di pace, ed è stato scelto a nome di uno spazio che vuole porsi a riscatto dell’immagine di queste donne, partendo dal sogno e dalla speranza che un luogo nuovo sia possibile e sia realizzabile grazie a un impegno collettivo, per ridare attenzione e cura a un fenomeno che spesso viene ignorato all’interno della scena pubblica, politica, economica e sociale (Casey et al., 2008). Spazio Irene si pone come luogo sicuro per creare un contesto, fisico e relazionale, che ridia presenza a donne che all’interno dei servizi finiscono spesso per venire annullate, o dai quali tendono in primo luogo ad allontanarsi per distaccarsi da esperienze di violenza e vittimizzazione alle quali sono esposte all’interno degli stessi (Bretherton 2 Mayock, 2021b). È un servizio che viene presentato all’interno dei documenti progettuali come uno spazio alternativo alla strada, svincolato dai meccanismi di scelta ed esclusione e per questo aperto a tutte, offrendo la possibilità di «stare» e di «essere» protagoniste di attività e di relazioni di vicinanza che provano ad essere un primo passo per «motivare al cambiamento e operare una rottura con i legami e con i ritmi della strada».4 Spazio Irene in questi anni ha messo a disposizione delle donne prive di una dimora sul territorio bergamasco un luogo di incontro e pianificazione, dove la scelta si pone centrale fin dalla dimensione del libero accesso, lasciando la possibilità di decidere se partecipare alle attività proposte o meno, riconoscendo i vissuti, le difficoltà e la dimensione di incertezza che è propria delle loro storie di vita, in un tentativo di rifornire la possibilità di imparare la partecipazione e l’impegno, a partire dalla relazionalità (Folgheraiter, 2011; Warren, 2007). In questo contesto, scaturito dal sogno e dalla speranza in un sistema nuovo che ridia importanza a strati invisibili della popolazione, la dimensione dell’aiuto e del controllo tendono a fondersi e a mischiarsi in diversi processi. La dimensione dell’aiuto, la quale si configura nella possibilità di scegliere se accedere e partecipare al servizio, in alcuni casi va infatti a fondersi con una dimensione maggiormente di controllo, nel momento in cui la frequenza allo spazio diviene necessaria e precondizione per l’accesso ad altre prestazioni previste da progetti definiti in collaborazione con gli operatori del Centro di Primo Ascolto di Caritas Bergamasca, in rete con le altre realtà territoriali.
Dal 2021 a Spazio Irene sono passate circa 50 donne senza dimora, e al suo interno sono stati attivati diversi progetti e collaborazioni, permettendo un ampliamento della rete e una maggiore consapevolezza sul fenomeno delle donne senza dimora che passa dalla condivisione e dalla conoscenza. Ciò consente nel tempo di riconoscere maggiormente queste donne come partner attive del progetto e come risorsa di crescita e miglioramento, ampliando sempre più gli spazi di parola che ad oggi hanno permesso l’attivazione di nuove collaborazioni e la creazione di uno Spazio nel quale le attività sono proposte, pensate e in parte gestite dalle stesse donne con il supporto degli operatori e delle volontarie.
All’interno di Spazio Irene sono state poi organizzate diverse iniziative, tra le quali un percorso teatrale sui desideri, un progetto di teatro sociale e un percorso in accompagnamento con una psicologa specializzata incentrato sull’essere donna. É stato inoltre costruito insieme un progetto in collaborazione con il Laboratorio Tantemani per la creazione di un editoriale dedicato a Spazio Irene, La Bandita, ideato e realizzato insieme alle ospiti.
Finalità e obiettivi della ricerca
La ricerca mira a esplorare come Spazio Irene possa favorire processi di advocacy e empowerment tra le donne senza dimora, investigando se e in che modo il servizio sia in grado di promuovere l’espressione delle loro voci e influenzare un reale cambiamento all’interno delle politiche sociali territoriali. L’interesse per questa ricerca nasce da un anno di osservazione e collaborazione come volontaria e stagista, da dicembre 2022 a dicembre 2023, durante il quale sono emerse dinamiche di partecipazione e di ripresa di voce tra le donne ospiti del servizio.
La domanda centrale alla ricerca si pone come obiettivo quello di comprendere quanto e come Spazio Irene favorisca l’espressione della voce delle donne senza dimora, promuovendo processi di advocacy e di empowerment, ma anche la costruzione di nuovi percorsi e nuovi servizi.
La ricerca esplora la percezione della dimensione di partecipazione da parte delle donne ospiti, cercando di comprendere come l’accesso e la frequenza al servizio possano essere un veicolo per la costruzione di un dialogo collettivo, sia a un livello interno al gruppo, che su un piano maggiormente comunitario. L’obiettivo centrale rimane quello di analizzare e osservare la formazione di nuove collaborazioni e reti di supporto interne, per provare a comprendere come queste possano diventare motori per cambiamenti concreti, favorendo una maggiore visibilità e comprensione delle condizioni di vita delle donne senza dimora.
Metodologia utilizzata per la ricerca
La metodologia di ricerca si basa su un approccio di tipo qualitativo, il quale impiega una prospettiva interpretativa che si concentra sulla comprensione delle realtà sociali attraverso le esperienze e le rappresentazioni soggettive degli individui. L’obiettivo della ricerca qualitativa è quello di esplorare e interpretare il mondo attraverso l’interazione tra ricercatore e partecipanti, riconoscendo la pluralità delle realtà sociali. Questo approccio si distingue per l’indagine dell’esperienza privata e dei significati attribuiti dagli attori sociali, e si inserisce in una tradizione costruttivista che enfatizza la conoscenza contestualizzata e dinamica dei fenomeni. Il fenomeno delle donne senza dimora, in particolare, viene esplorato attraverso le voci delle partecipanti, per offrire una comprensione più autentica e una rappresentazione che sfidi le visioni standardizzate (Flick, 2018).
La ricerca si è basata su due principali strumenti qualitativi: l’intervista semi-strutturata e l’analisi documentaria. L’intervista, che ha permesso di esplorare opinioni e vissuti soggettivi, è stata condotta con un approccio flessibile e poco direttivo, per raccogliere narrazioni libere e autentiche. Le interviste si sono concentrate su temi legati alla partecipazione, all’ascolto e al cambiamento, e sono state somministrate a nove donne ospiti del servizio Spazio Irene. L’analisi documentaria, che ha coinvolto documenti istituzionali e mediatici, ha contribuito invece a contestualizzare i dati emersi, mettendo in luce discontinuità e lacune nei documenti che regolano il servizio (Boeije, 2010).
Le donne intervistate sono state selezionate attraverso un processo di campionamento a scelta ragionata, che ha privilegiato donne con diverse esperienze di emarginazione sociale e con una partecipazione attiva al servizio Spazio Irene. La partecipazione alle interviste è stata infatti proposta alle varie donne che in quel periodo frequentavano con costanza Spazio Irene, ottenendo l’adesione volontaria di 9 donne, differenti tra loro per età, storia ed esperienze di vita. Questa scelta ha permesso di accedere a differenti mondi di significato e di raccogliere testimonianze ricche di esperienze personali, fondamentali per il contesto della ricerca.
A conclusione delle prime fasi, l’analisi dei dati raccolti si è configurata come processo riflessivo, il quale ha combinato la rilettura delle trascrizioni delle interviste con la comparazione dei dati documentari, al fine di individuare categorie di significato utili a rileggere quanto emerso. La fase analitica ha permesso di individuare categorie ricorrenti nelle risposte delle intervistate, restituendo un quadro interpretativo del fenomeno a partire da un’analisi della letteratura presente, la quale ha trovato in parte concretezza nelle testimonianze delle donne intervistate. Sebbene i risultati siano specifici al contesto di Spazio Irene e non generalizzabili su in piano più ampio, offrono una visione attuale e concreta delle esperienze vissute dalle donne senza dimora, un gruppo spesso marginalizzato all’interno della ricerca internazionale (Glumbíková et al., 2019; Juhila, 2008; Leonardi, 2021).
Presentazione dei risultati della ricerca: tra partecipazione e processi di advocacy
L’analisi dei risultati emersi diviene una lettura che si trasforma in narrazione nel momento in cui, a partire dalla rilevazione di dati e notizie, consente di restituire il mondo osservato attraverso lo sguardo delle persone intervistate (Della Porta, 2010). I risultati riportati in seguito seguono il corso delle categorie emerse, le quali, a partire dalla domanda di ricerca, hanno consentito una presentazione delle strutture di significato e delle percezioni soggettive delle partecipanti.
La partecipazione come scelta e apprendimento
Dal punto di vista degli operatori la partecipazione viene spesso delineata come diritto, come compito dei professionisti, in una cornice che la avvicina al concetto di compliance,5 cedendo a una necessità di aderenza al progetto e alle proposte da parte delle persone, le quali in questo modo favoriscono la buona riuscita dei percorsi di aiuto. Una reale partecipazione però è quella che comporta reciprocità, nel momento in cui ogni parte in gioco viene migliorata dal contributo dell’altra; e comporta redistribuzione di quello che è il potere decisionale e di azione, il quale si realizza anche nella possibilità della scelta, come riportato di seguito:
Partecipare è una scelta credo, io ho scelto di non partecipare, poi magari a qualcosa partecipo, dipende. […] All’inizio non partecipavo con la psicologa perché nelle diverse comunità mi hanno sempre obbligata a fare queste cose e per me sono inutili (Intervista 6).
Scelta che a volte ricade nella non partecipazione nel momento in cui nelle esperienze pregresse la partecipazione stessa è stata appresa in un’ottica di controllo come obbligo e precondizione per l’aiuto e la cura. Una scelta che può divenire al contempo riapprendimento di una partecipazione possibile che si rifondi appunto su una reale reciprocità, oltre che su di una redistribuzione del potere, spesso detenuto unicamente dai professionisti.
In strada a volte impariamo una libertà del disimpegno no? Non c’è una casa e non c’è un lavoro, a volte non si fa niente […]. Poi diventa difficile stare alle regole no? Rispettarle. Bisogna imparare di nuovo a rispettare alcune cose. Partecipare a tutte le proposte non è facile, è bello se vuoi cambiare ma non tutti vogliono, qualcuno sceglie di stare in strada e allora sceglie la libertà del disimpegno (Intervista 2).
L’idea della partecipazione come scelta e come potere di scelta presentata nel concetto che viene delineato come «libertà del disimpegno», riporta il ragionamento sulla necessità di imparare una partecipazione nuova sia per gli operatori che per le persone. Un apprendimento in ottica di reciprocità che consenta di immaginare insieme una partecipazione orientata ad agire anche su un livello di sistema, agendo sulla struttura dei servizi e delle professionalità, riconoscendo la possibilità di una libertà nuova che può iniziare proprio dalla partecipazione.
Noi non abbiamo potere, stare «fuori» non è la vera libertà. Viviamo una vita da detenute fuori dalle carceri. […] Viviamo in un mondo maschile, in un mondo di violenza e di cose rotte. Come in stazione, a volte sembra tutto rotto. […] Partecipare alle attività è un impegno ma ci ridà dignità, possiamo scegliere qualcosa che non è la strada, è bello ascoltare cosa vogliono fare le altre e poi magari lo facciamo davvero, però serve tempo e quello boh serve per altre cose (Intervista 4).
Ritornano qui i temi della libertà, della scelta, della violenza in una componente di genere che si rende pervasiva nella dimensione della strada. La partecipazione che viene riappresa come impegno e come riscatto, ma i cui tempi vanno a scontrarsi con i tempi della quotidianità di storie di vita precarie.
La paura del tempo che passa emerge come tema condiviso nelle diverse interviste, nello scontro tra un tempo desiderato di cambiamento e i tempi burocratici che sono richiesti per un cambiamento reale. Ciò che emerge dalle interviste sono i primi passi verso una partecipazione che richiede tempo per essere realmente compresa e appresa, un tempo che spesso fatica ad essere investito perché assorbito dai bisogni della strada. Serve pazienza e costanza in un percorso che può essere costruito insieme coniugando voci diverse che scelgono come esporsi, un percorso che richiede un supporto e un riconoscimento istituzionale ancora assente nei documenti del servizio, ma necessario per un cambio di prospettiva che parta dalla partecipazione come reciprocità. Sono infatti la dimensione del tempo e dell’incertezza quelle che tornano nelle parole di una delle donne intervistate:
Mi fa paura aspettare, il mio obiettivo è quello di stare meglio ma è lontano e faticoso e questo mi angoscia. Non so cosa succederà mentre aspetto perché magari potrei mollare di nuovo (Intervista 9).
Prendere voce: i processi di advocacy e l’ascolto
La dimensione della partecipazione riporta al tema del diritto all’ascolto e al tema dell’advocacy e dei processi di ripresa di voce che danno attuazione a questo diritto, rimettendo al centro il punto di vista delle persone protagoniste dei percorsi di aiuto. Prendere voce in un’ottica di partecipazione su un piano decisionale e attuativo richiede innanzitutto di fondare la relazione tra donne e operatori su un ascolto autentico che in ottica di reciprocità sappia legittimare un clima di fiducia senza pre-condizioni. L’ascolto si lega nuovamente al tema della cessione di potere da parte degli operatori che diviene imprescindibile per un operare nuovo e relazionale, un ascolto che sa dare valore alle voci e ai punti di vista delle persone senza pretendere di detenere a priori risposte attuative e risolutive. Nello stralcio che segue, la donna afferma che:
Quando ero senza un reddito, dopo la Legge Fornero, mi sono rivolta ai servizi, al Comune, agli assistenti sociali. La loro risposta è stata mandarmi da uno psicologo, ma io non stavo chiedendo quello (Intervista 3).
Ricevere risposte da parte degli operatori che si discostano da ciò che viene chiesto e presentato, anticipazioni e interpretazioni stereotipate che cercano di dare spiegazioni invece che mettersi in ascolto, risultano essere esperienze comuni per le donne che si sono rese disponibili alle interviste. Si parla di un ascolto che veicola giudizio anziché diritti e che riporta invece a una dimensione di scelta che richiede di essere riconosciuta come capacità di azione.
Vorrei che le persone non parlassero della vita degli altri, smettendo di giudicare. Vorrei capissero che vivere in strada non è un gioco, a volte è una sfida, a volte è anche una scelta (Intervista 5).
Scelta che richiede di essere ascoltata e tenuta in considerazione nel riportare le voci e le prospettive di queste donne in una cornice comunitaria e di cambiamento, basando il riconoscimento sociale su una conoscenza reciproca, che dalla vicinanza sappia dare inizio a una relazionalità nuova.
«Penso di essere ascoltata in Spazi come questi, ma non sempre, forse dipende più dalle persone. Gli assistenti sociali non ascoltano mai» (Intervista 2).
Viene riportata qui una difficoltà nel costruire spazi autentici di fiducia e di ascolto che si basa su stereotipi che si muovono in modo bidirezionale quando gli operatori agiscono secondo un approccio che tende spesso a improntarsi su assistenzialismo ed efficienza anziché sulla costruzione di una relazione autentica che dia spazio alla condivisione di prospettive e significati possibili. Eppure in queste frasi l’ascolto sembra nascere dall’incontro individuale tra due persone e non tanto dall’incontro con un solo professionista, e richiede dunque che si attui un cambio di prospettiva e di approccio da parte degli operatori sociali.
Viene riportata inoltre, nei racconti delle donne, una struttura del servizio che si trova in un processo di cambiamento che possiamo ritrovare nell’evoluzione delle forme di advocacy descritte da Juhila (2008). Da possibilità di azione e di presa di voce detenute dagli operatori del servizio alle sue origini, come presentato anche dai verbali che lo descrivono come «uno spazio per allontanare le donne dalla strada», si passa nel tempo a una possibilità di azione in parte condivisa, dove l’ascolto diventa la base per progettazioni nuove che sappiano ascoltare la strada invece che cercare di allontanarla a priori come sbagliata. Da forme di advocacy che vedono le donne in un ruolo maggiormente passivo e di consultazione, identificando negli operatori i conoscitori e promotori dei bisogni, si passa gradualmente a forme di advocacy che grazie a dinamiche di partnership tra ospiti e professionisti ricalcano un desiderio di cambiamento che parte dal ricercare un riconoscimento sociale spesso negato, sottolineando il ruolo della comunità come essenziale per portare avanti processi di ristrutturazione dei servizi e delle politiche.
Emerge poi un desiderio di riconoscimento e di cambiamento che può rendersi possibile grazie alla motivazione che si attiva nell’empatia che solo la conoscenza reciproca può avviare, come afferma la donna in questo stralcio:
In strada se io tipo, se io chiedo che ore sono, qualcuno si allontana e non mi risponde neanche. È vero io a volte chiedo i soldi ma a volte voglio solo sapere che ore sono e loro mi guardano male. […] Io voglio parlare con loro per dire che sono una persona, poi abbiamo provato con il giornale e le altre cose ma bisogna guardarsi in faccia! (Intervista 1).
Eppure sono desideri che spesso rischiano di arenarsi nella sfiducia nella possibilità di cambiamento, la quale si reitera nella dimensione del tempo e delle aspettative
A volte manca complicità e continuità, così i progetti possono far fatica ad andare avanti. […] Si parla sempre ma poi? Tanto non si fa mai niente (Intervista 7).
Sorge però nelle riflessioni estrapolate dalle interviste una dimensione di ripresa di voce che si manifesta anche nel presentare in maniera esplicita la propria opinione e i propri desideri, le riflessioni e le speranze sul servizio e sulle politiche che riguardano queste donne. Si rivelano come concrete forme di advocacy che risultano ibride e non definite ma che si rendono capaci di presentare e rendere visibili le prospettive delle ospiti di Spazio Irene, sia nell’ideare le attività del servizio che nel ragionare insieme su cosa non funziona, permettono una dimensione di ripresa di voce e di ascolto che necessita di essere approfondita dagli operatori, per giungere a una strutturazione e a un riconoscimento che si metta a supporto nel renderla strumento del servizio e del cambiamento.
Il rapporto con gli operatori del servizio
Come abbiamo visto emergere dalle interviste, le forme di advocacy che vengono a crearsi all’interno del servizio partono da dinamiche spontanee di presa di consapevolezza delle ingiustizie subite e della possibilità di partecipazione che viene ri-appresa, ma dipendono anche dal ruolo e dalla relazione con gli operatori all’interno dei servizi, i quali possono svolgere un compito importante nel favorire processi di empowerment e di ripresa di voce. Si tratta della necessità di adottare una nuova prospettiva che non metta il focus sulla dimensione patologica del fenomeno ma su quella delle risorse, entrando in dialogo con le donne ospiti del servizio. È un approccio che a tratti sembra fare ancora fatica a prendere piede all’interno del servizio, soprattutto per mancanza di operatori e di una formazione più specifica in merito.
Quando mi dicono «ti vedo bene» a volte fa male, perché io magari non sto bene. […] Non è che se ho avuto la fortuna di avere la casa di proprietà allora va tutto bene, ho un sacco di problemi e qui posso parlarne e stare con voi però non sto bene (Intervista 3).
Nelle parole di diverse donne torna il tema dell’ascolto in relazione agli operatori del servizio, un ascolto che non dia per scontato ma sappia domandarsi sempre e sappia riconoscere le dinamiche complesse che compongono il benessere, tra le quali emerge la dimensione della relazione e del legame. Una cura alla quale a Spazio Irene sembrano spesso sovrapporsi altri repertori, tra cui quello dell’offerta dei servizi (service provision) e della terapia (therapy), che per mancanza di tempo e di risorse non sempre riescono a rinforzarsi mutualmente ma rischiano di escludere altre possibilità relazionali.
Io al Punto Sosta nel pomeriggio non ci sto, infatti appena abbiamo finito [a Spazio Irene] vado subito. […] Ci sono tutti i maschi che ci cacciano dai divani e fanno casino. […] Sì, ci sono gli educatori però non sempre vedono e se glielo dici ti dicono di non pensarci e allontanarmi. Cioè, io devo allontanarmi? Quelli mi seguono io voglio stare in pace (Intervista 8).
Ri-emerge tra le righe il problema della mancanza di tempo e di risorse, rischiando di mettere in secondo piano una care che si rende imprescindibile secondo quell’etica della cura a base delle professioni sociali. Ed è una cura che deve partire dal dialogo, un dialogo che passa dalla motivazione e dalla riflessione, e di nuovo dall’ascolto, anche per le scelte che appaiono più semplici e che spesso vengono date per scontate. Un dialogo che si mette in discussione per non fermarsi a una negazione ma per costruire insieme nuove risposte.
Avevo proposto una partita a pallavolo qui tutte insieme ma hanno detto di no perché rischiamo di rompere tutto e bla bla. […]. Ma dai una palla di spugna si poteva fare, ci dicono di proporre ma poi approvano solo quello che vogliono loro [gli operatori], a me una palla non sembra così pericolosa, dobbiamo tenerci giovani se no che noia! (Intervista 5).
A volte invece si riesce a costruire insieme un repertorio relazionale nuovo, che si basa sulla reciprocità oltre che sulla cura, nel momento in cui si apprende insieme e si riconosce fallibili, permettendo di contro alle persone che abbiamo di fronte di riconoscersi competenti, anche a partire dalla semplicità dei primi movimenti, i quali, consentendo di sperimentare i primi successi nella partecipazione, possono sostenerne la legittimazione e il miglioramento nel tempo.
Le sciarpe mi sono piaciute perché le abbiamo fatte insieme. Poi è stato divertente perché le ho proposte io e E. [volontaria] non era capace. Le ho insegnato io, lo facevo con mia nonna (Intervista 6).
L’accesso al servizio tra aiuto e controllo
Le dimensioni dell’aiuto e del controllo ritornano anche nelle narrazioni sull’accesso ai servizi, dove in particolare la dimensione del controllo in alcune storie va a contrapporsi a esperienze di accompagnamento o di libero accesso. La funzione del controllo, per quanto parte del lavoro sociale, risulta problematica ogni qualvolta si accompagni a una considerazione passiva della persona. Si tratta di una problematicità che va a intaccare anche la dimensione etica nel momento in cui prospetta una conoscenza a priori di quello che è il bene del soggetto, in direzione del quale tale controllo viene agito. Un aspetto comune riconducibile agli interventi di controllo è la mancanza di una piena collaborazione da parte della persona, anche a causa di una condivisione che si limita ad essere comunicazione e non reale partecipazione in un’ottica di aiuto.
Io sono stata obbligata a venire, a me non frega niente. Lo sanno che io dentro ai progetti non ci sto, il mio posto è la strada e non lo accettano. […] Che ne sanno loro. […] Mi hanno detto che se non partecipavo a Spazio Irene mi mandavano via dalla Comunità, ma tanto non reggo neanche lì, ho retto già troppo. […] Si alla fine non è così male qui però mi dà fastidio che sono obbligata (Intervista 9).
Emerge qui un’azione di controllo che non ha saputo entrare in relazione per un ascolto autentico, pur agendo in direzione di quello che viene proiettato come l’interesse della persona e della collettività. Viene presentato un controllo nell’accesso per una persona che, vivendo il fenomeno dell’homelessness nelle sue sfaccettature di genere si trova da anni svincolata da obblighi e regole, perseguendo una forma di «libertà del disimpegno» presentata in precedenza, qui nettamente contrapposta a una richiesta messa a precondizione di un servizio. Sembra qui mancare una azione di advocacy che sappia riportare davanti ai servizi la voce di una persona che ad ora non condivide un percorso di aiuto che è stato a lei presentato. Le dinamiche di accesso al servizio però risultano essere molteplici e la maggioranza delle donne intervistate descrive processi di avvicinamento al servizio volontari e graduali, i quali riportano anche alla dimensione del gruppo e della rete relazionale come risorsa.
Ho conosciuto Spazio Irene perché ne parlavano in dormitorio. So che veniva F. [altra donna ospite di Spazio Irene] e un giorno siamo venute insieme dopo il Drop In (Intervista 6).
Me ne hanno parlato al Centro di ascolto in Caritas. […] Mi piace perché siamo solo noi e possiamo stare tranquille. […] Abbiamo imparato cose nuove come i gioielli e le sciarpe, ma io sto scrivendo un libro di poesie e farlo per il giornale [Bandita] è stato bello (Intervista 4).
Non mi ricordo come lo ho conosciuto, vengo qui da sempre, ma vengo da sempre anche al Punto Sosta. […] Però mi piace, perché siamo tra donne e possiamo essere noi stesse. […] Ora ho la casa ma non si sa mai, e poi lì sono sola, la casa non basta servono anche le persone (Intervista 7).
La dimensione dell’accesso viene presentata dai documenti come agita in collaborazione con gli operatori del Centro di Ascolto, con i quali vengono elaborati percorsi di aiuto individualizzati che spesso riconoscono l’utilità della frequenza a Spazio Irene ai fini dell’inclusione sociale e della partecipazione in un contesto nuovo e di cura.
Dialogo con la comunità e le istituzioni
Il contatto con la comunità è iniziato gradualmente da un desiderio di riconoscimento e riscatto sociale che ha portato all’emergere di riflessioni sull’incontro e la conoscenza per un fare insieme in ottica di cambiamento.
Per dire che noi esistiamo. […] Siamo persone non possono guardarci così (Intervista 1).
Vorrei che le persone vedessero la realtà e non solo quello che vogliono vedere. Che provassero a mettere le mie scarpe in quel momento della mia vita. Loro cosa farebbero? A volte da fuori è facile giudicare. […] Io nel giornale volevo mettere la mia storia e chiedere proprio a loro di dirmi cosa avrebbero fatto al mio posto. […] Lo so che non mi serve la loro approvazione però sono curiosa, secondo me non saprebbero cosa dire (Intervista 9).
Un desiderio di incontro e di narrazione che pone il focus sulle cause strutturali e sistemiche del fenomeno, nel tentativo di allontanare la visione pubblica dal focus che tende a colpevolizzare le donne e le persone in condizione di non avere una dimora come esiti di scelte sbagliate e fragilità individuali. Il desiderio portato avanti di riconoscimento sul suolo pubblico, in condizioni nelle quali l’esistenza su un piano politico, amministrativo e di ricerca viene ignorata, si pone come obiettivo anche quello di combattere i diffusi processi di alterizzazione, per riscoprire una vulnerabilità che ci accomuna in quanto esposti a una serie di rischi strutturali, i quali possono andare a incidere sulle traiettorie individuali di vita. Si tratta di una conoscenza che permette empatia nelle sue sfaccettature di vulnerabilità condivisa e di agente motivazionale e che consente di agire nella stessa direzione, rendendosi conto delle ingiustizie e dei processi di oppressione in atto.
Con le parrucchiere è stato divertente perché erano simpatiche, io avevo l’unico maschio, all’inizio non parlava non mi fidavo molto però poi era simpatico. […] Ai giovani di solito piaccio riesco a parlarci (Intervista 8).
L’incontro che passa dai piccoli passi e riesce ad abbattere una diffidenza che agisce in senso bidirezionale e che richiede una conoscenza reciproca in ottica relazionale, aprendo la possibilità di ampliare la rete di soggetti preoccupati e motivati al cambiamento, a partire dal desiderio di collaborare anche con la parte politica. Si tratta di richieste e riflessioni che già si identificano in azioni e processi di advocacy che vanno proprio a riprendere la riflessione sui catalizzatori motivazionali iniziata da Goodman, nel tentativo di influire direttamente sulle politiche e andando a incidere sui sistemi organizzativi grazie alla collaborazione delle persone coinvolte nei sistemi di aiuto.
Vogliamo incontrare le persone potenti, i politici, perché forse se ci conoscessero meglio farebbero qualcosa di diverso (Intervista 1).
Le azioni di advocacy qui presentate, pur muovendo i primi passi, si realizzano in una forma che, esprimendo preoccupazioni e desideri, possono rendersi capaci di attivare diversi aspetti motivazionali che possono portare i gruppi privilegiati a ingaggiarsi in una maggiore partecipazione per una nuova influenza sulla pratica politica, a partire da una nuova consapevolezza sui diritti che parta proprio dall’ascolto di queste voci.
A volte sembra banale chiedere come stai ma è bello. In strada spesso se lo chiedi ti sorridono. […] Nessuno ce lo chiede mai (Intervista 9).
Il gruppo come spazio e come risorsa
I percorsi di vita delle donne di Spazio Irene le hanno portate nella maggior parte dei casi a una disconnessione sociale e dei legami affettivi e relazionali, andando ad aggravare la condizione di esclusione sociale e di emarginazione nella quale si trovano in quanto donne senza dimora. Tale disconnessione può portare, in concomitanza alle esperienze di abuso e violenza, a interiorizzare vissuti di sfiducia negli altri, i quali si accompagnano a una rottura nel senso di autostima e di auto-efficacia. Esplorando il contesto gruppale tramite le interviste è emerso nella maggior parte dei casi come la dimensione del gruppo, composto unicamente da donne che vivono o hanno vissuto il fenomeno dell’homelessness, possa aiutare a sviluppare un senso di appartenenza e un riconoscimento, nonché un’accettazione, che difficilmente riescono a trovare in operatori e volontari.
A teatro cercavo di guardare negli occhi M. e C. [altre donne ospiti di Spazio Irene] e non voi [volontari e operatori] perché loro vedono come me (Intervista 2).
Si tratta di un riconoscimento che parte dall’aver vissuto esperienze di vita simili, andando a spezzare i vissuti di solitudine e frammentazione identitaria, riconoscendosi in percorsi famigliari, la cui narrazione permette la creazione di uno spazio mentale sicuro in cui ri-narrarsi ed entrare in relazione in assenza di giudizio. In tal senso la dimensione del gruppo e del confronto risulta essere una nuova possibilità di riapprendimento relazionale, per imparare insieme come muoversi in relazioni positive di confronto e dialogo che possono permettere la rielaborazione dei traumi. L’attenzione, nella creazione del gruppo in uno spazio prospettato come sicuro, è quella di non svilire di contro i legami relazionali e di gruppo esperiti nella dimensione della strada, i quali, seppur molte volte luogo di violenze e oppressione, si rivelano essere spesso una risorsa per la sopravvivenza, attivando processi di identificazione che al pari permettono di spezzare parzialmente i vissuti di solitudine.
Non capiscono [gli operatori] che la strada è il mio posto. Solo loro capiscono cosa provo e cosa ho passato ma fanno di tutto per tenermi lontana dalla strada (Intervista 9).
Si parla di un tentativo spesso portato avanti dagli operatori di spezzare i legami di strada tramite la presa di distanza, per allontanare legami individuati come violenti e abusanti, i quali però sono spesso vissuti dalla donna come unica ancora alle origini e come relazione presente nei momenti difficili, soprattutto con persone le quali si sono trovate nella stessa situazione. Si tratta di tentativi di spezzare processi identitari che hanno le loro origini proprio in queste relazioni e che per questo necessitano di riconoscimento, dialogo e di nuove esperienze per porsi a base di legami che si rendano emancipanti, consentendo empowerment e processi di advocacy, anche collettivi. Riprendendo una frase che viene usata a presentazione di diversi servizi di Caritas Bergamasca destinati alle persone senza dimora, il loro obiettivo pare essere quello di «motivare al cambiamento e operare una rottura con i legami e con i ritmi della strada», ma una rottura con tali legami non sempre può essere possibile quando, secondo un agire relazionale, bisogna essere in grado di riconoscere la risorsa che tali legami hanno saputo essere, per puntare a una loro trasformazione piuttosto che a un netto allontanamento in senso coercitivo.
Mi piace perché ci sono R. e G. e sono delle grandi, mi fanno ridere G. è matta. […] Cerco di tenerla fuori dai guai ma sai come è fatta. […] Sì fuori ci vediamo praticamente tutti i giorni lì in stazione, se abbiamo bisogno ci sfoghiamo insieme (Intervista 6).
Non è giusto che qui possa entrare anche certa gente [in riferimento a un’altra donna ospite di Spazio Irene], se uno non vuole farsi aiutare allora non merita di stare qui. […] Bisogna meritarselo lei arriva sempre ubriaca, devono esserci delle regole. […] Ho capito che voi dovete tenerla qui però per me non è giusto (Intervista 5).
Emergono qui due voci quasi contrapposte, dove da una parte si evidenzia la dimensione del supporto, dell’identificazione positiva e della mutualità possibili nella dimensione del gruppo, andando a intessere legami che si pongono a risorsa anche all’esterno del servizio. Dall’altra parte emerge invece il tema del conflitto che nasce sempre nella dimensione del gruppo, un conflitto che ha come obiettivo l’esclusione e che si basa su un senso di ingiustizia portata avanti dall’idea di un aiuto meritocratico. La dimensione del gruppo appare dunque ambivalente, consentendo da un lato la condivisione e la reciprocità che aiuta il dialogo e la riflessione sulle proprie storie e sui cambiamenti auspicati; dall’altro reitera processi di rabbia e di violenza ri-proiettati su membri del gruppo ritenuti immeritevoli, secondo un’idea di cura appresa dalle esperienze pregresse di aiuto e relazione.
Aspettative per il futuro
Nella narrazione sulle aspettative di cambiamento per il futuro, e sui cambiamenti vissuti, sono emerse testimonianze che si sono andate a costruire vicendevolmente in una narrazione comune, la quale è partita dalla crescita dello spazio che da semplice luogo dove «stare» è diventato luogo dove «essere» e dove progettare possibilità future. La visione e la capacità di prospettare narrazioni future del luogo, anche nella semplicità di alcune richieste, porta il focus sulla riflessione per un cambiamento che viene visto come possibile e del quale si riesce a parlare. Anche qui può essere possibile individuare una di quelle forme di advocacy non definite e non strutturate che prendono forma nella quotidianità del servizio, riconoscendo il cambiamento e la possibilità. Le nuove attività implementate a partire dal dialogo e dalle richieste portate in campo dalle donne ospiti del servizio hanno permesso loro di sperimentare con successo un potere di presa di voce che richiede di essere esperito per prendere fiducia in questa possibilità e divenire prassi nell’azione, rafforzando il senso di auto-efficacia e di condivisione.
Un po’ è cambiato perché all’inizio c’erano più attività proposte dalle volontarie poi abbiamo iniziato con S. [esperta di teatro] e C. [psicologa]. […] Vorrei fare più cose, anche uscire insieme e fare cose più attive come il ballo o cantare (Intervista 4).
Le aspettative presentate di crescita e cambiamento prospettano un gruppo che non si accontenta ma crede nella possibilità di un miglioramento. Un miglioramento che riprendendo i temi già riportati prevede un coinvolgimento della collettività al fine di un riconoscimento e un riscatto sociale, per un agire comunitario che, coinvolgendo i servizi e la parte politica e amministrativa attiva nel settore, possa portare a nuove riflessioni sulle mancanze e sui bisogni, per creare spazi nuovi che sappiano dare un’attenzione alla specificità del fenomeno delle donne senza dimora, rendendosi sicuri e flessibili nell’offrire risposte adeguate e nel permettere un ascolto autentico.
Vorrei poter venire qui più giorni non solo il lunedì (Intervista 3).
Nel weekend non ci sono servizi e allora si beve di più, ci si droga di più si ruba di più. […] Servirebbe uno spazio come questo dove stare anche nel weekend (Intervista 5).
Passa da queste parole la consapevolezza su rischi e debolezze che sono proprie del fenomeno soprattutto a causa di fattori strutturali, e che riportano l’attenzione sulla mancanza di attenzioni mirate alla condizione delle donne senza dimora. Un’attenzione che non deve rendersi sterile nell’ideare nuove risposte tampone in senso direttivo ma che richiede una riflessione all’interno di un agire relazionale secondo un lavoro di rete, tra i cui membri risultano fondamentali le stesse donne con le loro risorse e i loro punti di vista.
Conclusioni
A conclusione del lavoro di ricerca svolto all’interno di Spazio Irene, grazie alle donne che ne sono ospiti, è possibile esporre come i processi di partecipazione e di advocacy si manifestino in forme ibride ed embrionali all’interno della quotidianità del servizio. Si tratta tuttavia di prime forme ed esperienze di ripresa di voce che consentono un apprendimento che richiede di essere riconosciuto e valorizzato, per porsi a base della costruzione di forme più strutturate e funzionali (Juhila, 2008). I temi del proporre, della partecipazione e dell’ascolto tornano più volte in un desiderio di riconoscimento e in una condanna delle ingiustizie subite e della mancanza di servizi adeguati che ancora però sembra partire da una aspettativa di risposta in senso unidirezionale, faticando a prospettare il proprio ruolo e le proprie risorse in ottica di un agire che si renda invece bidirezionale (Folgheraiter, 2018). Le forme di advocacy presentate partono soprattutto da una presa di voce che ritrova fiducia nell’esporsi per presentare pensieri e desideri di cambiamento, che però non sempre sono visti come possibili, e che richiedono un agire in ottica di partnership con gli operatori, i quali dovrebbero mettersi a sostegno di queste istanze per porle su un piano di concretezza e di partecipazione (Juhila, 2008). Il lavoro svolto negli ultimi anni, che ha visto l’attivazione di alcuni progetti e iniziative a partire dalle riflessioni e dalle proposte delle donne, ha posto le basi per operare in ottica maggiormente relazionale e per favorire realmente il ruolo degli operatori come professionisti a promozione del miglioramento dello status sociale di individui in situazioni di vulnerabilità e oppressione, rafforzandone la posizione all’interno del sistema sociale nel quale vivono, e favorendo la partecipazione e l’inclusione comunitaria (Freddolino et al., 2004). Si tratta tuttavia di una prospettiva che fatica a realizzarsi nella sua completezza anche a causa della mancanza di tempo e risorse, a partire dalla presenza di un’unica operatrice sui servizi di Caritas Bergamasca destinati alle donne senza dimora. L’innovatività del servizio, che si presenta come nuovo sulla scena nazionale e internazionale, va a scontrarsi dunque con una realtà operativa che non sempre permette un agire relazionale che si rende necessario nella creazione di un contesto sicuro e specifico che sappia favorire la voce di queste donne. Gli stessi documenti si rivelano carenti nello stabilire un quadro progettuale in linea con i pensieri e le aspettative presentate e, in mancanza di protocolli scritti e condivisi, si rischia di delegare a forme verbali gli sviluppi futuri, non dando un giusto riconoscimento e una adeguata strutturazione al servizio. La dimensione del gruppo risulta centrale nel riattivare processi di identificazione positivi e legami di solidarietà e condivisione, ponendosi tuttavia anche come luogo di conflitto, dove le ingiustizie subite vengono ri-proiettate su altri membri del gruppo (Krupnick et al., 2008). Le aspettative di cambiamento tornano invece a concentrarsi un desiderio di riconoscimento che muove i primi passi nell’esposizione di tali prospettive, riportando il ragionamento su processi di advocacy che trovano spazi di parola nel tema delle ingiustizie vissute e percepite, nel tentativo di ricostruire un incontro e una conoscenza reciproca che si mettano a base di un’empatia come motore di cambiamento (Curry-Stevens, 2012). Tale ricerca muove dunque solo i primi passi all’interno di un contesto che richiede di essere approfondito e studiato in ottica migliorativa, per ridare dignità a un fenomeno che rimane spesso ignorato sulla scena pubblica politica ed economica, ma che vede l’introduzione dei primi apprendimenti e delle prime consapevolezze sia da parte degli operatori che da parte delle donne. In tal senso, le donne richiedono di essere curate e valorizzate per sviluppi futuri che si rendano fertili nell’influenzare nuovi approcci di lavoro in ottica partecipativa (Casey et al., 2008; Folgheraiter, 2011; Juhila, 2008). I primi elementi emersi permettono di aprire un ragionamento sulla necessità di una formazione specifica da parte degli operatori, i quali sappiano agire in contesti di vulnerabilità e vittimizzazione come presentati nei paragrafi precedenti, dove è necessario avere un’attenzione e una conoscenza specifica anche su quelle che sono le dinamiche di genere all’interno del fenomeno. È da tale specializzazione che si potrà ipotizzare un ampliamento dell’offerta di servizi mirati a tale fascia di bisogni, per costruire, anche grazie al coinvolgimento delle donne senza dimora, spazi e ragionamenti che sappiano tematizzare quella che è la situazione a livello nazionale e locale.
Bibliografia
Boeije H. (2010), Analysis in Qualitative Research, New York, Sage.
Bova R. (2022), The homeless population during the COVID-19 syndemic: Inequities, practices of social resilience, and social reintegration strategies, «Frontiers in Sociology», vol. 7.
Bretherton J. (2017), Reconsidering Gender in Homelessness, «European Journal of Homelessness», vol. 11, n. 1, pp. 1-22.
Bretherton J. (2020), Women’s Experiences of Homelessness: A Longitudinal Study, «Social Policy and Society», vol. 19, n. 2, pp. 255-270.
Bretherton J. e Mayock P. (2021), Women’s Homelessness: European Evidence Review, FEANTSA, March.
Calcaterra V. (2014), Il portavoce del minore. Manuale operativo per l’advocacy professionale, Trento, Erickson.
Casey R., Goudie R. e Reeve K. (2008), Homeless Women in Public Spaces: Strategies of Resistance, «Housing Studies», vol. 23, n. 6, pp. 899-916.
Curry-Stevens A. (2012), Persuasion: Infusing advocacy practice with insights from anti-oppression practice, «Journal of Social Work», vol. 12, n. 4, pp. 345-363.
Della Porta D. (2010), L’intervista qualitativa, Roma, Laterza.
Dominelli L. (1998), Anti-oppressive practice in context. In Social work: Themes, issues and critical debates, London, Macmillan Education UK, pp. 3-22.
Dominelli L. (2017), Anti Oppressive Social Work. Theory and Practice, London, Bloomsbury Publishing.
FEANTSA (2021), Guide for developing effective gender-responsive support and solutions for women experiencing homelessness, https://www.feantsa.org/download/ethos2484215748748239888.pdf (consultato il 23 luglio 2025).
Flick U. (2018), Designing qualitative research, New York, Sage.
Folgheraiter F. (2011), Fondamenti di metodologia relazionale, Trento, Erickson.
Folgheraiter F. (2016), Scritti scelti, Trento, Erickson.
Folgheraiter F. (2018), La logica dell’auto mutuo aiuto. Reciprocità nel welfare societario, «Lavoro Sociale», vol. 18, n. 2, pp. 25-34.
Freddolino P.P., Moxley D.P. e Hyduk C.A. (2004), A Differential Model of Advocacy in Social Work Practice, «Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services», vol. 85, n. 1, pp. 119-128.
Glumbíková K., Gojová A. e Gřundělová B. (2019), Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: the case of social work with mothers in shelters, «European Journal of Social Work», vol. 22, n. 4, pp. 575-586.
Henwood B., Wenzel S.L., Mangano P.F., Hombs M. e Padgett D.K. (2015), The Grand Challenge of Ending Homelessness, «Grand Challenges for Social Work Initiative», pp. 1-21.
Huber M.A., Brown L.D., Metze R.N., Stam M., Van Regenmortel T. e Abma T.N. (2022), Exploring empowerment of participants and peer workers in a self-managed homeless shelter, «Journal of Social Work», vol. 22, n. 1, pp. 26-45.
Istat (2014), La ricerca nazionale sulla condizione delle persone senza dimora in Italia, www.istat.it/it/files/2014/06/17915_Senza_dimora.pdf (consultato il 23 luglio 2025).
Istat (2021), Risultati del Censimento permanente della popolazione, www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/risultati/ (consultato il 23 luglio 2025).
Juhila K. (2008), Forms of advocacy in social welfare work with homeless women, «European Journal of Social Work», vol. 11, n. 3, pp. 267-278.
Juhila K. (2009), From care to fellowship and back: Interpretative repertoires used by the social welfare workers when describing their relationship with homeless women, «British Journal of Social Work», vol. 39, n. 1, pp. 128-143.
Krumer-Nevo M. (2021), Speranza radicale. Lavoro sociale e povertà, Trento, Erickson.
Krupnick J.L., Green B.L., Stockton P., Miranda J., Krause E. e Mete M. (2008), Group interpersonal psychotherapy for low-income women with posttraumatic stress disorder, «Psychotherapy Research», vol. 18, n. 5, pp. 497-507.
Leonardi D. (2021), La colpa di non avere un tetto. Homelessness tra stigma e stereotipi, Torino, Eris Edizioni.
Lodi Rizzini C. (2013), Il social housing e i nuovi bisogni abitativi, Torino, Einaudi.
Mayock P. e Sheridan S. (2020), Women Negotiating Power and Control as they ‘Journey’ Through Homelessness: A Feminist Poststructuralist Perspective, «European Journal of Homelessness», vol. 14, n. 2, pp. 17-47.
Milaney K., Williams N., Lockerbie S.L., Dutton D.J. e Hyshka E. (2020), Recognizing and responding to women experiencing homelessness with gendered and trauma-informed care, «BMC Public Health», vol. 20, n. 1.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2015), Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Poverta-estreme/Documents/Linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta.pdf (consultato il 23 luglio 2025).
Raineri M.L. (2007), Interventi di controllo, «Lavoro Sociale», vol. 7, n. 3, pp. 415-423.
Raineri M.L., Calcaterra V., Cabiati E. e Corradini F. (2021), Compliance o reciprocità? Come gli operatori sociali concepiscono la partecipazione. In Tra Partecipazione e controllo. Contributi di ricerca sul coinvolgimento di bambini e famiglie nei servizi di tutela minorile, Trento, Erickson.
Steele L. (2017), Housing First for Women Experiencing VAWG Toolkit, «The Whole Housing Approach», pp. 1-15.
Warren J. (2007), Service User and Carer Participation in Social Work, New York, Sage.
-
1 Assistente Sociale, Comune di Bergamo.
-
2 Assistente Sociale, Comune di Bergamo.
-
3 Definizione riportata in https://www.fiopsd.org/persone-senza-dimora/.
-
4 Si tratta di una frase con cui vengono presentati diversi servizi di Caritas Bergamasca dedicati alle persone senza dimora e che è stata centro di discussione in questo anno all’interno del gruppo di donne che hanno frequentato il servizio, come è emerso anche dalle riflessioni scaturite dalle interviste che verranno presentate in seguito.
-
5 Con il termine compliance ci si riferisce a una forma di partecipazione che si realizza come aderenza al progetto, in uno sforzo consapevole nel seguire i suggerimenti forniti da un operatore esperto nella direzione di un percorso di aiuto e di miglioramento. Tale termine viene contrapposto all’idea autentica di partecipazione come reciprocità e condivisione del potere tra persone e professionisti (Raineri et al., 2021).
Vol. 2, Issue 1, July 2025