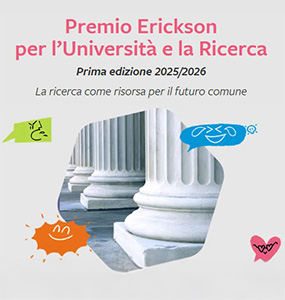Vol. 2, n. 1, Luglio 2025
Oltre le sbarre
Il «Metodo Cec» dell’associazione papa Giovanni XXIII nella realtà riminese a partire da una ricerca etnografica
Laura Petroni1
Sommario
Nel presente articolo vengono riportati i risultati di una ricerca etnografica volta a conoscere l’esperienza CEC (Comunità Educante con i Carcerati), con particolare riferimento alla prima fase di questo metodo. Giorgio Pieri, membro dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, ispirandosi al modello APAC nato in Brasile, ha fondato il metodo CEC che si prepone, a partire da alcuni principi ispiratori e dall’utilizzo di diversi strumenti, di accompagnare chi ha commesso un reato ad avviare un cammino di cambiamento. La ricerca etnografica è stata condotta, nel mese di ottobre 2021, all’interno di una comunità — sita a Rimini — che si occupa della prima fase del metodo CEC: quella di accoglienza. L’osservazione partecipante, la raccolta di note etnografiche e l’intervista semi-strutturata, rivolta al fondatore a conclusione del mese di permanenza in struttura, hanno consentito di ottenere un materiale denso di informazioni che è stato poi sottoposto ad analisi tematica. I dati ottenuti sono stati -infine- riletti attraverso le lenti del Relational Social Work: questo lavoro ha permesso di individuare alcune linee guida e principi, che a partire dall’esperienza CEC, possono essere utili a tendere al mandato rieducativo sancito nella Costituzione.
Parole chiave
Detenuti, mandato rieducativo, metodo CEC, sfida relazionale.
Beyond the bars
An analysis of the «CEC method» of the «Papa Giovanni XXIII» Association of Rimini, based on ethnographic research
Laura Petroni2
Abstract
This article reports the results of an ethnographic study understanding the experience of CEC (Educating Community with Prisoners) with particular reference to the initial phase of this method. Giorgio Pieri, a member of the Associazione Papa Giovanni XXIII, founded the CEC method, drawing inspiration from the APAC model developed in Brazil. The method, based on inspiring principles and the use of different tools, aims to guide individuals who have committed crimes towards a path of change.
The ethnographic research has been conducted, in October 2021, within a community — sited in Rimini — that is responsible for the first phase of the CEC method: the reception method. Through the participant observation, collection of ethnographic notes and the semi-structured interview with the founder at the conclusion of the month-long stay in the facility, made it was possible to obtain material dense with information that was then subjected to thematic analysis. The data obtained were — finally — reread through the lens of Relational Social Work: this research made it possible to identify some guidelines and principles, that, starting from the CEC experience, can contribute to fulfilling the re-educational mandate enshrined in the Constitution.
Keywords
Prisoners, reeducational mandate, CEC method, relational challenge.
Introduzione
Il tema della giustizia da sempre interessa e interpella l’uomo, trapassa il tempo, cambiando «abiti», ma senza perdere il proprio connotato di complessità. È sufficiente porsi il quesito di cosa sia la giustizia (Martini e Zagrebelsky, 2003; Stella, 2006). per scontrarsi con la laboriosità insita in tale concetto, che richiama a sé costrutti non solo giuridici, ma anche politici, sociali e culturali.
L’art 27 della Costituzione rappresenta un primo approdo che possiamo tracciare nel terreno sconfinato della giustizia: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Questo articolo, da un lato chiarisce lo scopo della pena — quale è la rieducazione del reo — e, dall’altro lato, offre precise indicazioni su come tendere a tale fine vietando ogni pratica contraria al senso di umanità. Come ha ribadito anche la Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 12 del 1996, un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è il presupposto necessario per un’azione rieducativa del condannato. L’art 27 della Costituzione, in questo modo, si pone come un baluardo che protegge dalle pratiche punitive, disumane e barbare dell’antico regime e anche dai retaggi retributivi: fare giustizia non significa rispondere al male con il male, piuttosto credere nel valore della libertà umana e scommettere sulla possibilità di cambiamento, offrendo a chi ha commesso reati l’opportunità di riscattarsi poiché, anche se il passato «è stato», il futuro rimane una possibilità aperta (Eusebi, 2023; 2004).
La pena carceraria rappresenta — ancora oggi — la risposta prevalente dello Stato nei confronti di chi ha commesso reati; tuttavia, è sufficiente «andare a vedere» (Calamandrei, 2019) dentro le mura carcerarie per comprendere quanto la pena detentiva sia lontana al senso di umanità e altresì al mandato rieducativo a cui, invece, dovrebbe tendere. La pena detentiva non solo non sembra aderire al dettato Costituzionale, ma non risulta neppure efficace né sul piano della prevenzione generale, né su quello della prevenzione speciale: come sottolinea Giostra (2020), infatti, «la cultura del crimine» che aleggia dentro le mura carcerarie incrementa l’indice di recidiva (che oggi si attesta al 68%), inoltre le istanze intimidatorie non risultano funzionali a scopi preventivi che richiedono, invece, un’adesione e un consenso alle norme (Eusebi, 2023).
Come mai il sistema carcerario, nonostante queste contraddizioni e inefficienze, continua a sopravvivere?
Per rispondere a questo quesito è necessario interrogarsi sul senso e sul significato di giustizia che aleggia non solo nei contesti istituzionali, ma soprattutto nel tessuto sociale: la richiesta populista di «buttare le chiavi» esprime con forza una concezione di giustizia intesa come corrispettivo, e aderente — quindi — alla logica sterile di rispondere al male con il male. Le mura carcerarie, accuratamente relegate ai margini della società e chiuse su se stesse, sembrano rispondere a questa idea di giustizia che, riprendendo Mazzucato, «non ha nulla da chiedere al reo, perché per infliggere non c’è — ovviamente — bisogno della collaborazione, né di un facere propositivo del colpevole» (Mazzucato, 2004, p. 165).
Per rilanciare il senso di giustizia di cui è intriso l’articolo 27 della Costituzione, è necessario seminare l’immagine di una pena che non si limiti a infliggere passivamente, ma che solleciti un’attivazione del reo, ponendolo davanti alla possibilità di intraprendere un cammino di cambiamento. Riprendendo Fiandaca, il mandato rieducativo presume un «clima politico-culturale di rinnovata fiducia nella possibilità di riabilitare gli autori di reato» (Fiandaca, 2017, p. 29) ed è altresì una riduzione «dell’ambito di operatività della pena detentiva» (Fiandaca, 2017, p. 29).
Uno scenario, questo, che grazie alla cosiddetta «riforma Cartabia» (l. 134/2021), si profila come raggiungibile; tra i contenuti della riforma, infatti, centrale è «il superamento dell’idea di carcere come unica effettiva risposta al reato», nell’idea che «la certezza della pena non è la certezza del carcere» (Novi, 2021; Ruotolo, 2016). In questo modo la riforma Cartabia ha messo in discussione quel «sistema a clessidra» (Eusebi e Giunta, 2021, p. 13) che pone la pena detentiva come porta di accesso per la totalità dei reati, promuovendo invece l’ambito di azione delle misure alternative alla detenzione che, come dimostra l’inferiore tasso di recidiva rispetto ai condannati alla pena carceraria, si rivelano più efficaci sul fronte rieducativo (Fiandaca, 2024).
In questo quadro di riflessione sul significato di giustizia e sul modo di intendere la pena, si vuole presentare l’esperienza CEC (Comunità Educante con i Carcerati) che, ponendosi l’obiettivo di superare i limiti della realtà carceraria, dal 2004 accoglie detenuti proponendo loro un percorso di accompagnamento alla rieducazione e al reinserimento sociale. Nel presente articolo l’esperienza CEC verrà presentata riprendendo i dati raccolti tramite una ricerca etnografica che è stata condotta in una delle strutture afferenti al metodo CEC. L’analisi delle note etnografiche ha permesso di tratteggiare diverse aree tematiche che sono state poi rilette secondo l’approccio del Relational Social Work; quest’ultimo passaggio ha consentito di definire alcuni principi e linee guida che, a partire dall’esperienza CEC, possono essere utili a operatori sociali impegnati a tendere al mandato rieducativo.
Dal modello APAC in Brasile al metodo CEC della Papa Giovanni XXIII3
Il modello APAC (Associazione per la Protezione e l’Assistenza dei Condannati) (Ottoni, 2001) è stato fondato, in Brasile, da Mario Ottoboni. Questa Associazione, dal 1972, accoglie detenuti per accompagnarli in un cammino rieducativo che, abbandonate le catene, fa leva sulla loro responsabilizzazione attiva. Il simbolo delle chiavi affidate agli stessi recuperandi4 racchiude lo spirito e la portata rivoluzionaria di questo modello. Giorgio Pieri, membro dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, ispirandosi all’APAC, ha dato vita nel 2004 al metodo CEC (Comunità Educante con i Carcerati) che, a partire da alcuni principi ispiratori e dall’utilizzo di diversi strumenti, offre ai detenuti5 un percorso umano, valoriale e religioso volto a facilitare un cambiamento personale e un progressivo reinserimento nel contesto sociale.
Il metodo CEC si suddivide in tre fasi: la prima è focalizzata a far conoscere al recuperando la vita comunitaria (le attività e le regole previste) e ad avviare una riflessione personale. La seconda fase si pone l’obiettivo di far emergere passioni, doti, e di consolidare le capacità del singolo, in modo tale da accompagnarlo a quella che è la terza fase, ovvero il reinserimento nel contesto sociale, attraverso la ricerca di un lavoro retribuito e la promozione di un’autonomia abitativa.
Metodologia della ricerca
La conoscenza del metodo CEC, come sopra riportato, è avvenuta mediante lo svolgimento di una ricerca etnografica condotta — nel mese di ottobre del 2021 — nella struttura Casa Betania, sita a Rimini, che si occupa di accogliere recuperandi che escono dal carcere in misura alternativa alla detenzione, e di accompagnarli nella prima fase del percorso rieducativo offerto dal metodo CEC. È opportuno sottolineare che, nonostante la possibilità offerta dal fondatore di conoscere anche le altre strutture CEC referenti delle successive fasi, si è scelto, per ragioni metodologiche, di focalizzare la ricerca unicamente sulla comunità di Casa Betania. Questa decisione è stata presa nella consapevolezza che la permanenza del ricercatore nel contesto di studio per un tempo sufficientemente lungo, è indispensabile a raccogliere dati qualitativamente validi (Cardano, 2011). La domanda di ricerca è stata quindi circoscritta alla conoscenza della prima fase del metodo CEC, escludendo l’obiettivo -troppo ambizioso per il presente studio- di poter descrivere il metodo nella sua interezza. Durante il mese di permanenza in struttura i recuperandi accolti, tutti di genere maschile, erano 13, con un’età molto varia (dai 19 ai 60 anni); eterogenei erano anche i reati dagli stessi compiuti (per tratteggiare alcuni esempi, vi erano accuse di omicidio, spaccio, pedofilia e furto).
In riferimento alla presente ricerca, è stata condotta un’osservazione partecipante di tipo scoperto: è stata quindi comunicata, e non occultata, la finalità di condurre un’analisi sul metodo CEC. Rispetto al ruolo osservativo è stato ricoperto quello di osservatore in veste di partecipante, che richiede al ricercatore di partecipare alla maggior parte delle esperienze vissute dagli attori sociali, seppur distinguendosi dall’osservatore completo che letteralmente vive come le persone coinvolte. La redazione delle note etnografiche, che costituiscono un altro strumento proprio della ricerca etnografica, è avvenuta in due momenti distinti: l’osservazione scoperta ha consentito, durante la permanenza sul campo, di appuntarsi su un taccuino note rapide, particolari e dettagli osservati, che in una fase successiva sono stati poi trascritti in maniera più descrittiva e completa, andando così a tracciare le note etnografiche propriamente dette.
Le informazioni e i risultati ottenuti dalla presente ricerca sono stati raccolti attraverso questa immersione sul campo, e quindi mediante momenti di confronto informale con gli attori sociali e -altresì- osservando le dinamiche relazionali che venivano di giorno in giorno a dispiegarsi. Si precisa che, a conclusione del mese di permanenza in struttura, è stata rivolta una sola intervista semi-strutturata al fondatore del metodo CEC, al fine di confrontarsi con lo stesso su alcuni aspetti che non erano emersi in maniera chiara durante il mese di osservazione, e di approfondirne altri che avevano sollevato dubbi e questioni. Nel dettaglio, nella costruzione della griglia di intervista, sono state individuate tre aree tematiche: la nascita del progetto CEC, l’utilizzo degli strumenti e le motivazioni a questi sottese e, infine, gli aspetti di forza e di debolezza del modello; per ciascuna area tematica è stata definita una domanda sonda volta a sollecitare una riflessione sulla questione di interesse (Tunisi, 2016).
Presentazione dei risultati
La fase di analisi dei dati si è articolata in tre momenti distinti: segmentazione della documentazione empirica, qualificazione di ciascun segmento e individuazione delle relazioni tra gli attributi assegnati ai segmenti (Cardano, 2001). Questo lavoro ha consentito di giungere alla delineazione di diverse aree tematiche che di seguito verranno brevemente riportate:
Fare la verità nei rapporti con l’altro e con se stessi
Un tema ricorrente all’interno della comunità è quello della verità: i recuperandi sono chiamati, sia nelle relazioni con gli altri, sia in riferimento alla propria storia di vita, a fare la verità. Sono diversi gli strumenti del metodo CEC che si propongono di facilitare rapporti di fratellanza: i richiami, che si svolgono ogni giovedì sera, richiedono a ciascun recuperando di indicare a uno o più compagni errori, anche piccoli, e trasgressioni di regole compiute durante la giornata; un altro strumento è quello dei ringraziamenti: ogni sera, pensando alla giornata appena trascorsa, ogni recuperando viene chiamato a condividere uno o più ringraziamenti; questa routine ha l’obiettivo di abituare a un diverso modo di vivere le relazioni e a essere riconoscenti per ciò che si riceve. Infine, la tabella dei voti è uno strumento orientato a mettere in luce le dinamiche relazionali, evitando atteggiamenti omertosi: ogni settimana i recuperandi devono dare voti agli altri «fratelli» su ciascuna delle voci preposte in tabella (cura e amore di te stesso, cura e amore degli altri, responsabilità, verità e omertà, ecc.); il C.S.S.S. ogni domenica corregge in rosso i voti che non reputa onesti, ma che sono stati attribuiti per ripicca o per complicità con un compagno.

La finalità di questo principio è di innescare cambiamenti nella gestione delle relazioni e quindi superare l’omertà che, riprendendo il pensiero del fondatore Giorgio Pieri, domina il mondo della delinquenza. Si riportano stralci di note etnografiche che aiutano a comprendere l’orizzonte in cui il valore di fare la verità si dispiega:
Recuperando 11 mi racconta che all’inizio la vita in comunità era difficile, aveva molte discussioni con chi «faceva vedere la verità». È solo quando ha capito che ogni cosa era pensata per lui, per un desiderio di bene e di aiuto, che ha deciso di restare (10/10/2021).
Recuperando 1 mi racconta che inizialmente ha fatto molta fatica in comunità, aggiunge: «io ho sempre pensato solo a me stesso e mi bastava, in comunità ho iniziato a pensare agli altri». Mi parla poi dei richiami, di quanto siano faticosi per i detenuti perché in carcere vige l’omertà; mi spiega che è difficile compiere questo passo e riconoscere che «fare la verità» significa fare del bene (20/10/2021).
Durante il mese di permanenza in struttura si è potuto cogliere il rischio che il continuo richiamo a fare la verità venga percepito dai recuperandi come una mera imposizione, e quindi che non venga vissuto e riconosciuto come un valore. Per esempio, alcuni, confrontandosi sui voti ricevuti, hanno riferito che «non servono a nulla, solo a fare arrabbiare e litigare»; uno di loro, rancoroso per aver ricevuto un voto basso, ha minacciato di non impegnarsi più nella mansione, un altro ha dichiarato di non prestare attenzione ai voti perché non servono a nulla aggiungendo: «devi scrivere ciò che vogliono sentirsi dire». L’intento di questi strumenti è quello di educare a un nuovo modo di vivere i rapporti, e questo sicuramente è fondamentale in un cammino rieducativo. Da quanto osservato, tuttavia, risulterebbe utile predisporre dei momenti di dialogo e di confronto, facilitati da un operatore, che aiutino a cogliere il senso di questi strumenti e a evitare che l’intento di fare la verità si traduca in una omertà, più o meno esplicita.
In comunità la verità non orienta solo la relazione con l’altro, ma anche quella con se stessi: i recuperandi sono chiamati a riflettere sulla propria vita, a riconoscere la gravità e il motivo sotteso alle proprie azioni delinquenziali, nell’idea che questo sia il presupposto per poter avviare un autentico cammino di cambiamento. Durante il mese di osservazione si è potuto cogliere come l’obiettivo di guardare con verità alla propria storia sia raggiunto grazie alla dimensione relazionale che contraddistingue il percorso CEC, il quale si contrappone alla solitudine che i recuperandi hanno, invece, vissuto in carcere. Si riportano di seguito alcuni stralci di note etnografiche sul tema:
Operatore 2 (ex recuperando) mi spiega che nel carcere in cui è stato gli educatori in pianta organica erano 12, ma quelli realmente presenti erano solo tre, più uno part time. Mi dice di aver incontrato in comunità recuperandi che non hanno mai visto un operatore, aggiunge: «se sei in stato di abbandono come fai a rinascere maturato?» (3/10/2021).
Secondo Recuperando 1, il carcere rappresenta un tentativo di «eliminare le persone»; in carcere uno può fare quello che vuole: dormire, fumare, drogarsi; in comunità, invece, ci sono regole, sei obbligato a convivere con te stesso e con gli altri (26/10/21).
Operatore 2 (ex recuperando) mi spiega che lo scopo della comunità è aiutare i recuperandi a prendere in mano il proprio dolore, non la sua rimozione, che è «l’anticipo della disperazione». Segue un momento di silenzio, poi afferma: «dire che ho ucciso è difficile»; mi spiega che è stato un percorso graduale e che bisogna sentire «uno sguardo di bene, bisogna sentire che le persone non hanno paura di te» (3/10/2021).
Oggi ho avuto il colloquio con Recuperando 3, un ragazzo di 30 anni incarcerato per stupro, con alle spalle un vissuto di violenza che, riprendendo le sue parole, gli hanno «tolto il valore». Il suo racconto del carcere trasuda di una sofferenza indicibile […] mi confida di essere nato un’altra volta in comunità perché è qui che è riuscito a dire ciò che ha vissuto nella sua vita. Mi racconta, una volta entrato in carcere, di aver mentito sul reato compiuto, a tutti diceva che l’accusa era falsa. Aggiunge «ero schiacciato dalle mie bugie». Mi riferisce di non aver dormito per giorni, di aver passato ore davanti allo specchio chiedendosi se rivelare o meno la verità, fino a quando, un giorno, lo ha confidato a Operatore 3 (ex recuperando) il quale gli ha chiesto se anche lui avesse subito violenze da piccolo. Recuperando 3 afferma: «davanti a quella domanda si è aperta tutta la mia ferita» (9/10/2021).
Dalle parole dei recuperandi emerge l’importanza di investire nella dimensione relazionale a partire proprio da uno sguardo di rispetto che vede la persona e non solo il reato commesso.
Responsabilità e fiducia
Durante il mese di permanenza in struttura è emerso, come ricorrente, il bisogno dei recuperandi di ricevere fiducia. La Comunità Educante con i Carcerati opera in questa direzione affidando a questi ultimi ruoli come quello di C.S.S.S., oppure mansioni lavorative, o ancora l’incarico di prendersi cura di uno «special». Gli «special» sono persone con disabilità sia fisica che psichica, i quali vivono all’interno della struttura e che sono appunto affidati a un recuperando che ha il compito di prendersi cura di loro, lavarli, vestirli e rispondere a ogni loro esigenza. La fiducia così ricevuta, come dimostrato dagli stralci di note etnografiche di seguito riportate, ha permesso ai recuperandi di «riconcepirsi come persone capaci di fare del bene»:
Recuperando 2 (riferendosi alle mansioni lavorative) mi spiega che in comunità viene fatto emergere quello che hai di buono, «se hai anche poco lo sviluppi al massimo» (4/10/2021).
Operatore 2 (ex recuperando), riferendosi agli «special», mi spiega che loro aiutano i recuperandi a tirare fuori il meglio. La loro esperienza è molto importante perché «chi ha fatto del male pensa di saper fare solo del male. All’inizio pensi che il bene fa schifo, come difesa, poi dici che il bene non ti appartiene». Aggiunge: «gli special, invece, ti danno amore incondizionato, tirano fuori quello che hai dentro e che senti nascosto». Conclude affermando: «non sei tu ad aiutare loro, sono loro ad aiutare te» (3/10/21).
Recuperando 1 riferendosi al rapporto con lo «special» che gli è stato affidato, confida: «da lui mi sono sentito amato per quello che sono e non per quello che ho fatto» (27/10/21).
Recuperando 3 mi spiega che la responsabilità di C.S.S.S lo ha aiutato tantissimo perché è stato come fargli capire che si fidavano di lui, che lui valeva. Recuperando 3 si definisce una persona che non ha mai saputo comunicare e parlare con gli altri, perché ha vissuto di sola violenza; aggiunge: «io conoscevo solo la violenza non sapevo ci fosse altro» (9/10/21).
Recuperando 4 mi racconta di quanto ha ricevuto da Giorgio Pieri l’incarico di C.S.S.S. e della felicità che ha provato. Afferma: «ero felice perché mi hanno dato fiducia, mi hanno fatto capire che meritavo quella responsabilità»; ancora: «mi hanno valorizzato». Mi parla poi del carcere, del fatto che incattivisce le persone: «in carcere pensi solo a cosa fare, per fare peggio, provi rabbia perché chiedi le cose e non ti viene dato nulla».
In comunità, invece, capisci che puoi fare altro, ti fanno capire che tutto quello che usavi per fare del male lo puoi usare per fare del bene, aggiunge: «non voglio più essere borderline». Secondo Recuperando 4 tutti sono recuperabili, ma ciascuno ha bisogno del suo tempo: «bisogna svuotare e riempire il vuoto con altre cose». Per fare questo, secondo lui, è molto utile compiere azioni positive, mi menziona lavori socialmente utili, volontariato e aiutare persone bisognose. Conclude: «a me fa star bene sentirmi utile agli altri» (28.10.21).
Reciprocità
Il metodo CEC educa a un diverso modo di vivere le relazioni: i recuperandi sono chiamati a «guardare alla persona e non al reato» e altresì a sostenersi reciprocamente scoprendo come, ogni aiuto dato, abbia insita una forma di aiuto verso se stessi. Questo concetto emerge chiaramente da alcune testimonianze:
Recuperando 2 mi spiega che in comunità lo ha aiutato confrontarsi con persone come lui, perché porta a non sentirsi giudicato. In comunità ciascun recuperando aiuta l’altro (7/10/21).
Recuperando 2 mi spiega il principio «recuperando aiuta recuperando», mi dice che è importante perché insegna «a usare il metro degli altri, non il nostro». Mi dice che spesso gli operatori mettono insieme persone per completarsi reciprocamente (4/10/21).
Il valore della reciprocità emerge anche dal rapporto con gli «special»:
Recuperando 7 mi racconta di aver lavorato in cucina con Giuseppe (ragazzo con ritardo cognitivo che viene in struttura durante la giornata), mi spiega che grazie a lui ha imparato a comunicare: di solito è abituato a non spiegare, non ha pazienza e quindi preferisce fare le cose da solo. In cucina con Giuseppe si è fermato, gli spiegava le cose con cura ed è rimasto sorpreso dalla sua capacità di eseguire i passaggi in modo perfetto (14/10/21).
La Comunità Educante Con i Carcerati opera nel tentativo di far crollare i pregiudizi per lasciare spazio a dei rapporti di mutualità. Questo tema verrà poi ripreso, in fase di discussione dei risultati, da una prospettiva metodologica.
Rapporto con la comunità esterna
Uno dei principi cardine del metodo CEC attiene al coinvolgimento della comunità esterna nei percorsi rieducativi: secondo Don Oreste, infatti, «nello sbaglio di uno c’è lo sbaglio di tutti. Per recuperare uno è necessario il coinvolgimento di tutti». Casa Betania, così come le altre strutture CEC, sono aperte al territorio: ai volontari è affidato un recuperando da accompagnare nel percorso tramite incontri settimanali. Questi rapporti non si riducono a dei colloqui, piuttosto si creano relazioni intense, sia a livello emotivo, sia in termini di aiuto offerto.
Il confronto con i volontari ha permesso di cogliere quanto, per loro, l’esperienza in comunità rappresenti una fonte di crescita e di ricchezza personale:
Durante il confronto con Volontario 1, gli chiedo cosa rappresenta per lui questo ruolo; mi spiega che ogni volta che ascolta le storie di vita si sorprende: da un lato riconosce quanto sia stato fortunato nella sua vita, dall’altro lato trae degli insegnamenti. Per lui tutti dovrebbero fare un’esperienza di volontariato per conoscere quanto è importante l’esperienza del dare, ancor di più di quella del ricevere, afferma: «l’esperienza del dare è la più formativa» (18.10.21).
Volontario 2 mi riferisce che l’esperienza in comunità lo aiuta a capire quanto è fortunato: ha scoperto che ci sono persone che non hanno niente. Il rapporto con i recuperandi gli ha permesso anche di capire che chi commette un reato è una persona come noi, che si può recuperare, conclude: «mi sento utile, mi sento vivo» (27.10.21).
Alcune zone d’ombra
In questo paragrafo si vogliono riportare, seppur brevemente, alcune «zone d’ombra» che sono state rilevate nella conoscenza del metodo CEC: la prima attiene alla mancata integrazione tra saperi, la seconda all’obbligatorietà della componente religiosa.
In riferimento al primo punto è opportuno sottolineare come le pratiche di aiuto convenzionali si fondino su una relazione asimmetrica dove «l’aiutante è colui che offre aiuto, mentre gli aiutati sono coloro che lo ricevono» (Folgheraiter, 2011); in questo senso l’esperienza della Comunità Educante con i Carcerati si pone controcorrente: la comunità trasuda di sapere esperienziale e si mostra — invece — più carente sul fronte tecnico-metodologico. La gestione della vita comunitaria è, infatti, principalmente affidata al C.S.S.S. che è composto da recuperandi in percorso; inoltre, gli operatori presenti in struttura sono membri dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, i quali dedicano la propria vita a sostegno di chi è emarginato, oppure ex recuperandi che hanno deciso di rimanere a servizio della comunità. Si tratta, quindi, di persone che detengono un prezioso sapere esperienziale, ma non conoscitivo (Folgheraiter e Cappelletti, 2011; Raineri, 2018). Riprendendo lo sguardo del Relational Social Work, l’aiuto si esprime in tutto il suo potenziale quando nasce dall’incontro tra i due saperi: quello esperienziale, posseduto da chi si trova a vivere una situazione di difficoltà, e quello conoscitivo, detenuto dai professionisti (Folgheraiter, 2007; Illich, 2008). L’osservazione partecipante ha permesso di riflettere su quanto la presenza di operatori all’interno della comunità potrebbe facilitare l’utilizzo degli strumenti del metodo CEC secondo un approccio relazionale, che sembra poi essere in linea con lo scopo enunciato dallo stesso fondatore. Inoltre, si ritiene che la presenza di una guida relazionale (Folgheraiter, 2016) potrebbe accompagnare quella che appare una rete di fronteggiamento potenziale (Folgheraiter, 2007) che vede riunire molteplici persone interessate (recuperandi, volontari, «operatori esperienziali»), favorendo l’integrazione tra le diverse risorse e quindi sostenendo il passaggio da una finalità comune (tutti operano nella stessa direzione) a una finalità condivisa (i membri non solo guardano nella stessa direzione, ma si guardano reciprocamente) (Folgheraiter, 2007).
È opportuno specificare che la mancanza di professionisti all’interno della comunità rappresenta, in qualche modo, una «scelta obbligata»: da quanto riferito dal fondatore, non ricevono rette da parte dei recuperandi e nemmeno una forma di finanziamento da parte dello Stato; non vi sono quindi i fondi per poter retribuire del personale specializzato.
La seconda zona d’ombra attiene all’obbligatorietà, prevista nel metodo CEC, della componente religiosa: dal lunedì al venerdì sono previsti tre momenti di preghiera che si svolgono nella cappellina, situata all’interno della struttura (le lodi alle ore 7,50, la lettura del Vangelo alle ore 9,00 e, infine, l’Ora Media alle 14); è prevista, poi, la preghiera prima di ogni pasto. La domenica, chi sulla base delle prescrizioni del giudice è libero di uscire dalla struttura, viene incentivato ad andare alla messa che si tiene nella chiesa parrocchiale. La formazione spirituale non è proposta con lo scopo di fare proselitismo o di incentivare alla conversione, piuttosto per sollecitare una riflessione interiore e quindi rafforzare il cammino di cambiamento. È opportuno precisare che il fondatore, e anche il volontario che presenzia h24 in struttura, condividono una vita spirituale; secondo il fondatore, infatti, «il bravo operatore non è un insegnante, ma un testimone: deve quindi accostarsi lui in prima persona alla parola di Dio». È proprio questa dimensione di fede, incarnata dagli operatori, a rendere la loro proposta genuina e autentica. Tuttavia, la formazione religiosa predisposta in forma obbligatoria nel programma di recupero pone alcune riflessioni critiche: imporre la preghiera nel percorso rieducativo rischia di ledere la libertà di fede dei recuperandi6 e altresì quel principio di autodeterminazione che la comunità stessa si impegna a rispettare. È opportuno precisare, che i recuperandi che decidono di fare ingresso in comunità, sono consapevoli della presenza della religione nel cammino rieducativo; tuttavia, è importante interrogarsi se siano veramente posti davanti a una scelta libera. Le testimonianze riguardo all’ esperienza carceraria rivelano quanto il «dramma delle catene» influenzi profondamente questa decisione.
Discussione dei risultati: l’analisi del metodo CEC attraverso le lenti del Social Work Relazionale
L’ultimo passo compiuto con la presente ricerca è stato quello di rileggere i risultati ottenuti attraverso le lenti del Social Work Relazionale. Di seguito verranno riportate, seppur brevemente, le riflessioni a cui si è giunti e che hanno permesso di individuare linee guida e principi che, a partire dalla lettura dell’esperienza CEC, risultano importanti per tendere al mandato rieducativo.
Un primo punto di approdo: la relazione come spazio rieducativo
Tenendo in considerazione le testimonianze dei recuperandi risulta funzionale, ai fini di interrompere l’agire delinquenziale, un intervento coercitivo e quindi calato dall’alto, quale può essere l’incarcerazione; come ha confidato un recuperando: «da solo non sarei mai riuscito a fermarmi».7 Tuttavia, riprendendo Ivo Lizzola, affinché il cammino rieducativo possa prendere forma è necessaria una «rottura instauratrice» (Lizzola, 2018) e quindi, potremmo dire, generativa; in relazione a questo secondo mandato, il carcere sembra essere fallimentare poiché risulta intessuto di solitudine e di violenza.
I recuperandi, infatti, attraverso i loro racconti hanno denunciato in carcere un’assenza di personale educativo e altresì di supporti «relazionali» che sembrano essere colmati dall’offerta di farmaci, dalla vendita di alcool e di droga. Diversi di loro hanno riferito che la domanda che usualmente viene rivolta loro in carcere non è «come stai», bensì «cosa vuoi»; ancora, molti hanno paragonato il carcere a una gabbia perché i detenuti sono trattati come animali, ridotti a un numero e a una pratica. Riprendendo le parole di un recuperando «è un sistema che ti logora, ti porta via il rispetto, la dignità, ti senti un oggetto sottomesso alle guardie»,8 «se entri lì vieni dimenticato»,9 «il carcere ti abbandona».10 Oltre alla dimensione di solitudine, gli stessi hanno riportato diversi episodi di violenza che, secondo le loro parole, alimentano ulteriormente la violenza in quanto «da carnefice ti senti vittima»11 Questo è un capovolgimento pericoloso che non induce a un cammino di cambiamento, al contrario porta a «progettare altro male e in misura maggiore».12
I percorsi all’interno della Comunità CEC, e le testimonianze dei recuperandi, hanno dimostrato come siano invece le relazioni, animate da sentimenti di rispetto e di fiducia, a rappresentare un terreno fertile per avviare un percorso di cambiamento. Possiamo quindi declinare il cammino rieducativo in un appello, proprio perché chiama in causa il singolo e la libertà di cui dispone, ma anche un Altro, nella consapevolezza che il cambiamento, pur non potendo essere imposto, può/deve essere accompagnato.13 La sfida rieducativa, più di ogni altro problema di vita (Folgheraiter, 2016) con cui può confrontarsi un operatore sociale, si pone quindi in termini di sfida relazionale, sia perché richiama a una corresponsabilità, del reo e al contempo della società (nelle sue diverse forme istituzionali e non), sia perché, conducendo nel terreno insondabile della libertà umana, sfugge a ogni tipo di trattamento e quindi di intervento coercitivo. Il cammino rieducativo presuppone di non ridurre la persona a un oggetto su cui intervenire dall’alto, piuttosto di considerarla sempre come soggetto agente (Folgheraiter, 2007) nella consapevolezza che, solo nel momento in cui essa si pone come obiettivo «la finalità cosciente di cambiare» (Folgheraiter, 2007, p. 137), allora quel cambiamento può dirsi realmente possibile.
Un secondo punto di approdo: la fiducia come motore di un cambiamento possibile
Durante il mese di permanenza in struttura è emerso quanto sia generativo l’atto di ricevere fiducia in quanto consente di ritrovare stima in se stessi. I recuperandi, grazie alla fiducia ricevuta dagli operatori che hanno attribuito loro ruoli e conferito compiti, si sono sentiti scelti, valorizzati, visti e hanno così scoperto «di valere», «di essere capaci di fare il bene», «di meritare quella responsabilità». Il valore della fiducia ricevuta — e quindi specularmente data — non solo rigetta con forza nella dimensione relazionale (il «portatore» di fiducia è un Altro), ma apre anche le porte ad alcune riflessioni «metodologiche» sul ruolo dell’operatore che non è estraneo, bensì fortemente implicato in questi processi rieducativi. L’operatore sociale, riprendendo il paradigma Relazionale del Lavoro Sociale, è chiamato a volgere lo sguardo a ciò che c’è di positivo (Folgheraiter, 2007): a scorgere non ciò che è assente, piuttosto ciò che è presente; non ciò che è insufficiente, piuttosto ciò che è sufficiente. In altre parole, l’operatore non deve perdersi nei vortici di ciò che va male, ma ricercare quella spinta al bene che — per quanto talvolta offuscata — è sempre possibile scorgere. Riprendendo il paradigma Relazionale del Lavoro Sociale, per sostenere e accompagnare un cammino di cambiamento, è necessario credere nel principio della reciprocità e quindi ancor prima di pretendere fiducia è opportuno darla, nella consapevolezza che questa potrà poi essere ricambiata.
È opportuno sottolineare che guardare a ciò che c’è di positivo, e quindi dare fiducia a chi quella fiducia l’ha infranta compiendo un reato, non significa negare o giustificare il male e gli atti commessi. Agire in questo senso, infatti, oltre che essere lesivo nei confronti della vittima, sarebbe fortemente diseducativo per il reo. Nelle vesti di un operatore sociale assumere questo sguardo significa riconoscere la dignità della persona e soprattutto non assoggettarla agli atti compiuti; ancora, vuol dire discernere la gravità del reato, che deve essere sempre condannato, senza però condannare il singolo alle sue azioni, nella consapevolezza che, per quanto il passato sia già stato e quindi non modificabile, il futuro è sempre aperto a margini di cambiamento. In conclusione, l’atto di dare fiducia, ben lungi dall’essere una forma di giustificazione o di minimizzazione delle responsabilità del soggetto, si profila come una strada più esigente poiché, puntando sull’agency (Folgheraiter, 2007), pone il reo nella posizione emancipativa di soggetto agente, invece che in quella passivizzante di oggetto agito.
Un terzo punto di approdo: educare alla reciprocità per cambiare assieme
Nel mondo della delinquenza viene disattesa quella regola aurea della reciprocità che, riprendendo Folgheraiter, può essere riassunta nel principio biblico di «non fare agli altri ciò che non vorresti facessero a te» (Folgheraiter, 2014); in qualche modo, il denominatore comune di ogni reato è la violazione di questo principio. Nonostante la difficoltà a ripristinare il valore della reciprocità (non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te) e della fiducia (fidarsi che l’altro possa farti del bene), la Comunità Educante Con i Carcerati riesce a muovere passi in questa direzione investendo nel «potere dell’esempio»: il fondatore e gli operatori, che hanno scelto di donare la propria vita per la comunità; i volontari, che in modo gratuito e senza chiedere nulla in cambio offrono il proprio tempo e le proprie risorse, testimoniano rapporti intessuti di reciprocità. Anche la presenza degli «special» educa a un diverso modo di guardare l’altro: uno sguardo che non esprime giudizi e che è capace di accogliere la persona al di là degli atti compiuti.
L’osservazione partecipante ha consentito di cogliere quanto sia importante educare alla reciprocità per facilitare poi un cambiamento congiunto. Diversi recuperandi hanno dichiarato: «aiutare l’altro aiuta me stesso»;14 frase che incorpora il principio «dell’Helper Therapy» (Riessman, 1965) e che richiama le dinamiche dei gruppi di aiuto-mutuo-aiuto. I gruppi AMA testimoniano quanto sia prezioso l’aiuto che proviene da persone che si trovano a fronteggiare la medesima difficoltà: condividere situazioni simili, infatti, consente di offrire un sostegno emotivo che difficilmente può scaturire da chi in quella situazione non si è mai trovato. La ricchezza non risiede solo nel compatire i bisogni dell’altro, così simili ai propri; il gruppo, infatti, non è solo un luogo di condivisione delle difficoltà, piuttosto rappresenta anche — e forse soprattutto — «un’opportunità di azione e di cambiamento» (Steinberg, 2002). Riprendendo lo sguardo della metodologia Relazionale del Lavoro sociale, la risorsa del gruppo, e in qualche modo il suo scopo cardine, è quello di aiutare le persone a tramutare una preoccupazione in una finalità a cui tendere e quindi da raggiungere insieme (Raineri, 2017). La diversità non è percepita come un limite e neppure come un pretesto per andare a definire rapporti di superiorità-inferiorità; diviene, invece, una risorsa: chi si trova in stadi più avanzati del cammino può offrire indicazioni e aiuti a chi ancora quel passaggio deve compierlo. È in questo spazio, in cui ciascuno «è terapeuta di se stesso e del proprio vicino» (Calcaterra, 2013, p. 18), che i partecipanti possono percepire non solo la propria situazione, ma anche la propria persona con occhi diversi e tornare quindi a ri-concepirsi come competenti, capaci di aiutare l’altro e, così facendo, se stessi.
Il metodo CEC investe nel ripristinare rapporti intessuti di reciprocità dimostrando come sia importante, in quanto unico, il supporto tra persone che affrontano situazioni simili.
Un quarto punto di approdo: lavorare con la comunità per fronteggiare problemi complessi
Il sapere tecnico-metodologico del professionista non è sufficiente a fronteggiare sfide complesse, quali quelle rieducative. È necessario investire in primis nella partecipazione del reo — considerato sempre come soggetto agente — e anche della comunità più ampia. Riprendendo Calcaterra e Panciroli, per fronteggiare problemi sociali a carattere collettivo diviene necessario agganciarsi a membri della comunità che percepiscono il problema come tale e che sono disponibili a contribuire per fronteggiarlo (Calcaterra e Panciroli, 2021).
Pensare al lavoro di comunità nel campo della devianza può essere complesso poiché non è facile intercettare un sociale interessato: come si è riflettuto a inizio di questo articolo, il senso di giustizia che aleggia nel tessuto sociale richiama uno stampo propriamente retributivo della pena; la richiesta avanzata dal popolo, che si sente sempre «giusto» (Lizzola, 2009), è quella di «buttare le chiavi» relegando accuratamente il problema della delinquenza tra le mura carcerarie. Per avviare un lavoro di comunità nel campo della devianza, ritenuto necessario per tendere al mandato rieducativo e anche per agire in un’ottica preventiva, occorre scuotere la comunità invitandola a lasciarsi interpellare dal volto di chi ha commesso reati nella consapevolezza, riprendendo le parole di De André, che «per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti».15 Questo è un messaggio di cui si fa portatore la Comunità Educante con i Carcerati che invita la collettività a entrare in struttura per conoscere chi ha commesso reati, lasciarsi perturbare dallo straniero (Lévinas, 2002), riconoscendo la sua responsabilità senza, però, eludere la propria.
Conclusioni e riflessioni sui limiti della ricerca
Nel presente articolo, a partire da una riflessione sui limiti del sistema carcerario nel perseguire il mandato rieducativo sancito dalla Costituzione, è stata presentata l’esperienza della CEC (Comunità Educante con i Carcerati) attraverso i dati raccolti da una ricerca etnografica.
Tale percorso di ricerca, e il successivo lavoro di analisi, ha permesso di rilevare come il carcere sia funzionale in termini di «battuta d’arresto» di un agire deviante; tuttavia, la solitudine di cui è intessuto, impedisce che tale rottura diventi instauratrice. I vissuti di abbandono e di violenza, testimoniati dai recuperandi durante il periodo di detenzione, conducono a reiterare l’esperienza del male inibendo ogni possibile cammino di cambiamento. Il percorso rieducativo promosso dalla Comunità Educante con i Carcerati ha dimostrato che, per interrompere il ciclo della ritorsione — una violenza che genera altra violenza — è necessaria la presenza di un Altro. Seguendo questa linea di pensiero, il percorso rieducativo è stato declinato in un «appello»: al centro vi è il reo, con la sua autodeterminazione, ma anche un Altro responsabile di accompagnare — e non di forzare — tale cambiamento. Il paradigma del Relational Social Work, grazie alla «postura» che conferisce al professionista e al diverso modo di guardare all’utente, si è rivelato un terreno fertile a sostenere la sfida rieducativa. Tale paradigma conduce, infatti, a un riposizionamento degli attori coinvolti nella relazione di aiuto: all’utente viene restituito il ruolo di soggetto agente e non di oggetto agito, e al professionista quello di facilitatore e non di «tecnico impositore». In questo modo viene abitato quello spazio di aiuto, propriamente relazionale, che è necessario se si vogliono sostenere cammini di cambiamento quali quelli rieducativi.
Queste riflessioni, tuttavia, richiedono ulteriori approfondimenti. I risultati discussi si riferiscono unicamente alla prima fase del metodo CEC: un’analisi estesa all’intero percorso potrebbe condurre a una revisione, o quantomeno a un’integrazione, delle conclusioni finora formulate. Analogamente, anche il contesto carcerario andrebbe indagato in modo più diretto, superando la mediazione dei soli racconti dei recuperandi. In questa direzione, si sostiene la necessità di «andare a vedere» questi luoghi, accuratamente relegati ai margini della nostra società, al fine di comprenderne l’organizzazione interna e il complesso panorama delle dinamiche relazionali e istituzionali.
Queste prospettive di indagine future potrebbero contribuire a consolidare — e a integrare — la riflessione, avviata attraverso le lenti del Relational Social Work, sul ruolo degli operatori sociali impegnati nei percorsi rieducativi, offrendo strumenti teorici e operativi orientati a sostenere il cambiamento.
Bibliografia
Calcaterra V. (2013), Attivare e facilitare gruppi di auto/mutuo aiuto, Trento, Erickson.
Calcaterra V. e Panciroli C. (2021), Il Lavoro Sociale di Comunità passo dopo passo. Metodologia e strumenti per progetti a valenza collettiva, Trento, Erickson.
Cardano M. (2001), Etnografia e riflessività. Le pratiche riflessive costrette nel binario del discorso scientifico, «Rassegna Italiana di Sociologia», n. 2, pp. 173-204.
Cardano M. (2011), La ricerca qualitativa, Bologna, il Mulino.
Eusebi L. (2017a), La colpa e la pena: ripensare la giustizia, «Paradoxa», n. 4, pp. 43-65.
Eusebi L. (2017b), La fraternità ferita: colpa, pena, giustizia riparativa. In R. Ragonese (a cura di), Fraternità ferita e riconciliazione, Milano, Ancora, pp. 42-65.
Eusebi L. (2024), Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?, «DisCrimen», n. 3, pp. 89-108.
Eusebi L. e Giunta F. (2021), Sistema sanzionatorio penale e ordinamento penitenziario. In A. Giarda, G. Forti, F. Giunta e G. Varraso (a cura di), Manuale di diritto penitenziario, Milano, Wolters Kluwer-CEDAM.
Fiandaca G. (2017), Prima lezione di diritto penale, Roma-Bari, Laterza.
Fiandaca G. (2024), Punizione, rieducazione, riparazione, «DisCrimen», n. 1, pp. 1-25.
Folgheraiter F. (2007), Fondamenti di metodologia relazionale, Trento, Erickson.
Folgheraiter F. (2011), Fondamenti di metodologia relazionale. La logica sociale dell’aiuto, Trento, Erickson.
Folgheraiter F. (2014), Non fare agli altri: il benessere in una società meno ingiusta, Trento, Erickson.
Folgheraiter F. (2016), Scritti scelti, Trento, Erickson.
Folgheraiter F. e Cappelletti P. (2011), Natural Helpers. Storie di utenti e familiari esperti, Trento, Erickson.
Giostra G. (2020), Questione carceraria, insicurezza e populismi penali, «Questione Giustizia», n. 4.
Gonnella P. e Ippolito D. (a cura di) (2019), Bisogna aver visto. Il carcere nella riflessione degli antifascisti, Roma, Edizioni dell’Asino.
Illich I. (2008), Esperti di troppo. Il paradosso delle professioni disabilitanti, Trento, Erickson.
Lévinas E. (2002), Dall’altro all’io, Roma, Meltemi.
Lizzola I. (2009), L’educazione nell’ombra. Aver cura della fragilità, Roma, Carocci.
Lizzola I. (2018), La risposta al reato. Oltre il diritto di punire: prospettive pedagogiche. In L. Eusebi (a cura di), Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale, Milano, Vita e Pensiero, pp. 37-64.
Martini C.M. e Zagrebelsky C. (2003), La domanda di giustizia, Torino, Einaudi.
Mazzucato C. (2004), Per una risposta democratica alle domande di giustizia: il compito appassionante della mediazione in ambito penale, «Ars Interpretandi», pp. 165-193.
Novi E. (2021), Cartabia, «una rivoluzione costituzionale», «Il Dubbio», 16 marzo.
Ottoboni M. (2001), Vamos matar o criminoso? Metodo APAC, São Paulo, Paulinas.
Raineri M.L. (2017), Relational Social Work and mutual/self-help groups, «Relational Social Work», n. 1, pp. 19-83.
Raineri M.L. (2018), Cosa sono le conoscenze esperienziali? Un concetto fondamentale per capire i gruppi di auto/mutuo aiuto e non solo, «Rivista del Lavoro Sociale», n. 2, pp. 21-27.
Riessman F. (1965), The helper-therapy principles, «Social Work», n. 10, pp. 27-32.
Ruotolo M. (2016), Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti, «Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti», n. 3.
Steinberg D.M. (2002), L’auto/mutuo aiuto, Trento, Erickson.
Stella F. (2006), La giustizia e le ingiustizie, Bologna, il Mulino.
Tunisi S. (2016), La ricerca come relazione. L’intervista nelle scienze sociali, Milano, FrancoAngeli.
Weil S. (1979), L’amore di Dio, Roma, Borla.
-
1 Assistente Sociale, Unione dei Comuni Appennino Bolognese.
-
2 Assistente Sociale, Unione dei Comuni Appennino Bolognese.
-
3 L’associazione Papa Giovanni XXIII (APG 23) è stata fondata nel 1968 da Don Oreste Benzi e, da allora, è impegnata sul territorio nazionale e internazionale per contrastare l’emarginazione e la povertà. Per maggiori informazioni https://www.apg23.org/it/la_comunita_papa_giovanni_xxiii/ e https://www.fondazionedonorestebenzi.org/ (consultato il 25/7/2025)
-
4 Il metodo APAC non rivolge l’appellativo di «detenuto», ma quello di «recuperando» al fine di sottolineare l’importanza di porre al centro non il reato commesso, quanto la persona e la possibilità di cambiamento. Questo termine viene ripreso anche nel metodo CEC.
-
5 Le strutture CEC accolgono detenuti definitivi in misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare) e anche sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Accoglie poi imputati agli arresti domiciliari e anche quelli sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Non sono previsti limiti in relazione alla tipologia di reato e neppure criteri relativi alla nazionalità. Sono, tuttavia, esclusi coloro che presentano problemi di tossicodipendenza ai quali viene proposto l’inserimento in strutture predisposte che intrattengono contatti con il SerD.
-
6 Riconosciuta nella Costituzione (si rimanda agli articoli 8, 3, 19 e 13) e altresì nell’ordinamento penitenziario (articolo 1 e articolo 26)
-
7 Si fa riferimento alle note etnografiche redatte in data 11/10/2021.
-
8 Si fa riferimento alle note etnografiche redatte in data 7/10/2021.
-
9 Si fa riferimento alle note etnografiche redatte in data 7/10/2021.
-
10 Si fa riferimento alle note etnografiche redatte in data 27/10/2021.
-
11 Si fa riferimento alle note etnografiche redatte in data 26/10/2021.
-
12 Si fa riferimento alle note etnografiche redatte in data 26/10/2021.
-
13 La citazione di Simone Weil chiarisce la «dimensione relazionale» del cambiamento: «Non possiamo trasformare noi stessi, possiamo soltanto essere trasformati, ma lo possiamo soltanto quando lo vogliamo con tutte le nostre forze» (Weil, 1979, p. 215).
-
14 Ripreso dalle note etnografiche del 4/10/2021.
-
15 Ripresa dal testo della canzone di De André intitolata «nella mia ora di libertà».
Vol. 2, Issue 1, July 2025