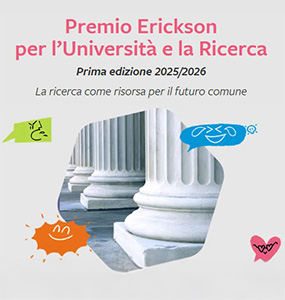Vol. 2, n. 1, Luglio 2025
Ascolto e partecipazione di bambini e ragazzi fuori famiglia
Il punto di vista dei professionisti del settore della protezione dell’infanzia nel Canton Ticino
Sommario
Il presente studio si inserisce nel quadro teorico della partecipazione e dell’ascolto dei bambini e ragazzi nei processi decisionali che li riguardano, diritti sanciti dalla legislazione internazionale. La ricerca presentata è stata realizzata all’interno del progetto «VIVAvoce», realizzato nel Canton Ticino tra il 2021 e il 2023, in collaborazione con la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e le istituzioni cantonali. Il progetto è finalizzato a promuovere il protagonismo di bambini e ragazzi collocati fuori famiglia attraverso la formazione dei professionisti e la sperimentazione di metodiche e strumenti orientati a sostenere il loro ascolto e la loro partecipazione nella costruzione dei progetti di tutela. La ricerca condotta ha coinvolto più di 70 professionisti operanti nel Canton Ticino e ha esplorato le opinioni dei partecipanti riguardo alle pratiche di ascolto e partecipazione dei bambini e ragazzi, nonché le ricadute di tali pratiche sui percorsi di protezione. I risultati evidenziano la necessità di approcci inclusivi e partecipativi che garantiscano ai bambini un ruolo attivo nei propri progetti di vita, migliorando l’efficacia e la sostenibilità degli interventi di tutela.
Parole chiave
Tutela minorile, partecipazione, ascolto, collocamento etero-familiare, allontanamento.
Listening to and involving children and adolescents in out-of-home care
The perspective of Child Protection professionals in Canton Ticino
Camilla Landi3 and Fabio Lenzo4
Abstract
This study is situated in the theoretical framework of children’s participation in decision-making processes that concern them, rights enshrined in international legislation. The research presented was carried out in the context of the «VIVAvoce» project, which will be implemented in the Canton of Ticino between 2021 and 2023, in collaboration with the University of Applied Sciences of Southern Switzerland (SUPSI) and cantonal institutions. The project aims to promote the protagonism of children and adolescents in out-of-home care by training professionals and experimenting with methods and tools to support their listening and participation in the development of protection projects. The research involved more than 70 professionals working in the Canton of Ticino and explored participants’ opinions on listening and participation practices of children and adolescents, as well as the impact of these practices on protection pathways. The findings highlight the need for inclusive and participatory approaches that ensure children play an active role in their life projects, thereby improving the effectiveness and sustainability of protection interventions.
Keywords
Child participation, child protection, children’s rights, child removal, decision-making process.
Premessa
L’ascolto e la partecipazione di bambini e ragazzi ai processi decisionali che riguardano la loro vita sono diritti sanciti dalla legislazione internazionale. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia annovera tra i diritti delle persone di minore età il diritto del fanciullo a esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa e che questa venga tenuta debitamente in considerazione (art. 12). Simili indicazioni si ritrovano anche nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, entrata in vigore nel 2000, che agli articoli 3 e 6 riconosce a bambini e ragazzi il diritto di essere informati e consultati sulle questioni che li riguardano e sulle conseguenze che eventuali decisioni — proprie e/o altrui — potrebbero avere in pratica sulle loro vite. Inoltre, le Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, adottate nel 2010, dichiarano il diritto dei più piccoli di essere ascoltati e di prendere parte ai procedimenti che li vedono coinvolti, tenendo in considerazione il loro grado di maturità e la loro capacità di discernimento.
Negli ultimi decenni, molti Paesi hanno recepito la normativa internazionale all’interno dei propri ordinamenti giuridici, riconoscendo grazie all’emanazione di leggi e linee guida nazionali l’ascolto e la partecipazione di bambini e ragazzi come diritti esigibili. Nonostante la ratifica delle convenzioni sovranazionali e l’impegno profuso dai singoli Stati nel legiferare su un tema tanto delicato, studi e ricerche empiriche testimoniano ancora oggi la «mancata partecipazione» dei più piccoli alla costruzione dei progetti pensati per loro (Toros, 2021) e la conseguente necessità di trovare strategie e strumenti efficaci per fare in modo che questo diritto venga riconosciuto e agito in pratica.
L’articolo presenta il progetto «VIVAvoce», realizzato nel periodo 2021-2023 in Canton Ticino (Svizzera) grazie alla collaborazione tra la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e le istituzioni cantonali, finanziato dal Fondo Diritti della Confederazione. Il progetto, finalizzato a promuovere il protagonismo di bambini e ragazzi collocati fuori famiglia, ha previsto la realizzazione di un percorso di formazione dei professionisti e di sperimentazione di metodiche e strumenti orientati a sostenere il loro ascolto e la loro partecipazione nella costruzione dei progetti di tutela. Il progetto, che ha coinvolto più di 70 professionisti operanti nel Canton Ticino, ha previsto un’attività di ricerca di cui si darà conto in questo contributo.
Ascolto e partecipazione dei bambini e ragazzi collocati fuori famiglia
In ambito internazionale, numerose ricerche hanno raccolto e analizzato opinioni ed esperienze di bambini e ragazzi sottoposti a procedimenti di tutela minorile, relativamente alla loro partecipazione ai processi decisionali che li riguardano. Ciò che emerge dagli studi empirici, però, è generalmente una partecipazione limitata se non, in alcuni casi, del tutto assente (Balsells et al., 2017; Bessell, 2011; Cossar et al., 2016; Calcaterra e Landi, 2021; Middel et al., 2021; Delgado et al., 2023). I bambini riferiscono di sentirsi esclusi dalle decisioni che li riguardano e di avere poche opportunità per esprimere le proprie opinioni e venire ascoltati dai professionisti chiamati a occuparsi della loro protezione e tutela. Anche quando viene permesso loro di prendere parte ai momenti decisionali, la mancanza di adeguate informazioni impedisce a bambini e ragazzi di partecipare in maniera consapevole e spesso non permette loro nemmeno di comprendere appieno le decisioni prese durante l’incontro (Bessell, 2011). Gli studi condotti mostrano come la mancata partecipazione genera nei diretti interessati sentimenti negativi come frustrazione, tristezza e senso di esclusione, tanto che i bambini e gli adolescenti intervistati in numerose ricerche riferiscono di sentirsi impotenti e non considerati (Schoch et al., 2020; Toros, 2021; van Bijleveld et al., 2021). Questi vissuti sembrano acuirsi quando per la tutela dei più piccoli, si rende necessario l’allontanamento dalla famiglia d’origine e il conseguente collocamento etero-familiare (Delgado et al., 2023; Strömpl e Luhamaa, 2020). L’allontanamento viene descritto da chi l’ha vissuto perlopiù come uno shock, un trauma: nelle testimonianze di bambini e ragazzi ricorrono frequentemente sentimenti di tristezza, ingiustizia e forte spaesamento (Fernandez, 2007; Mitchel et al, 2010; Goodyer, 2016), nonché perdita di fiducia nei confronti delle proprie figure genitoriali e degli operatori di riferimento (Šumskiené et al., 2022). Come emerge dagli studi di Winter (2010), queste sensazioni negative sembrano amplificarsi quando i più piccoli non vengono informati adeguatamente su quanto sta accadendo e sulle decisioni che gli adulti stanno prendendo per il loro bene. Alcuni studi mettono in luce che quando gli operatori pianificano e attuano gli allontanamenti, difficilmente ascoltano e tengono in considerazione i desideri e le preferenze dei più piccoli (Pölkki et al., 2012; Delgado et al., 2023). Tale evidenza empirica evidenzia il diffuso paradosso tale per cui gli interventi proposti e realizzati in nome della tutela e del benessere dei bambini non considerano il loro punto di vista, i loro desideri, le loro paure (Šumskiené et al., 2022). Bambini e ragazzi chiedono espressamente di essere coinvolti e informati sulle decisioni che li riguardano e vogliono che la loro voce venga ascoltata e tenuta in considerazione nella definizione del loro percorso fuori famiglia. Anche i più piccoli possono contribuire attivamente alla pianificazione dei propri progetti di tutela e per far ciò è importante che i professionisti si impegnino a costruire con loro relazioni solide e positive, fondate su fiducia e rispetto reciproco (Toros, 2021; van Bijleveld et al., 2021). In particolare, per garantire una reale — e non simbolica — partecipazione da parte di bambini e adolescenti è opportuno che essi ricevano informazioni accurate rispetto ai loro diritti, a quanto sta accadendo nella loro vita, alle ragioni del collocamento etero-familiare, al nuovo contesto di vita che li accoglierà, e che vengano ascoltati in merito al tipo di collocamento, a cosa sarebbe loro d’aiuto nella fase di transizione e nella presa di decisioni durante la realizzazione del progetto (Bianchi et al. 2024).
Negli ultimi decenni, sono stati utilizzati diversi modelli per definire e rendere operativo il concetto di partecipazione. Nonostante la sua longevità, la scala di Hart sulla partecipazione dei bambini (1992; 2008) è tra le più comunemente preferite (Cudjoe et al., 2020; Donnelly, 2010; Kosher e Ben-Arieh, 2020). Hart, a partire dalla scala della partecipazione civica proposta da Arnstein (1969), definisce la partecipazione come un processo di condivisione delle decisioni che influenzano la vita dell’individuo e della sua comunità. La scala della partecipazione dei bambini e ragazzi proposta da Hart descrive otto livelli e per ciascuno di essi evidenzia il ruolo giocato dagli adulti per promuovere la partecipazione dei più piccoli. I primi tre livelli indicano situazioni di non partecipazione (manipolazione, decorazione, tokenismo), mentre il quarto livello segna l’inizio della vera partecipazione, dove i bambini vengono informati dell’iniziativa, decisa dagli adulti, e vengono assegnati loro compiti per realizzarla. Al quinto livello, l’iniziativa è ancora degli adulti, ma i bambini vengono consultati. Il sesto livello prevede una maggiore condivisione delle decisioni, che, pur partendo dagli adulti, vengono negoziate ed elaborate insieme ai bambini. Gli ultimi due livelli rappresentano situazioni di alta partecipazione, con iniziative definite e realizzate autonomamente dai minori, o condivise con gli adulti che ne supportano la realizzazione.
In accordo con Shier (2001), i professionisti che lavorano al fianco di bambini e ragazzi possono svolgere un ruolo molto importante nel favorire la loro partecipazione, avendo cura di offrire loro spazi di ascolto dedicati, sostenendoli nell’esprimere i propri punti di vista e tenendoli in considerazione in fase di presa delle decisioni nonché coinvolgendoli attivamente nella costruzione e nel monitoraggio del progetto di cui sono protagonisti. I punti di attenzione sottolineati da Shier (2001) trovano corrispondenza con gli elementi chiave di un processo partecipativo individuati da Lundy (2007). Nel tentativo di concettualizzare l’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, Lundy (2007) mette a fuoco quattro dimensioni, distinte ma integrate tra loro, adattabili in vari contesti di lavoro con bambini e ragazzi, inclusi quelli scolastici e educativi:
- spazio: garantire uno spazio sicuro e inclusivo per permettere ai ragazzi di esprimere le loro idee;
- voce: supportare i ragazzi nel formare ed esprimere la loro visione;
- audience: assicurare che le idee siano ascoltate con attenzione;
- influenza: garantire che le idee siano concretamente realizzate nelle politiche o nelle azioni di un processo.
In linea con Shier (2001), anche Healy e Darlington (2009) sottolineano l’importanza che i professionisti dell’aiuto adottino degli approcci che riconoscano il diritto all’autodeterminazione delle persone, quindi anche di bambini e ragazzi, e per far ciò è necessario essere trasparenti e comprensibili nel comunicare le proprie valutazioni, mettere a conoscenza anche i più piccoli di ciò che sta accadendo, rispettare ciò che i diretti interessati pensano e le loro capacità e contribuire attivamente affinché tutti abbiano le condizioni per poter partecipare.
Alla luce della letteratura di riferimento e in linea con il paradigma relazionale (Folgheraiter, 2011), i bambini e i ragazzi devono essere considerati come partner attivi nella definizione degli interventi di tutela pensati e messi in campo per il loro benessere. Al pari degli adulti, anche ai più piccoli va riconosciuto un sapere esperienziale, unico e soggettivo, che deriva dalle esperienze che hanno vissuto e che è imprescindibile quando ci si trova a dover prendere delle decisioni che andranno a incidere sulla loro vita.
Garantire l’ascolto e la partecipazione non significa, però, delegare ai più piccoli la responsabilità ultima delle decisioni prese, bensì offrire loro la possibilità di esprimere i propri desideri e le proprie preoccupazioni, garantendo che questi vengano tenuti debitamente in considerazione nei processi valutativi e decisionali che li riguardano (Landi e Malvestiti, 2020; 2023). Il diritto ad essere ascoltati e di vedere le loro opinioni essere tenute debitamente in considerazione, infatti, non implica necessariamente accogliere tutte le richieste e le proposte avanzate da bambini e ragazzi e, soprattutto, non determina necessariamente la decisione finale. La responsabilità decisionale rimane in capo agli adulti che nella scelta dovranno valutare l’interesse superiore del fanciullo come considerazione preminente (Pazè, 2014; Calcaterra, 2014).
In conclusione, l’ascolto e la partecipazione dei più piccoli sono da considerarsi un diritto, uno strumento per accedere ai valori fondamentali, quali l’inclusione e la democrazia (Bouma et al., 2018) ma anche una necessità, data dal fatto che i bambini e ragazzi chiedono di poter prendere parte alla costruzione dei loro progetti di aiuto ed è dimostrato che quando questo succede gli interventi che ne conseguono sono migliori in termini di efficacia e sostenibilità (Winter, 2010; Calcaterra e Landi, 2021).
Il sistema di protezione minorile in Svizzera: breve inquadramento del contesto5
In Svizzera, il sistema di protezione e tutela delle persone di minore età presenta modalità di funzionamento diverse nei 26 cantoni che compongono la Confederazione.6 Questa diversificazione deriva dalla suddivisione delle competenze, regolata dal principio di sussidiarietà, tra i tre livelli istituzionali: Confederazione, Cantoni e Comuni. In questo contesto, la protezione dell’infanzia ricade principalmente sotto la responsabilità dei Cantoni e dei Comuni, che hanno il compito di organizzare e gestire interventi e servizi a livello locale.
Nonostante questa suddivisione, la Confederazione mantiene un ruolo di supervisione attraverso l’Ufficio federale di giustizia (UFG7), che ha il mandato di verificare e garantire che gli istituti dedicati all’educazione e alla protezione di bambini e adolescenti rispettino i requisiti minimi previsti dalla legge per la loro autorizzazione e il loro riconoscimento.
A livello cantonale, l’assistenza e la protezione di bambini, adolescenti e delle loro famiglie è affidata a due uffici specifici. Il primo è l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG8), che ha il compito di coordinare, sovvenzionare e vigilare sulle attività e i servizi che rientrano nelle politiche per famiglie, giovani e bambini. Tra le strutture e i servizi che ricadono sotto la sua competenza figurano, ad esempio, le comunità educative residenziali e semiresidenziali, i servizi di educativa domiciliare e gli asili nido. La maggior parte di questi servizi è gestita da Fondazioni o associazioni appartenenti al Terzo settore, alle quali il Cantone garantisce un supporto economico tramite i contratti di prestazione che regolano il finanziamento degli enti e le modalità operative.
Il secondo ufficio è l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP9) che si occupa sia di fornire supporto sociale e assistenza a favore dell’infanzia e delle famiglie, sia di intervenire in favore di adulti che si trovano in situazioni di vulnerabilità. Questo ufficio rappresenta un punto di riferimento diretto per le persone e le famiglie che necessitano di aiuto e sostegno.
L’ambito giuridico è presidiato dall’Autorità regionale di protezione (ARP10), un organo amministrativo decentrato appartenente alla giustizia civile e istituito dalla legislazione federale. La sua funzione principale è quella di intervenire quando risulta necessario adottare misure di protezione a favore della popolazione che, per vari motivi, può necessitare di assistenza e interventi di tutela, quali ad esempio l’allontanamento del minore dalla propria famiglia d’origine. Come previsto dall’ordinamento giuridico italiano, anche in Svizzera il diritto di protezione di bambini e adolescenti prevede che lo Stato debba intervenire nella sfera privata e famigliare, assicurando le necessarie misure di aiuto e protezione, quando la loro salute e il loro sviluppo fisico, psichico o sociale sono minacciati.11
Le misure previste dall’ordinamento giuridico cantonale per tutelare bambini e adolescenti in condizione di pregiudizio sono l’attivazione di interventi di sostegno alla genitorialità tramite il supporto educativo domiciliare, la disposizione di curatele (art. 308 C.C.), l’affido temporaneo ad altri componenti della famiglia se disponibili oppure ad affidatari al di fuori della cerchia parentale, oppure il collocamento in comunità educative. Il collocamento fuori famiglia di un bambino/ragazzo deve essere considerato una soluzione di ultima istanza, ovvero «extrema ratio». Questo significa che viene adottato solo quando tutte le altre misure di assistenza e supporto per il bambino e la sua famiglia si sono rivelate inefficaci o insufficienti a garantire il benessere e la protezione.
Attualmente, nel Canton Ticino non sono disponibili dati statistici attendibili relativi ai minori collocati fuori famiglia. Si stima che, su un totale di 62.877 (al 31.12.2023) di minorenni residenti in maniera permanente nel Canton Ticino, circa 700 bambini e adolescenti vivono al di fuori della propria famiglia d’origine, collocati in strutture residenziali o presso famiglie affidatarie (Da Vinci e Lenzo, 2025).
Il progetto «VIVAvoce: la partecipazione di bambini e ragazzi nel percorso di collocamento fuori famiglia»
Il progetto «VIVAvoce» si inserisce in questo contesto e prende avvio da un’analisi preliminare dei dati cantonali sui collocamenti nelle comunità educative. Le considerazioni espresse dai professionisti del settore evidenziano un incremento della complessità delle situazioni con le quali si confrontano quotidianamente nello svolgimento del proprio lavoro.
L’aumento di situazioni di disagio composite e multidimensionali, come, ad esempio, la compresenza di difficoltà educative, precarietà economica ed esclusione dal mercato del lavoro, difficoltà di carattere psico-sociale e relazionale, isolamento sociale, difficoltà di carattere psicologico, può incidere significativamente sulla qualità delle risposte che le famiglie riescono ad offrire per far fronte ai bisogni evolutivi dei propri figli (Serbati e Milani, 2013).
La numerosità dei servizi coinvolti (servizio sociale, educativa domiciliare, comunità educative, servizi medico-psicologici, scuole, servizi per l’infanzia, consultori familiari) rende necessaria — nonché imprescindibile per la buona riuscita degli interventi socioeducativi — la definizione di un unico percorso progettuale congiunto e coordinato nella rete di sostegno. Per assicurare l’attivazione di sostegni tempestivi ed efficaci, in un’ottica di intervento integrato e multidisciplinare, risulta cruciale la collaborazione interprofessionale tra operatori appartenenti a servizi con mandati differenti. La capacità di costruire pratiche condivise di lavoro in rete, fondate su un coordinamento intenzionale e sulla negoziazione di ruoli e responsabilità, rappresenta una condizione imprescindibile che non può essere data sempre come acquisita. Le specificità progettuali di ogni servizio e le difficoltà della rete di sostegno nel trovare convergenze sugli obiettivi creano momenti di «stand-by» nella progettazione e attuazione dell’intervento a tutela dei più piccoli, con conseguente dilatazione dei tempi per le famiglie e i bambini e diminuzione dell’efficacia dei progetti pensati per loro (Lenzo et al., 2018).
Gli elementi significativi emersi evidenziano, da una parte, le difficoltà nel coordinare i momenti di ascolto fra i vari attori che intervengono nel percorso di tutela, in particolar modo nella pianificazione del collocamento etero-familiare dei più piccoli, dall’altra la consapevolezza di dover sviluppare competenze, metodologie e strumenti più adatti a favorire il dialogo con i diretti interessati, in particolare i bambini e i ragazzi, che spesso non vengono ascoltati né coinvolti nei processi decisionali che li riguardano.
A fronte di questa lettura, il progetto «VIVAvoce» si è concentrato sullo sviluppo di metodologie di lavoro volte a favorire la partecipazione e l’ascolto di bambini e ragazzi collocati fuori dalla propria famiglia d’origine, in particolar modo nei Centri Educativi per Minorenni (CEM). Le azioni progettuali previste mirano ad aumentare la possibilità per bambini e ragazzi di incidere sulle decisioni relative ai propri progetti di vita, al fine di creare dei progetti educativi maggiormente rispondenti alle loro esigenze e ai loro bisogni specifici, e quindi maggiormente efficaci (Winter, 2010).
Partendo dal presupposto che «per sostenere lo sviluppo di un sistema maggiormente inclusivo nei confronti delle famiglie e dei bisogni del bambino, risulta imprescindibile un lavoro sulla dimensione inter-istituzionale» (Lenzo et al., 2020, p. 33), unito a un processo di accompagnamento formativo e riflessivo nei singoli servizi. Si è dunque optato per adottare un approccio di co-costruzione del progetto con i principali attori che operano nell’ambito della protezione: ARP, UAP, CEM e UFaG.
È stato sviluppato un percorso di formazione e sperimentazione nei servizi che si occupano della protezione dell’infanzia, con i seguenti obiettivi specifici: (1) aggiornare e sviluppare le competenze degli operatori che lavorano al fianco di minori e famiglie; (2) sperimentare metodologie partecipative e strumenti di lavoro con gli operatori attivi nella rete cantonale; (3) valorizzare le buone pratiche sperimentate.
Il target principale del progetto comprende i professionisti attivi nei Centri Educativi per Minorenni del territorio ticinese, dove sono accolti bambini e adolescenti (0-18 anni), gli assistenti sociali del servizio sociale e i professionisti delle Autorità Regionali di Protezione.
Il progetto ha coinvolto tutte le comunità educative attive sul territorio cantonale eccetto una, circa la metà dei servizi sociali territoriali e una rappresentanza delle Autorità, per un totale di 76 professionisti.
Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi:
- co-costruzione del percorso: decidere con i professionisti coinvolti la struttura e le tematiche del percorso formativo e tempi e modalità per la sperimentazione (gennaio-settembre 2022);
- formazione: fornire ai professionisti teorie, metodologie e strumenti per promuovere la partecipazione di bambini e ragazzi (ottobre 2022-febbraio 2023; n. 6 giornate per un totale di n. 48 ore di formazione);
- sperimentazione: implementare quanto appreso durante la formazione nei propri contesti di lavoro (marzo-giugno 2023);
- monitoraggio: documentare e sistematizzare le pratiche sperimentate e i risultati delle azioni (aprile-luglio 2023);
- valorizzazione: promuovere e diffondere le esperienze all’interno della rete territoriale dei servizi (luglio-dicembre 2024).
L’attività di sperimentazione è stata supportata da percorsi di supervisione, sia di gruppo che individuali, guidati da professionisti esperti di pratiche partecipative, con l’obiettivo di accompagnare l’apprendimento delle metodologie di espressione e ascolto di bambini e ragazzi, e di sostenere metodologicamente gli operatori nell’implementazione delle sperimentazioni nella propria pratica professionale. Le tappe che si sono susseguite alla formazione iniziale mirano a «costruire senso» attorno alle prassi professionali sviluppate, monitorandone i processi di lavoro per renderli più facilmente replicabili da altri professionisti dello stesso servizio/ente e da altre realtà professionali simili.
Finalità e metodologia della ricerca
Dati il carattere innovativo e la portata del progetto, in fase di pianificazione è stata prevista un’azione di ricerca finalizzata a esplorare i significati attribuiti dai professionisti partecipanti all’iniziativa al costrutto di partecipazione e alle pratiche di ascolto messe in atto nel lavoro con bambini e ragazzi collocati fuori famiglia.12
Più precisamente, l’obiettivo era esplorare l’opinione dei professionisti circa gli elementi che definiscono le pratiche di ascolto di bambini e ragazzi e il loro punto di vista in merito a ciò che le esperienze di partecipazione alla definizione dei percorsi di protezione producono in termini di ricadute ed esiti.
Per perseguire tale finalità, è stato adottato un approccio alla ricerca di tipo qualitativo (Corbetta, 2003). Lo strumento proposto è un questionario composto da due domande a risposta chiusa finalizzate a raccogliere informazioni relative alla professione svolta dai rispondenti e le loro percezioni relative al lavoro inter-istituzionale per la tutela e protezione di bambini e ragazzi (di cui, però, non si darà conto in questo contributo) e tre domande a risposta aperta per esplorare i significati attribuiti dai partecipanti alle pratiche di ascolto e le loro opinioni ed esperienze circa le ricadute derivanti dalla partecipazione dei più piccoli nei percorsi di aiuto che li riguardano.
La somministrazione del questionario a tutti i partecipanti al progetto è avvenuta in due momenti distinti: una prima somministrazione è stata effettuata in fase di avvio del percorso formativo, mentre la seconda al termine dello stesso.
La scelta di utilizzare questionari strutturati con domande per lo più a risposta aperta ha consentito di raccogliere dati qualitativi ricchi e articolati, dando voce ai partecipanti e favorendo l’espressione di punti di vista soggettivi (Corbetta, 2003; Caselli, 2024). Tuttavia, il campione ristretto e selezionato limita la possibilità di generalizzare i risultati, che rimangono comunque significativi per il contesto del progetto pilota.
L’insieme dei partecipanti al progetto è costituito da 76 professionisti afferenti ai principali servizi attivi nel settore della protezione dei minori nel Canton Ticino: 44 educatori impiegati in 11 delle 12 comunità di accoglienza per minorenni presenti sul territorio cantonale, 20 assistenti sociali e curatori del Servizio Sociale, che rappresentano circa il 50% degli effettivi totali impiegati nei servizi sociali del Canton Ticino, e 12 rappresentanti delle autorità di protezione (ARP), ossia professionisti con ruoli decisionali chiave nel garantire la tutela e la protezione dei minori.
Nella prima rilevazione, di cui si darà conto in questo contributo, hanno preso parte alla somministrazione 65 professionisti, di cui 39 educatori, 18 assistenti sociali e curatori e 8 rappresentanti dell’autorità di protezione, mentre nella seconda rilevazione il questionario è stato compilato da 43 partecipanti, di cui 27 educatori, 13 assistenti sociali e curatori e 3 rappresentanti dell’autorità di protezione.13
La composizione del campione è diversificata ed eterogenea e rispecchia la molteplicità degli attori coinvolti nei processi di protezione, offrendo una prospettiva ampia e multidisciplinare sui temi trattati all’interno del progetto.
Le risposte scritte fornite dai partecipanti sono state analizzate utilizzando un metodo di analisi del contenuto di tipo qualitativo, volto a identificare ricorrenze, significati attribuiti e categorie emergenti (Braun e Clarke, 2006; Di Fraia e Risi 2019). I temi principali sono stati categorizzati, facendo riferimento ai concetti teorici sopra citati. In particolare, l’analisi delle risposte è stata condotta a partire dai livelli di partecipazione proposti da Hart (1992; 2008). Ciascuna risposta è stata esaminata nel dettaglio e ricondotta alla categoria corrispondente, in funzione degli elementi emersi e della coerenza con il quadro teorico adottato. Successivamente, sono state individuate e raggruppate le principali ricorrenze, con particolare attenzione alle tematiche relative alle pratiche di ascolto e alle strategie per promuovere la partecipazione di bambini e ragazzi. Seppur non sia stato possibile attribuire a tutte le risposte un corrispettivo nella scala, una parte di esse si presta a interessanti considerazioni rispetto ai livelli maggiormente richiamati ed esemplificati dai professionisti.
L’analisi dei dati ha consentito, da un lato, di esplorare le condizioni e gli accorgimenti che i professionisti ritengono importanti per favorire l’ascolto di bambini e ragazzi, dall’altro di mettere in luce le ricadute che le esperienze di partecipazione nei progetti di tutela hanno per i più piccoli.
Come anticipato, nell’articolo vengono presentati e discussi i risultati emersi dalla prima somministrazione del questionario (T0) poiché i percorsi formativi dei diversi gruppi di professionisti sono evoluti in modo differente a seguito del processo di co-costruzione in itinere delle attività di formazione e sperimentazione e ciò non avrebbe permesso di fare una lettura comparata dei dati. Più precisamente, durante la prima fase i partecipanti hanno espresso bisogni formativi differenti, dettati dal loro ruolo e dal loro specifico mandato professionale, che hanno portato i responsabili del progetto a ridefinire le azioni delineando tre diversi percorsi dedicati ai tre gruppi di professionisti. Inoltre, si precisa che non tutti i rispondenti alla prima rilevazione hanno preso parte alla successiva somministrazione poiché impegnati in altre attività formative contestuali al progetto.
Cosa pensano i professionisti sull’ascolto di bambini e ragazzi
I dati mettono in luce che la maggioranza dei professionisti ha risposto alla domanda relativa a cosa significa ascoltare i bambini e ragazzi focalizzandosi sugli accorgimenti metodologici che connotano il proprio modo di lavorare. Piuttosto che concentrarsi sul significato concettuale dell’ascolto, i rispondenti sembrano aver posto maggiore attenzione alle strategie e alle modalità operative adottate per rendere più efficaci i momenti di incontro e dialogo con i bambini e ragazzi. Tra gli elementi metodologici maggiormente citati, emergono con particolare rilevanza l’attenzione agli aspetti legati alla comunicazione verbale e non verbale, considerati fondamentali per instaurare una relazione positiva e favorire l’espressione dell’altro. Il tema del non giudizio si rivela altresì centrale, così come testimoniamo le seguenti risposte: «per me significa non giudicare, favorire un clima di espressione del ragazzo» (C25); «ascoltare in modo attivo e non giudicare. Dar valore alle parole» (U1); «far sentire loro che ci tengo e che sono lì per loro: vicinanza emotiva, empatia, non giudizio e sostegno/accompagnamento» (C19). I professionisti ritengono questo aspetto essenziale per creare un ambiente sicuro, accogliente e rispettoso, in cui bambini e ragazzi si sentano liberi di esprimere il proprio punto di vista senza timore di essere criticati.
Un ulteriore elemento ricorrente riguarda la costruzione e l’adattamento dello spazio di ascolto, non solo da intendersi come setting spazio-temporale ma anche come apertura e disponibilità all’incontro e alla relazione con bambini e ragazzi. In particolare, alcuni fanno riferimento all’importanza di «creare uno spazio idoneo in cui confrontarsi» (C32); «investire tempo, spazio e metodi definiti. Favorire la costruzione di una relazione costruttiva, rispettosa dei diritti e autorevole» (C13). Gli operatori intervistati sottolineano l’importanza di predisporre ambienti adeguati, modulati in base all’età e alle caratteristiche dei propri interlocutori, nonché alle finalità specifiche del colloquio. In sintesi, questi accorgimenti permettono di facilitare l’incontro e il dialogo e di rendere l’interazione più efficace e funzionale rispetto all’obiettivo del colloquio.
Un altro aspetto metodologico ritenuto cruciale dai rispondenti è l’impiego di mediatori relazionali (attività, strumenti, giochi, albi illustrati) finalizzati a incentivare e sostenere l’espressione del punto di vista del bambino. L’uso di strumenti e tecniche specifiche è percepito da molti come un supporto fondamentale per garantire un ascolto efficace e inclusivo.
Infine, emerge con forza la necessità di definire tempi e momenti specifici durante il processo di aiuto da dedicare agli incontri con i più piccoli: «fornirgli uno spazio adeguato per potersi esprimere così come fargli scegliere la modalità» (C5); «garantire tempo e uno spazio adeguato (a misura di bambino/ragazzo) nel quale poter esprimere (verbalmente o non) la loro opinione» (C6) in modo da valorizzare questi momenti di scambio e confronto e considerarli delle azioni strutturate, necessarie e continuative lungo il percorso di collocamento fuori dalla famiglia di origine.
Promuovere un clima relazionale favorevole, basato sulla chiarezza delle responsabilità di ciascuno, sul riconoscimento dei diritti e sul rispetto dell’individualità, è indicato dai partecipanti al progetto come un ulteriore fattore determinante per il successo delle pratiche di ascolto. Un aspetto aggiuntivo che emerge dalle risposte dei partecipanti è dunque l’importanza della dimensione relazionale. Alcuni professionisti sembrano concepire le pratiche di ascolto perlopiù come vere e proprie occasioni costanti nel tempo per instaurare una relazione con il bambino/ragazzo con cui stanno lavorando: «prendere il tempo per un autentico ascolto senza pregiudizio» (C39); «mantenere con loro un regolare contatto prima, durante e dopo il loro collocamento per potersi assicurare del loro stato di benessere» (U10); «significa essere presenti nei momenti positivi e negativi delle loro vite» (C24).
Una parte nettamente minoritaria riguarda, invece, coloro che associano l’ascolto dei più piccoli alle funzioni di advocacy che, in quanto operatori, potrebbero svolgere a favore di bambini e ragazzi durante il collocamento in comunità o in affido familiare: «essere garante nel trasmettere la sua voce, dar credito ai bisogni dell’utente» (C29); «coinvolgerli e renderli protagonisti del loro progetto di vita. Riportare il loro punto di vista al resto della rete formale e informale» (U2).
Uno degli aspetti emersi nell’analisi delle risposte riguarda l’interpretazione dell’ascolto e della partecipazione solo come momento finalizzato a raccogliere dal bambino informazioni utili, a partire dalle quali prendere poi delle decisioni e progettare interventi, senza però prevedere in questa fase un coinvolgimento attivo dei diretti interessati. Questa lettura solleva questioni di natura metodologica ed etica, in quanto rischia di ridurre l’ascolto a una funzione strumentale, utile all’operatore per il raggiungimento dei propri obiettivi, piuttosto che considerarlo come un processo relazionale e partecipativo. Alcune risposte date dagli operatori ci portano a sostenere l’idea che questo rischio possa essere presente: «significa avere delle informazioni in più su cui basare le decisioni» (C37); «è importante poter sentire la loro versione/posizione in merito alle decisioni, poter percepire la loro adesione/contrarietà nel progetto» (A2); «significa ascoltare quanto racconta e quanto non ci racconta» (U17), «raccogliere punto di vista, desideri, stati d’animo del minore. Dargli voce e spiegargli il percorso» (A1). Se da un lato è innegabile che la raccolta di informazioni sia una componente essenziale di alcune fasi del processo di aiuto, dall’altro permangono dubbi e rischi sulla sovrapposizione integrale dell’ascolto a questa funzione. Tale visione potrebbe limitare la dimensione dialogica nel processo di aiuto, rischiando di considerare le persone con cui si lavora solo come meri informatori, a cui comunicare decisioni già prese e non negoziabili.
Questa prospettiva sottolinea la necessità di un approccio più ampio, in cui l’ascolto venga valorizzato non solo come strumento operativo, ma anche — e soprattutto — come elemento centrale nella costruzione di una relazione di aiuto paritaria ed efficace nonché nella promozione della partecipazione attiva delle persone coinvolte, piccole o grandi che siano, in un’ottica di co-costruzione dei progetti di collocamento etero-familiare.
I dati fino a qui analizzati suggeriscono che l’ascolto di bambini e ragazzi, così come inteso dai professionisti intervistati, sia di difficile definizione e descrivibile per lo più grazie a una serie di accorgimenti operativi volti a favorire la comunicazione, la comprensione e l’espressione. Tali strategie risultano essere parte integrante del lavoro degli operatori e riflettono un approccio pragmatico che pone l’attenzione sulle condizioni e sulle modalità attraverso cui l’ascolto può essere reso più efficace e significativo, senza però fare riferimento al contributo diretto che bambini e ragazzi possono portare nella costruzione del proprio percorso di protezione.
Quando ascolto significa partecipazione
In un terzo dei casi circa le definizioni di ascolto elaborate dai rispondenti sono riconducibili, più o meno direttamente, al concetto di partecipazione. In questi casi, le risposte possono essere analizzate facendo riferimento alla scala della partecipazione elaborata da Hart (1998; 2002). L’analisi si concentra essenzialmente sui livelli di partecipazione denominati «informazione», «consultazione» e «decisioni condivise», e cercherà di mettere in evidenza le principali sfaccettature nominate dai professionisti.
Il quarto livello della scala di partecipazione di Hart si caratterizza per un coinvolgimento perlopiù informativo all’interno dei processi decisionali: i bambini vengono informati sulla loro situazione e sulle decisioni che gli adulti hanno preso (o hanno intenzione di prendere) per il loro bene. In questa accezione, il punto di vista di bambini/ragazzi non per forza concorre alla definizione delle scelte. Alcune delle risposte date dai professionisti enfatizzano proprio questa dimensione informativa attribuita alle pratiche di ascolto: risposte quali «far capire se sono consapevoli del “perché” si trovano in un percorso di collocamento» (C38), «Spiegare ai bambini, nel loro linguaggio […] le motivazioni del collocamento e i passi da percorrere» (C33), «permettere all’infante di comprendere il motivo del suo collocamento al fine di permettergli di viverlo serenamente» (C27), «[…] permettergli di comprendere le procedure in essere» (A5) sembrano rimandare a finalità esclusivamente di natura informativa, in cui i professionisti comunicano a bambini e ragazzi accadimenti e decisioni precedentemente prese relativamente al loro progetto fuori famiglia. Queste risposte sottolineano l’importanza di garantire ai più piccoli una comprensione chiara di ciò che gli adulti stanno comunicando loro, delle decisioni prese e delle ragioni che stanno alla base di tali scelte, che più o meno direttamente andranno a incidere sulla vita di bambini e ragazzi. Alcuni operatori hanno messo in risalto la possibilità, quando si informa il bambino, di «affrontare [con lui/lei] temi personali e delicati» (U3), evidenziando il valore della costruzione di una relazione professionale di aiuto, il cui scopo va oltre lo scambio di informazioni. Questo passaggio è cruciale per evitare forme di partecipazione perlopiù simboliche e per garantire che le persone di minore età si sentano protagoniste del proprio progetto, seppur all’interno di un modello in cui la responsabilità decisionale rimane legittimamente in capo agli adulti.
Il quinto livello aggiunge all’informazione la consultazione, rendendo il processo decisionale potenzialmente attento e permeabile agli spunti e alle interpretazioni espresse dal bambino/ragazzo. Alcune delle risposte ricondotte al quinto livello evidenziano chiaramente questa dinamica: le seguenti citazioni «significa prendersi un momento per avere uno scambio con i ragazzi, un dialogo dove si arriva poi a trovare una decisione tramite uno scambio prendendo in considerazione l’idea/opinione del ragazzo» (C18), «significa tenere in considerazione l’opinione del bambino/ragazzo. Fattore estremamente importante dal momento in cui si parla del suo progetto di vita» (C4) mettono in luce come il professionista possa contribuire attivamente e consapevolmente a includere il punto di vista dei più piccoli nelle fasi decisionali riguardanti il progetto di collocamento etero-familiare. Per concretizzare ciò, appare centrale garantire spazi di ascolto e offrire strumenti per facilitare l’espressione del bambino.
Il sesto livello segna un passaggio fondamentale nella partecipazione dei più piccoli, poiché si riferisce a un processo decisionale marcatamente co-costruito tra adulti e bambini. In questo livello, il loro contributo viene ascoltato e preso in considerazione nella presa di decisioni, riconoscendo e sostenendo le capacità della persona di minore età di esprimere opinioni e influenzare le scelte che andranno a incidere sul proprio percorso di vita. Troviamo alcuni riferimenti a questo livello nel seguente passaggio, in cui l’operatore sottolinea che l’ascolto è finalizzato a «costruire assieme un progetto reale e realizzabile» (C21). Il riferimento a «permettere di decidere. Incoraggiare a dar voce a sé stesso» (C17) sottolinea l’importanza di promuovere l’auto-espressione e l’autodeterminazione nel rispetto dell’autenticità della persona. In questo caso, il rispondente sembra fare riferimento al contributo che gli operatori possono mettere in campo per incoraggiare e sostenere un processo emancipatorio, all’insegna dell’empowerment. Inoltre, alcune risposte rinforzano l’idea di «collaborare, capire, costruire assieme, sostenere. Dare voce per sviluppare un progetto» (C31). In questo caso il bambino/ragazzo passa dell’essere il «destinatario delle decisioni» ad attore protagonista delle scelte che lo riguardano. Il professionista è comunque chiamato a rendere il contesto accessibile affinché le persone coinvolte possano prendere parte attivamente e in modo incisivo ai processi decisionali relativi al proprio progetto di protezione. Il bambino/ragazzo, oltre ad essere consultato e informato, è così messo nella condizione di diventare un attore riconosciuto nel processo decisionale e il suo punto di vista ha un peso effettivo, contribuendo a modellare e definire le scelte.
I benefici delle pratiche partecipative
Dall’analisi del quesito relativo alle pratiche partecipative e alle ricadute che queste possono avere nella vita dei bambini e ragazzi, i professionisti intervistati appaiono concordi nell’esprimere che il loro coinvolgimento nelle differenti fasi del progetto fuori famiglia garantisce una maggiore efficacia del percorso di aiuto e tutela. Dalle risposte si evince che i percorsi fuori famiglia che incoraggiano la partecipazione attiva di bambini e adolescenti generano ricadute positive sui percorsi educativi e di crescita. La personalizzazione dei progetti, il rafforzamento del protagonismo, i processi decisionali partecipati, la tutela dei diritti e un clima relazionale più inclusivo e accogliente sono i principali elementi emersi dall’analisi delle risposte al quesito posto nel questionario.
Le risposte dei partecipanti possono essere ricondotte a quattro categorie che sintetizzano i principali benefici emergenti da un approccio partecipativo nell’ambito della protezione. Di seguito riassumiamo le categorie a cui è possibile ricondurre le risposte del campione.
- Progettazione individualizzata. Risposte quali «rendere il bambino/adolescente partecipe nella creazione del PEI, accogliere i suoi bisogni e renderlo attore protagonista del suo progetto» (C1), «rendere più efficace il progetto e l’intervento. Favorire consapevolezza e co-partecipazione. Limitare dispersione e interruzioni di percorsi» (C13), «metterli al centro del proprio progetto, non giudicarli e sostenerli positivamente. Coinvolgerli nel loro processo decisionale» (C23), «identificarsi col progetto e investire le energie utili e necessarie al raggiungimento degli obiettivi» (U14), «costruire un progetto specifico per ognuno» (A2), ci invitano a considerare la partecipazione attiva dei bambini nei percorsi fuori famiglia come un elemento chiave che garantisce una reale personalizzazione degli interventi. Questo approccio consente di rispondere con maggior aderenza ai bisogni specifici di ogni bambino o ragazzo, adattando i progetti alle loro caratteristiche e potenzialità e alla situazione generale che stanno affrontando.
- Promozione del protagonismo e della motivazione a partecipare al proprio progetto. Questo tema trova spazio nelle seguenti considerazioni: «una partecipazione attiva garantisce maggiore successo nei vari percorsi, diventando protagonisti del proprio progetto» (C16), «renderli protagonisti il più possibile della loro vita e del loro progetto di vita che se è compreso e condiviso viene potenziato ulteriormente» (C21), «renderli maggiormente protagonisti delle loro vite. Rendere il percorso di collocamento più specifico e appropriato ad ogni ragazzo» (C34). La partecipazione diretta dei bambini nei percorsi di aiuto e tutela sembra tradursi nel concreto in un maggiore protagonismo da parte di bambini e ragazzi e questo può determinare, a detta dei rispondenti, una maggiore motivazione e un più forte coinvolgimento nel progetto stesso poiché sentito come «proprio» e autentico.
- Definizione di scelte e processi decisionali maggiormente condivisi. Determinate risposte hanno messo al centro i processi decisionali: «[…] coinvolgerli nelle decisioni e stabilire con lei/lui gli obiettivi del collocamento» (C15); «renderli partecipi delle varie decisioni che vengono prese» (C18); «[…] valorizzare il suo pensiero, oltre che favorire maggiore consapevolezza sulla sua situazione e sui suoi vissuti ed essere in chiaro sul suo progetto futuro» (U3). Sostenere la partecipazione sembra quindi favorire la condivisione delle scelte e dei processi decisionali tra bambini, famiglie e professionisti. Tale processo concorre alla co-costruzione dei progetti di tutela e può sostenere la creazione di un clima relazionale positivo, caratterizzato da maggiore fiducia e reciprocità.
- Tutela dei diritti. Alcune risposte offerte dai professionisti, quali «tutelare i diritti del minore e farlo protagonista della sua storia» (C13), «la vera protezione del minore passa attraverso la sua partecipazione!» (U12), «rispetto della loro persona» (A7), sembrano rimandare al fatto che un intervento basato sulla partecipazione contribuisce al rafforzamento della consapevolezza dei diritti dei bambini da parte dei piccoli ma anche degli adulti chiamati a promuovere il loro benessere. La possibilità di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltati all’interno dei contesti di tutela dell’infanzia si fonda, infatti, sul riconoscimento e sul rispetto dei principi fondamentali della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Conclusioni e implicazioni per la pratica
L’esperienza condotta all’interno del progetto «VIVAvoce» ha confermato l’importanza della partecipazione attiva di bambini e ragazzi nei processi decisionali che li riguardano. L’analisi dei dati induce a pensare che la partecipazione dei bambini e dei ragazzi rappresenti un principio ampiamente condiviso e auspicato da tutti i soggetti coinvolti. Tuttavia, la sua concreta attuazione nelle prassi operative dei servizi appare disomogenea, evidenziando una distanza tra l’intenzionalità dichiarata e le effettive modalità di implementazione da parte dei diversi attori coinvolti nel settore della protezione. Inoltre, è come se i partecipanti alla ricerca avessero ben chiari gli accorgimenti metodologici per gestire efficacemente un colloquio con un bambino o ragazzo (ambiente sicuro, clima di non giudizio, capacità di ascolto, ecc.), ma non il fine per il quale si debba promuovere l’ascolto e la partecipazione dei più piccoli nella costruzione dei loro percorsi fuori famiglia. Questa considerazione trova conferma nelle risposte dei partecipanti che confondono l’ascolto e la partecipazione con meri colloqui in cui raccogliere informazioni relative alla vita del bambino e della sua famiglia. Alla luce dei dati raccolti, si sottolinea la necessità di lavorare con un approccio maggiormente inclusivo e partecipato, che possa garantire a bambini e ragazzi un ruolo attivo all’interno del proprio percorso di tutela al di fuori della famiglia d’origine. I professionisti dell’aiuto hanno un ruolo decisivo nel facilitare la partecipazione dei bambini attraverso relazioni di aiuto costruite nel tempo — curate con continuità — che considerino sempre le situazioni specifiche dei bambini e delle loro famiglie (Toros, 2021).
Una possibile sfida per il futuro consiste quindi nell’assicurare che l’ascolto e la partecipazione si traducano in prassi operative sistematiche, con finalità ancorate alle evidenze scientifiche, alle linee guida riconosciute a livello internazionale e coerenti tra i vari servizi. A tal proposito, però, i dati mettono in luce la necessità, in primis, di creare una base comune e condivisa tra i professionisti dell’aiuto rispetto a ciò che significa «ascolto» e «partecipazione» e alle finalità dei momenti di ascolto soprattutto nella progettazione e realizzazione di percorsi fuori famiglia, e in seconda battuta di continuare a lavorare per potenziare le occasioni di incontro con i più piccoli affinché siano sempre più efficaci, presenti con continuità nella pratica professionale e capaci di rispondere alle esigenze di tutti gli attori coinvolti. Per far ciò, può ritenersi opportuno adottare metodologie e strumenti specifici che favoriscano l’ascolto e la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi. Questo può includere l’uso di mediatori relazionali, come attività, giochi e strumenti visivi, per facilitare l’espressione di bambini e ragazzi.
La rappresentazione che gli operatori hanno del proprio operato a tutela dei più piccoli sembra mostrare una «tensione» tra la necessità di proteggere il bambino — aspetto spesso determinante e fondamentale nonché sancito dall’articolo 3 della Convenzione ONU — e il diritto dei minorenni di essere ascoltati e di prendere parte attivamente al proprio progetto di tutela. Riconoscere questa tensione significa definire il concetto di «tutela» assumendo che la partecipazione è una dimensione fondamentale del benessere, così come della buona riuscita dei percorsi di protezione. Il lavoro progettuale è così inteso come «progettare con» e non «progettare per» o «al posto di», in un’ottica di promozione di contesti professionali e istituzionali che valorizzino la voce dei bambini e ne sostengano la capacità di agire. In questa prospettiva, si rende necessario offrire reali opportunità di ascolto, creare spazi decisionali e riconoscere che ciò contribuisce alla costruzione di esperienze autentiche di partecipazione e sostiene la cittadinanza attiva (Biffi et al., 2023). Il diritto di ascolto e partecipazione non è considerato in opposizione a quello di protezione, ma costituisce una componente essenziale per avviare reali processi di empowerment e per sostenere l’agency delle persone coinvolte, in primis di bambini e ragazzi (Folgheraiter, 2011; Toros, 2021). Una questione centrale, non tematizzata dai partecipanti alla ricerca, è che l’ascolto non è sinonimo di responsabilità decisionale, che deve rimanere in capo agli adulti chiamati a prendersi cura della persona di minore età. La trasparenza, dichiarata come uno dei principi guida per promuovere la fattiva partecipazione di bambini e ragazzi (Healy e Darlington, 2009), invita i professionisti dell’aiuto a chiarire fin da subito con il proprio interlocutore che ogni decisione sarà presa nel suo superiore interesse e che la responsabilità di questa scelta sarà degli adulti.
Questo studio offre alcune indicazioni utili per la pratica. Innanzitutto, ciò che emerge chiaramente è la necessità di percorsi formativi continui per i professionisti, al fine di aggiornare e sviluppare competenze specifiche nell’ambito delle pratiche collaborative ed emancipatorie. Lavorare in ottica relazionale e partecipativa al fianco di minori e famiglie richiede competenze relazionali, comunicative e riflessive; pertanto, la formazione dovrebbe includere sia aspetti teorici che operativi, con un’attenzione particolare agli atteggiamenti facilitanti e ostacolanti nei processi decisionali, di accoglienza e di dimissione (FICE et al., 2007) e nei colloqui di aiuto in generale, nonché prevedere anche incontri di supervisione metodologica a sostegno degli operatori centrati sul lavoro a tutela di bambini e ragazzi. Pratiche professionali all’insegna della partecipazione dei più piccoli necessitano di approcci, metodiche e strumenti operativi da apprendere e utilizzare nella relazione con bambini e ragazzi, in base all’età e al loro livello di sviluppo.
L’organizzazione all’interno della quale operano dovrebbe promuovere una cultura istituzionale che riconosca la partecipazione come principio trasversale e sistemico — non come un atto isolato — adottando possibilmente policy interne e inter-istituzionali per incentivare il coinvolgimento attivo di bambini e ragazzi in momenti chiave del percorso di tutela (Shier, 2001). Nel concreto, le organizzazioni dovrebbero supportare i professionisti dell’aiuto nel predisporre ambienti adeguati e sicuri dove i bambini possano esprimere liberamente le proprie opinioni (Shier, 2001; Lundy, 2007) e disporre delle risorse di tempo sufficienti per rispondere in modo flessibile agli eventi e ai cambiamenti che possono intercorrere. Questi spazi devono essere modulati in base all’età e alle caratteristiche di bambini e adolescenti, garantendo che ogni incontro sia un’opportunità reale di ascolto e partecipazione (Lundy, 2007).
Lavorare in ottica partecipativa e relazionale rispetta i diritti di bambini e ragazzi e rende i progetti di tutela più efficaci e sostenibili nel tempo (Hart, 1992; 2008; Winter, 2010). Un intervento basato sulla partecipazione, infatti, deve sempre considerare la tutela dei diritti dei bambini, come sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: garantire che anche i più piccoli possano esprimere le proprie opinioni e che queste siano rispettate è fondamentale per promuovere il loro benessere e la loro crescita (Calcaterra e Landi, 2021; Landi e Malvestiti, 2020; 2023).
Bibliografia
Arnstein S.R. (1969), A Ladder of Citizen Participation, «Journal of the American Institute of Planners», vol. 35, n. 4, pp. 216-224.
Balsells M.Á., Fuentes-Peláez N. e Pastor C. (2017), Listening to the voices of children in decision making: A challenge for the child protection system in Spain, «Children and Youth Services Review», vol. 79, pp. 418-425.
Bessell S. (2011), Participation in decision-making in out-of-home care in Australia: What do young people say, «Children and Youth Services Review», vol. 33, pp. 496-501.
Bianchi D., Montà C., Biffi E. e Pepe A. (2024), Esplorare i significati della partecipazione dei minorenni attraverso il collage, «IUL Research», vol. 5, n. 10, pp. 69-85.
Biffi E., Pippa S. e Montà C. (2023), Child participation in the protection system through the lenses of the capability approach: Questions about who, how and whose terms, «Metis», vol. 13, n. 1, pp. 289-302.
Bouma H., López M., Knorth E. e Grietens H. (2018), Meaningful participation for children in the Dutch child protection system: A critical analysis of relevant provisions in policy documents, «Child Abuse & Neglect», vol. 79, pp. 279-292.
Braun V. e Clarke V. (2006), Using thematic analysis in psychology, «Qualitative Research in Psychology», vol. 3, n. 2, pp. 77-101.
Calcaterra V. (2014), Il portavoce del minore. Manuale operativo per l’advocacy professionale, Trento, Erickson.
Calcaterra V. e Landi C. (2021), «È il mio progetto di affido!». La partecipazione dei bambini e delle bambine nella progettazione e realizzazione degli affidi familiari, «Autonomie Locali e Servizi Sociali», n. 2, pp. 265-282.
Caselli M. (2024), Fare domande e ottenere risposte. Il questionario nella ricerca sociale, Milano, Vita e Pensiero.
Corbetta P. (2003), La ricerca sociale: Metodologia e tecniche. Vol. 2: Le tecniche qualitative, Bologna, il Mulino.
Cossar J., Brandon M. e Jordan P. (2016), «You’ve got to trust her and she’s got to trust you»: Children’s views on participation in the child protection system, «Child & Family Social Work», vol. 21, pp. 103-112.
Cudjoe E., Uggerhøj L. e Abdullah A. (2020), «We are consultants, not collaborators»: Young people’s experiences with child protection meetings in Ghana, «Children and Youth Services Review», vol. 109, 104748.
Delgado P., Carvalho J.M.S. e Alves S. (2023), Children and young people’s participation in decision-making in foster care, «Child Indicators Research», vol. 16, pp. 421-445.
Di Fraia G. e Risi E. (2019), Empiria. Metodi e tecniche della ricerca sociale, Milano, Hoepli.
Da Vinci L. e Lenzo F. (a cura di) (2025), VIVAvoce. Sostenere l’ascolto e la partecipazione di bambini e giovani nei percorsi di protezione attraverso una formazione-intervento, Trento, Erickson.
Donnelly C. (2010), Reflections of a guardian ad litem on the participation of looked-after children in public law proceedings, «Child Care in Practice», vol. 16, n. 2, pp. 181-193.
Fernandez E. (2007), How children experience fostering outcomes: Participatory research with children, «Child & Family Social Work», vol. 12, n. 4, pp. 349-359.
FICE, IFCO e SOS Children’s Villages (2007), Quality4Children standards for out-of-home child care in Europe.
Folgheraiter F. (2011), Fondamenti di metodologia relazionale. La logica sociale dell’aiuto, Trento, Erickson.
Goodyer A. (2016), Children’s accounts of moving to a foster home, «Child & Family Social Work», vol. 21, n. 2, pp. 188-197.
Hart R.A. (1992), Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship, Innocenti Essay Nr. 4, Firenze, Unicef International Child Development Centre.
Hart R.A. (2008), Stepping Back from «The Ladder»: Reflections on a Model of Participatory Work with Children. In A. Reid, B.B. Jensen, J. Nikel e V. Simovska (a cura di), Participation and Learning, Dordrecht, Springer, pp. 19-31.
Healy K. e Darlington Y. (2009), Service User Participation in Diverse Child Protection Contexts: Principles for Practice, «Child and Family Social Work», vol. 14, pp. 420-430.
Kosher H. e Ben-Arieh A. (2020), Social workers’ perceptions of children’s right to participation, «Child & Family Social Work», vol. 25, n. 2, pp. 294-303.
Landi C. e Malvestiti D. (2020), A tutt’orecchi. Strumenti per la gestione dei colloqui con bambini e ragazzi nei percorsi d’aiuto, Trento, Erickson.
Landi C. e Malvestiti D. (2023), L’allontanamento del minore passo dopo passo. Metodo e strumenti operativi, Trento, Erickson.
Lenzo F., Solcà P. e Maida S. (2018), Progetto pilota «Presa in carico in rete di famiglie vulnerabili i cui bambini sono inseriti in servizi per la prima infanzia» Manno.
Lenzo F., Zanon O. e Solcà P. (2020), Approcci innovativi nella presa a carico di bambini in situazione di vulnerabilità in Ticino, «Rivista Iride SUPSI-DEASS», n. 8, Manno.
Lundy L. (2007), «Voice» is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, «British Educational Research Journal», vol. 33, n. 6, pp. 927-942.
Middel F., Post W., López López M. e Grietens H. (2021), Participation of children involved in the child protection system – Validation of the Meaningful Participation Assessment Tool (MPAT), «Child Indicators Research», vol. 14, n. 2, pp. 713-735.
Mitchell M.B., Kuczynski L., Tubbs C.Y. e Ross C. (2010), We care about care. Advice by children in care for children in care, foster parents and child welfare workers about the transition into foster care, «Child & Family Social Work», vol. 15, n. 2, pp. 176-185.
Pazé P. (2014), Il diritto del figlio di ascolto in famiglia, «Minorigiustizia», n. 2, pp. 43-50.
Schoch A., Aeby G., Müller B., Cottier M., Seglias L., Biesel K., Sauthier G. e Schnurr S. (2020), Participation of children and parents in the Swiss child protection system in the past and present: An interdisciplinary perspective, «Social Sciences», vol. 9, n. 8, pp. 1-19.
Serbati S. e Milani P. (2013), La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili, Roma, Carocci.
Shier H. (2001), Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations, «Children & Society», vol. 15, n. 2, pp. 107-117.
Strömpl J. e Luhamaa K. (2020), Child participation in child welfare removals through the looking glass: Estonian children’s and professionals’ perspectives compared, «Children and Youth Services Review», vol. 118, 105421.
Šumskienė E., Charenkova J., Gvaldaitė L., Seniutis M., Gevorgianienė V., Petružytė D. e Žalimienė L. (2022), Wor(l)ds struggle against wor(l)ds: Public discourse around children’s removal from families in Lithuania, «Family Relations», pp. 1-19.
Toros K. (2021), A systematic review of children’s participation in child protection decision-making: Tokenistic presence or not?, «Children & Society», vol. 35, pp. 395-411.
van Bijleveld G.G., Dedding C.W. e Bunders-Aelen J.F. (2015), Children’s and Young People’s Participation Within Child Welfare and Child Protection Services: A State-of-the-Art Review, «Child & Family Social Work», vol. 20, n. 2, pp. 129-138.
van Bijleveld G.G., de Vetten M. e Dedding C.W.M. (2021), Co-creating participation tools with children within child protection services: What lessons we can learn from the children, «Action Research», vol. 19, n. 4, pp. 693-709.
Winter K. (2010), The Perspectives of Young Children in Care About Their Circumstances and Implications for Social Work Practice, «Child and Family Social Work», vol. 15, n. 2, pp. 186-195.
Sitografia
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie del Canton Ticino, https://www4.ti.ch/dss/dasf/home (consultato il 25 luglio 2025).
SUPSI, progetto Vivavoce, https://vivavoce.supsi.ch/cms/ (consultato il 25 luglio 2025).
Ufficio di statistica del Canton Ticino, https://www4.ti.ch/dfe/dr/ustat/ufficio/ (consultato il 25 luglio 2025).
-
1 Università Cattolica del Sacro Cuore.
-
2 Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).
-
3 Università Cattolica del Sacro Cuore.
-
4 Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).
-
5 I contenuti esposti nei seguenti paragrafi [Il sistema minorile in Svizzera: breve inquadramento del contesto e Il progetto «VIVAvoce: la partecipazione di bambini e ragazzi nel percorso di collocamento fuori famiglia» sono stati elaborati nel testo: Da Vinci L. e Lenzo F. (a cura di) (2025). VIVAvoce. Sostenere l’ascolto e la partecipazione di bambini e giovani nei percorsi di protezione attraverso una formazione-intervento, Trento, Erickson, pp.13-28, in fase di pubblicazione.
-
6 La Svizzera è una repubblica federale il cui sistema politico unisce federalismo e democrazia diretta. È suddivisa in 26 cantoni, ognuno dotato di un proprio parlamento e governo. Questa struttura garantisce un’elevata autonomia alle autorità locali e si fonda sul principio di sussidiarietà, che prevede l’attribuzione delle competenze al livello istituzionale più vicino ai cittadini, delegandole al livello superiore solo quando necessario.
-
7 Organo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) responsabile per tutti gli affari legislativi nell’ambito del diritto pubblico, amministrativo, privato e penale. Non esercita funzioni giudiziarie; https://www.bj.admin.ch/bj/it/home.html (consultato il 24/7/2025).
-
8 Ufficio cantonale ticinese che sottostà al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), sotto il cappello della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF). Si occupa del coordinamento, del sussidiamento e della vigilanza negli ambiti inerenti alle politiche per le famiglie, ai giovani e ai minorenni; https://www4.ti.ch/dss/dasf/chi-siamo/ufficio-del-sostegno-a-enti-e-attivita-per-le-famiglie-e-i-giovani (consultato il 24/7/2025).
-
9 Ufficio cantonale ticinese che sottostà al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). L’UAP è collocato nella Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF). Attraverso i suoi settori e servizi di intervento, offre prestazioni di servizio sociale e di protezione a favore di minorenni, delle loro famiglie e di adulti in situazioni di vulnerabilità. Si occupa inoltre della valutazione e della vigilanza delle famiglie affidatarie e adottive, alle quali offre anche sostegno e consulenza. Per le vittime di reati, così come per le vittime di un evento traumatico, dispone di servizi specifici di aiuto e di intervento mirati. https://www4.ti.ch/dss/dasf/chi-siamo/ufficio-dellaiuto-e-della-protezione (consultato il 24/7/2025).
-
10 Le Autorità regionali di protezione (ARP) in coerenza con l’autonomia cantonale che la Svizzera garantisce, ciascun cantone decide indipendentemente sull’organizzazione e le modalità d’intervento. Nel Canton Ticino sono 16 le ARP, le quali esercitano la loro funzione su altrettanti comprensori. L’ARP svolge la funzione del Tribunale per i minorenni come corrispettivo del contesto italiano. https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/famiglia-e-figli/supporto-aiuto-e-protezione/autorita-regionali-di-protezione-arp (consultato il 24/7/2025).
-
11 La Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF) è responsabile della pianificazione, coordinamento e attuazione delle politiche sociali e familiari cantonali. Opera sia attraverso l’erogazione diretta di servizi e prestazioni alla popolazione, sia mediante l’autorizzazione, il finanziamento e la vigilanza di enti e progetti con finalità sociali. https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/aiuto-e-protezione/protezione-di-famiglie-minori-e-adulti/misure-di-protezione-per-minori-e-adulti/interventi-a-favore-di-minorenni-su-richiesta-dellautorita (consultato il 24/7/2025).
-
12 Per quanto riguarda il concetto di «partecipazione» si fa qui riferimento alla definizione proposta da Hart (1992; 2008). Con riferimento alle pratiche di ascolto, si intendono metodi e atteggiamenti volti a entrare in relazione e comprendere i significati attribuiti da bambini e adolescenti al loro percorso di vita in un ambiente inclusivo che valorizzi esperienze, emozioni e prospettive, promuovendo così una comunicazione efficace e l’empowerment di bambini e ragazzi che vivono nelle comunità educative per minorenni.
-
13 Il questionario è stato consegnato in forma cartacea all’avvio del progetto a tutti i 76 partecipanti, 11 dei quali non hanno restituito lo stesso. La seconda rilevazione si è tenuta al termine del percorso formativo e non è stato possibile somministrarlo a tutto il gruppo poiché i percorsi nella parte finale si sono differenziati. A tal proposito, si precisa che nella seconda rilevazione il questionario è stato consegnato a 43 partecipanti.
Vol. 2, Issue 1, July 2025