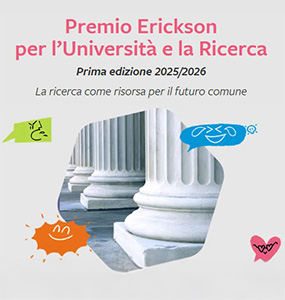Vol. 2, n. 1, Luglio 2025
Esplorare l’intreccio fra spiritualità e lavoro sociale
Riconnettere spiritualità, relazione d’aiuto e costruzione comunitaria
Andrea Gollini1
Sommario
La letteratura scientifica internazionale suggerisce che la spiritualità rappresenti una dimensione significativa per la pratica del lavoro sociale, capace di rafforzare la qualità relazionale dell’intervento, sostenere i percorsi di aiuto e contribuire alla costruzione di senso nelle situazioni di sofferenza e marginalità. Mathews (2009) evidenzia la necessità per gli operatori sociali di sviluppare sensibilità culturale e spirituale; Nash (2006) e Lee (2007) mostrano come la spiritualità possa alimentare l’impegno per la giustizia sociale; Gardner (2020) invita a riconoscere questa dimensione anche nei percorsi formativi. In ambito anglosassone, in particolare, si è consolidata una riflessione ampia e plurale, con strumenti concettuali, operativi e deontologici capaci di integrare la spiritualità nelle pratiche professionali.
Nel contesto italiano, al contrario, questo tema è ancora ampiamente trascurato. L’assenza di una riflessione esplicita appare legata, almeno in parte, al lungo processo di laicizzazione del lavoro sociale, che ha cercato legittimazione attraverso una separazione netta dalla matrice religiosa storicamente dominante. In questo scenario, la spiritualità è spesso percepita come un tema ambiguo, improprio o non professionale. Tuttavia, questa rimozione rischia di eludere una componente rilevante dell’esperienza umana, condivisa anche da persone non religiose.
A partire da una distinzione chiara tra religione e spiritualità (Crisp, 2010; Senreich, 2013), questo contributo intende esplorare, in chiave critica e interdisciplinare, le possibilità di integrare la dimensione spirituale nei percorsi di accompagnamento e recovery, valorizzando anche il ruolo dei volontari e delle reti di prossimità. Dopo un’analisi comparativa del dibattito internazionale, il saggio propone una riflessione sulle competenze necessarie, sulle implicazioni etiche e sui rischi connessi all’uso non critico della spiritualità nei servizi sociali. L’obiettivo è quello di avviare una riflessione situata, capace di riconnettere spiritualità, relazione d’aiuto e costruzione comunitaria nel lavoro sociale contemporaneo.
Parole chiave
Spiritualità, lavoro sociale, Comunità, Volontariato, Approccio olistico.
Exploring the intertwining of spirituality and social work
Reconnecting spirituality, helping relationships and community building
Andrea Gollini2
Abstract
The international literature suggests that spirituality is a significant aspect of social work practice. It can strengthen the quality of relationships in interventions, support help relationships, and contribute to the construction of meaning in situations of suffering and marginalisation. Mathews (2009) emphasises the importance of social workers developing cultural and spiritual sensitivity, while Nash (2006) and Lee (2007) demonstrate how spirituality can foster dedication to social justice. Furthermore, Gardner (2020) advocates for the recognition of this dimension in training programmes. A broad and pluralistic reflection on this issue has taken hold in the Anglo-Saxon world, providing conceptual, operational and ethical tools for integrating spirituality into professional practices.
In the Italian context, however, this issue is still largely neglected. This appears to be linked, at least in part, to the long process of the secularisation of social work seeking legitimacy through a clear separation from the historically dominant religious matrix. In this scenario, spirituality is often perceived as ambiguous, inappropriate or unprofessional. However, ignoring it risks overlooking a significant aspect of human experience, even among non-religious individuals.
Keywords
Spirituality, social work, community, volunteering, holistic approach.
Introduzione: perché parlare di spiritualità nel lavoro sociale?
La letteratura internazionale riconosce con crescente chiarezza la rilevanza della spiritualità nella pratica del lavoro sociale. Numerosi contributi teorici e studi empirici (Crisp 2010,2017; Canda e Furman 2010; Senreich 2013) evidenziano come la spiritualità — intesa non solo in senso religioso, ma come ricerca di significato, connessione e trascendenza — possa rafforzare la qualità della relazione d’aiuto, sostenere il benessere complessivo delle persone accompagnate e offrire strumenti per affrontare situazioni di crisi, sofferenza e marginalità.
In questo contributo useremo il termine spiritualità riferendoci a:
una relazione soggettiva — cognitiva, emotiva e intuitiva — con ciò che rimane inconoscibile dell’esistenza, e al modo in cui ogni persona integra tale relazione nella propria visione dell’universo, del mondo, degli altri, di sé, dei valori morali e del senso della vita (Senreich 2013).
Questa accezione ampia permette di distinguere la spiritualità sia dalla religione (adesione a un sistema dottrinale-rituale) sia dalla fede teistica personale, e di considerarla una risorsa trasversale alle culture e alle tradizioni.
A questo riconoscimento si affianca un’evoluzione nelle linee guida delle principali organizzazioni professionali. Non solo nei contesti accademici, ma anche nella deontologia e nella formazione, la spiritualità è sempre più vista come parte integrante di un approccio olistico e centrato sulla persona. Per esempio, la International Association of Schools of Social Work (IASSW) afferma:
Gli assistenti sociali riconoscono le dimensioni biologica, psicologica, sociale, culturale e spirituale della vita delle persone; comprendono e trattano tutte le persone nella loro interezza. Tale riconoscimento viene utilizzato per formulare valutazioni e interventi olistici, con la piena partecipazione di persone, organizzazioni e comunità coinvolte dagli assistenti sociali (IASSW, 2018).
Alla luce di questo panorama internazionale sempre più articolato, si impone una domanda: perché in Italia il tema della spiritualità resta ancora marginale nel lavoro sociale, sia a livello accademico che operativo? Come mai una dimensione presente nella vita delle persone è così poco tematizzata nei percorsi formativi, nei documenti ufficiali e nella pratica professionale?
Questo saggio, quindi, nasce dalla volontà di esplorare in dettaglio l’importanza della dimensione spirituale nel lavoro sociale, analizzando come possa essere efficacemente integrata nelle strategie di intervento e quali benefici specifici possa portare agli operatori, ai volontari e alle persone a cui si rivolgono i servizi. Attraverso un’analisi dettagliata, si discuteranno le potenzialità di un approccio olistico all’assistenza sociale, offrendo spunti per una maggiore comprensione e implementazione di pratiche spiritualmente consapevoli nel contesto del social work. Questo contributo cercherà anche di rispondere alle domande sullo stato di questo dibattito nel contesto italiano.
Per comprendere meglio come questa dimensione venga affrontata e valorizzata nella pratica professionale, è utile osservare alcuni contesti in cui il dibattito sulla spiritualità nel lavoro sociale ha già una lunga tradizione. Uno sguardo internazionale può offrire modelli ispirativi, approcci metodologici consolidati e prospettive critiche da cui trarre insegnamento.
L’evoluzione della spiritualità nel lavoro sociale: uno sguardo internazionale
L’interesse crescente verso la spiritualità nel lavoro sociale è confermato da numerosi studi comparativi internazionali, che mostrano come questa dimensione venga integrata nella formazione e nella pratica professionale.
Un contributo particolarmente significativo è quello di Crisp (2010), che analizza l’evoluzione del concetto di spiritualità in diversi contesti, come Australia, Regno Unito e Stati Uniti, mettendo in luce approcci differenti e modelli di formazione sempre più attenti a questo aspetto. La riflessione sulla spiritualità nel lavoro sociale è particolarmente sviluppata nei paesi anglosassoni, dove la considerazione delle dimensioni spirituali è stata integrata ampiamente nelle politiche, nella formazione e nella pratica del lavoro sociale.
Negli Stati Uniti, la spiritualità è considerata una componente critica dell’identità personale e, di conseguenza, del benessere individuale. I corsi di formazione in lavoro sociale spesso includono moduli specifici che trattano la competenza culturale e spirituale, enfatizzando l’importanza di comprendere e rispettare le diverse espressioni spirituali delle persone accompagnate (Canda & Furman, 2010). Questa pratica si basa sul presupposto che l’assistenza sociale che ignora le componenti spirituali delle esperienze umane possa risultare incompleta o meno efficace.
In Canada, il tema della spiritualità nel lavoro sociale è oggetto di una riflessione specifica, come evidenziato da Crisp (2017), che segnala il contributo di studiosi come John Coates, Diana Coholic e John Graham. Questo orientamento mostra un riconoscimento crescente della spiritualità come dimensione significativa nella pratica del servizio sociale, con particolare attenzione all’approccio olistico e al benessere integrale della persona.
Anche in Australia, l’interesse per la spiritualità nel lavoro sociale ha conosciuto uno sviluppo significativo. Sebbene inizialmente descritto come tiepido (Rice, 2002), si è consolidato nel tempo, anche grazie all’inclusione esplicita della spiritualità nel Code of Ethics dell’Australian Association of Social Workers (Rice, 2002). Inoltre, documenti politici come l’Early Years Learning Framework for Australia (in Bone & Fenton, 2015) sottolineano l’importanza di considerare gli aspetti spirituali nell’apprendimento e nel benessere dei bambini, indicando una crescente consapevolezza nel contesto educativo e sociale australiano.
Questo crescente riconoscimento internazionale evidenzia una tendenza verso un approccio più inclusivo e olistico nel lavoro sociale, dove le pratiche non si limitano a indirizzare i bisogni fisici o psicologici, ma si estendono a comprendere e supportare anche le necessità spirituali. La capacità di integrare efficacemente la spiritualità nella pratica del lavoro sociale non solo arricchisce la relazione tra operatore e persona accompagnata, ma favorisce anche una comprensione più profonda e sfaccettata delle vie che conducono al benessere. Come sottolineato da Mathews (2009), la sensibilità spirituale e culturale è fondamentale per cogliere la persona nella sua interezza e per costruire relazioni di aiuto autentiche. Nash (2006) evidenzia come la spiritualità possa rafforzare il legame tra lavoro sociale e giustizia sociale, offrendo anche una fonte di speranza — elemento centrale nei percorsi di accompagnamento. Gardner (2020), infine, riflette sul crescente riconoscimento della spiritualità nella pratica professionale, sottolineando come essa contribuisca a una comprensione più ampia e inclusiva del benessere personale e relazionale.
L’intersezione tra spiritualità e lavoro sociale ha radici profonde e una traiettoria evolutiva che riflette trasformazioni culturali, epistemologiche e professionali. Seguendo la letteratura internazionale (Canda & Furman, 2010; Crisp, 2017; Senreich, 2013), è possibile individuare quattro fasi principali nel rapporto tra lavoro sociale e spiritualità.
La prima fase, collocabile tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, è caratterizzata da un approccio fortemente influenzato dalle motivazioni religiose. Le prime organizzazioni di beneficenza, come le Charity Organization Societies, e i movimenti del settlement house, come quello avviato da Jane Addams con Hull House, erano spesso promossi da istituzioni cristiane e animate da un ethos spirituale (Canda & Furman, 2010; Crisp, 2017). In questa fase, spiritualità e intervento sociale erano strettamente intrecciati: i valori religiosi offrivano una cornice etica e motivazionale, e l’attenzione alla dimensione trascendente era parte integrante del prendersi cura. Scales e Kelly (2011) suggeriscono che questa eredità spirituale abbia influenzato profondamente lo sviluppo iniziale del lavoro sociale, anche se talvolta in modo implicito.
La seconda fase si sviluppa nella seconda metà del Novecento, in particolare nel secondo dopoguerra. Con il processo di professionalizzazione, il lavoro sociale cerca di affermarsi come disciplina autonoma e scientifica. In questo contesto, la spiritualità viene progressivamente marginalizzata, considerata non misurabile, soggettiva e dunque poco compatibile con l’evidenza empirica richiesta dalle scienze sociali emergenti (Gilligan e Furness 2006; Senreich, 2013). La formazione si concentra su modelli clinici e tecnici, spesso ispirati alla psicologia psicoanalitica o comportamentale (Canda & Furman, 2010). La religione è relegata alla sfera privata e spesso percepita come estranea — se non addirittura contraria — alla neutralità professionale. Questo processo è ben documentato anche in contesti culturali ad alta religiosità, come Malta (Psaila, 2017) o Irlanda del Nord (Carlisle 2017), dove gli assistenti sociali tendono comunque a evitare ogni riferimento spirituale.
La terza fase, a partire dagli anni Settanta e Ottanta, segna un rinnovato interesse per la spiritualità all’interno del lavoro sociale. Sull’onda di un clima culturale critico verso la razionalità tecnocratica e orientato a una maggiore attenzione alla soggettività, emergono approcci olistici che includono il vissuto spirituale come parte integrante dell’identità personale (Robbins et al., 1998; Bullis, 1996; Derezotes, 1995). Si affermano modelli centrati sulla persona, sulla relazione e sul significato, in cui la spiritualità inizia a essere esplorata come risorsa di coping, fonte di resilienza e leva per il cambiamento (Mathews, 2009). È in questo periodo che compaiono i primi testi e articoli dedicati alla «spiritual sensitivity» nella pratica sociale e alla necessità di una formazione che consideri anche la diversità religiosa e culturale (Devore e Schlesinger, 1994).
La quarta fase, dalla metà degli anni Novanta fino a oggi, vede il consolidamento di un approccio maturo e pluralistico alla spiritualità nel lavoro sociale. Le organizzazioni professionali, come la National Association of Social Workers (NASW) negli Stati Uniti e la International Federation of Social Workers (IFSW), riconoscono esplicitamente la spiritualità come parte integrante della persona e ne promuovono l’integrazione nei codici etici e nei programmi formativi. A livello internazionale si moltiplicano linee guida, strumenti di assessment e buone pratiche che aiutano gli operatori a esplorare la dimensione spirituale dei propri utenti in modo sensibile e non prescrittivo (Hodge, 2005; Puchalski et al., 2014). In questa fase, la spiritualità è intesa in senso ampio, come sistema di valori, credenze, relazioni e pratiche che offrono significato alla vita, indipendentemente dall’adesione a una religione organizzata (Senreich, 2013). Tale approccio permette di comprendere come la spiritualità possa essere presente anche in persone non religiose o non credenti, e proprio per questo risulti un riferimento più inclusivo rispetto alla dimensione confessionale o dogmatica della religione. La fede, intesa in senso stretto come adesione a una dottrina o a una pratica religiosa istituzionalizzata, rappresenta solo una delle possibili espressioni della spiritualità, che può manifestarsi anche in termini laici, esistenziali, simbolici o relazionali.
Nel lavoro sociale, la spiritualità può facilitare una relazione di aiuto più empatica, profonda e rispettosa, capace di valorizzare le risorse interiori e i riferimenti valoriali dell’utente. In questa prospettiva, è utile richiamare il concetto di epistemologia del rispetto,3 elaborato da Robert Segal (1998) conoscere non significa ridurre l’altro a oggetto di analisi, ma entrare in un dialogo autentico, in cui anche le dimensioni simboliche e spirituali vengono accolte come linguaggi significativi, e non marginali. Un ascolto attento, non giudicante, che assume la comprensione come esercizio di reciprocità, è alla base di un’etica della relazione che riconosce il soggetto nella sua interezza.
Autori come Crisp (2010) e Sheridan (2009) hanno mostrato come l’integrazione della spiritualità, lungi dal rappresentare un elemento accessorio, possa invece svolgere un ruolo centrale nei percorsi di sostegno, specialmente in contesti segnati dalla sofferenza, dalla perdita o dalla marginalità. Al tempo stesso, ignorare questa dimensione rischia di produrre una visione parziale dell’esperienza dell’altro, limitando la capacità trasformativa dell’intervento.
Dal punto di vista etico, la valorizzazione della spiritualità si inserisce nella più ampia prospettiva del rispetto per la diversità culturale e per l’autodeterminazione dell’utente. I codici deontologici del lavoro sociale sottolineano l’importanza di riconoscere e accogliere le convinzioni spirituali e religiose come parte dell’identità personale e collettiva, evitando approcci normativi o riduzionisti. Come sottolineato da Senreich (2013), l’obiettivo non è quello di promuovere una visione spirituale specifica, ma di creare spazi in cui ogni persona possa esprimere, se lo desidera, il proprio rapporto con ciò che è percepito come sacro, misterioso o ultimativo.
Dopo aver delineato le principali traiettorie evolutive e i riferimenti internazionali che hanno contribuito a legittimare la spiritualità come dimensione professionale, è ora possibile soffermarsi su come questa attenzione si traduca concretamente nella pratica. Quali competenze, atteggiamenti e strumenti richiede l’integrazione della spiritualità nel lavoro quotidiano dell’operatore sociale?
Dalla teoria alla pratica: sviluppare una competenza spirituale
La crescente attenzione alla spiritualità nel lavoro sociale richiede oggi un impegno concreto per sviluppare pratiche professionali che siano rispettose, competenti e culturalmente sensibili. Sebbene la spiritualità non si presti a una sistematizzazione tecnica, esistono piste di lavoro riconosciute a livello internazionale che possono guidare l’intervento sociale nel trattare questa dimensione profonda e spesso trascurata dell’esperienza umana.
Un primo passo imprescindibile riguarda la formazione dell’operatore e il suo lavoro di autoriflessione. Come afferma Hodge (2001a), nessun professionista può avvicinarsi con efficacia e rispetto alla spiritualità dell’altro senza aver prima interrogato le proprie convinzioni e i propri eventuali pregiudizi. La supervisione e la formazione continua, in questo senso, sono strumenti fondamentali per sviluppare una competenza spirituale autentica e per evitare dinamiche di proiezione o imposizione (Furman et al., 2004).
La competenza spirituale, in questo senso, non consiste nel possedere una specifica visione religiosa, ma nella capacità di accogliere, comprendere e lavorare con i riferimenti spirituali dell’altro, anche quando sono diversi dai propri. Essa include componenti cognitive (conoscenze culturali e religiose di base), relazionali (ascolto empatico e rispetto per la pluralità) e riflessive (consapevolezza dei propri valori e limiti). Come sottolineato dalla letteratura internazionale (Canda e Furman, 2010; Senreich, 2013), si tratta di una competenza trasversale che attraversa l’intero processo di aiuto, contribuendo a una pratica più etica, sensibile e centrata sulla persona.
Accanto alla consapevolezza personale, è necessario costruire un contesto relazionale fondato sull’apertura e sul rispetto. Ogni social worker dovrebbe comunicare un atteggiamento accogliente verso la pluralità delle espressioni spirituali e religiose, creando uno spazio sicuro in cui la persona si senta libera di condividere, se lo desidera, i propri riferimenti interiori. Mathews (2009) e Pathan (2016) sottolineano l’importanza di un ambiente non giudicante, in grado di riconoscere la spiritualità come risorsa potenziale, senza trasformarla in oggetto di indagine o pressione.
In questo contesto, l’ascolto attento e l’uso di domande esplorative giocano un ruolo centrale. Cagna (2020) invita a prestare attenzione ai segnali linguistici o narrativi che possono indicare un riferimento spirituale — anche implicito — da parte dell’utente: frasi come «è destino», «se Dio vuole» o racconti di esperienze significative spesso contengono tracce spirituali. Domande aperte e rispettose possono allora facilitare un’esplorazione condivisa, ad esempio: «Ci sono pratiche o credenze che le danno forza nei momenti difficili?», oppure: «La sua spiritualità ha un ruolo nel modo in cui affronta le sfide?».
Un altro aspetto rilevante è l’integrazione della spiritualità all’interno dei modelli di intervento già in uso. Canda e Furman (2010) sottolineano la necessità di evitare compartimentazioni: la spiritualità non è un tema a parte, ma una dimensione trasversale che può informare l’intero processo di aiuto.
In alcuni casi, può risultare utile collaborare con risorse spirituali presenti nel contesto di vita della persona accompagnata — come leader religiosi, guide spirituali o membri di una comunità di fede — purché tale collaborazione sia richiesta o accettata dalla persona e venga mantenuta entro i limiti del mandato professionale. Come suggerito da Hodge (2004; 2010), queste collaborazioni possono arricchire l’intervento, a patto che non si sostituiscano all’ascolto professionale ma lo completino, nella logica di una rete di sostegno plurale. Fondamentale, infine, è il rispetto dei confini professionali. Sheridan (2009) ricorda che l’assistente sociale non è un consulente spirituale né un mediatore religioso. Il suo compito non è quello di fornire risposte spirituali, ma di sostenere la persona nel proprio percorso, riconoscendo la spiritualità come possibile risorsa e dimensione dell’identità, senza oltrepassare il proprio ruolo.
In tutte queste pratiche, è essenziale mantenere una costante vigilanza etica. I rischi di strumentalizzazione, imposizione valoriale, confusione tra dimensioni spirituali e patologie mentali sono reali e documentati (Furman et al., 2004). La competenza spirituale non si improvvisa: richiede formazione, riflessività, supervisione, e un atteggiamento costante di umiltà e ascolto.
A partire da questa prospettiva relazionale e riflessiva, si sono sviluppati anche numerosi strumenti che, se utilizzati con cautela e consapevolezza, possono supportare l’operatore nell’esplorare la dimensione spirituale in modo strutturato. Tali strumenti non intendono sostituirsi alla relazione, ma possono diventare occasioni per approfondire le risorse interiori, i valori e i significati attribuiti alla propria esperienza.
Strumenti per esplorare e valorizzare la dimensione spirituale
Nel campo dell’assistenza spirituale,4 in particolare nella pratica clinica, diversi autori hanno proposto strumenti tecnici per valutare la dimensione spirituale degli individui, evidenziando l’importanza di un approccio olistico. Tra gli strumenti più significativi troviamo gli Spiritual Genograms (Hodge, 2001b, 2005a), che utilizzano un albero genealogico modificato per visualizzare la spiritualità attraverso almeno tre generazioni, aiutando a comprendere il flusso di modelli radicati storicamente. Gli Spiritual Lifemaps (Hodge, 2005a, 2005b) offrono alle persone la possibilità di disegnare eventi significativi della loro vita spirituale, utilizzando materiali creativi per mappare il loro percorso spirituale.
Per una visione attuale delle relazioni spirituali della persona accompagnata, gli Spiritual Ecomaps (Hodge, 2000, 2005a,) rappresentano un metodo efficace per identificare e visualizzare le reti di supporto spirituale. Integrando genogrammi ed ecomaps, gli Spiritual Ecograms (Hodge, 2005a,) mostrano sia le risorse spirituali presenti che le influenze storiche, evidenziando come il passato e il presente si connettano nella spiritualità del cliente. Inoltre, le Spiritual Histories (Hodge, 2001a, 2005a) rappresentano un approccio narrativo per esplorare verbalmente la storia spirituale del cliente.
Al di là del lavoro di Hodge, strumenti come il modello F.I.C.A proposto da Puchalski et al. (2014), che fornisce una guida semi-strutturata per raccogliere l’anamnesi spirituale dei pazienti, e la «Scala di Valutazione HOPE dei Bambini» sviluppata da Fulton e Moore (1995), enfatizzano l’importanza di considerare la spiritualità nei contesti pediatrici. Cagna (2020) esplora strumenti specifici per l’assistenza palliativa pediatrica, sottolineando come la valutazione spirituale possa migliorare significativamente la qualità della cura e del sostegno fornito ai giovani pazienti e alle loro famiglie in momenti critici. Il bio-psychosocial spiritual assessment di Cheung Siew Li et al. (n.d.) estende questa valutazione includendo aspetti biologici, psicologici e sociali, sottolineando la necessità di un’analisi comprensiva.
Questi strumenti dimostrano un impegno continuo verso l’approfondimento e l’integrazione della spiritualità nella pratica clinica e sociale, permettendo ai professionisti di approcciare i loro clienti in maniera completa e rispettosa delle loro diverse esigenze e convinzioni spirituali. Tuttavia, è essenziale utilizzare questi strumenti con cautela, evitando ogni automatismo e determinismo.
Non si tratta di mappare meccanicamente la spiritualità, ma di lasciare che essa emerga come parte dell’identità complessa della persona. In questo senso possiamo estendere alla spiritualità quanto affermato da Cabiati circa gli strumenti di assessment interculturale: «È sempre necessario un setting dialogico per l’esplorazione intersoggettiva delle difficoltà accompagnato dal desiderio e dallo sforzo di provare a costruire assieme ai diretti interessati» (Cabiati, 2020, p. 372).
Se gli strumenti possono offrire un supporto tecnico nella relazione tra operatore e persona, non va dimenticato che l’azione sociale si dispiega anche al di fuori dei confini professionali. La spiritualità, infatti, attraversa e motiva profondamente l’impegno di tanti volontari che operano in ambito sociale, culturale e comunitario. In questo scenario, il lavoro sociale non è appannaggio esclusivo degli assistenti sociali o degli esperti: è un’azione diffusa, costruita anche nei contesti di prossimità, nelle reti di solidarietà e nelle relazioni quotidiane. È proprio nel volontariato e nel lavoro comunitario che la spiritualità può manifestarsi come risorsa simbolica, relazionale e trasformativa.
Volontari e spiritualità: motivazioni, relazioni e potere
La riflessione sulla spiritualità nel lavoro sociale non può prescindere da una considerazione attenta del ruolo centrale svolto dalle comunità e dai volontari che in esse si muovono, in particolare nel contesto delle organizzazioni caritative. La letteratura recente ha evidenziato come la spiritualità — intesa in senso ampio, come insieme di credenze, valori e narrazioni di senso — rappresenti una leva potente non solo per avviare l’impegno volontario, ma anche per sostenerlo nel tempo e trasformarlo in un percorso di crescita personale e collettiva (Denning, 2021a; Monforte, 2020). In particolare, nelle esperienze di volontariato in contesti di povertà alimentare, la fede religiosa non si configura unicamente come una motivazione iniziale, ma come una risorsa fluida e relazionale che alimenta l’entusiasmo, sostiene lo sforzo e orienta l’azione nel quotidiano (Denning, 2021b).
L’approccio teorico di Denning propone di interpretare la persistenza del volontariato attraverso la lente della affect theory, secondo cui le motivazioni non sono statiche, ma si rinnovano attraverso un ciclo continuo di emozioni, relazioni e riflessioni (Denning, 2021a). I volontari studiati dall’autrice esprimono il proprio agire come performazione della fede,5 mostrando come l’esperienza di servizio sia al tempo stesso espressione di convinzioni religiose e spazio di trasformazione spirituale. Questo movimento reciproco — tra fede che spinge all’azione e azione che modifica la fede — mette in discussione ogni lettura unidirezionale della motivazione spirituale, evidenziando il carattere processuale e situato del coinvolgimento volontario (Denning, 2021c).
Mentre i volontari sono spesso ispirati dalla loro appartenenza religiosa, è fondamentale riflettere criticamente su come queste convinzioni influenzino le loro azioni e interazioni con le persone incontrate. Attingendo alle riflessioni di Foucault (1977) sulle dinamiche di potere, possiamo esaminare come anche le azioni di aiuto possano diventare veicoli di potere e controllo. Questa consapevolezza aiuta a garantire che l’impegno dei volontari sostenga veramente l’autonomia e il benessere spirituale delle persone accompagnate, senza imporre visioni o pratiche non richieste.
La spiritualità, tuttavia, non si limita a fornire motivazioni individuali. Secondo Monforte (2020), nel contesto dell’austerità e del ritiro dello Stato sociale, essa può diventare anche fonte di resilienza critica, alimentando pratiche di solidarietà capaci di intrecciare compassione e contestazione. In altre parole, il volontariato spiritualmente motivato non è sempre un’azione conservatrice o caritatevole in senso tradizionale, ma può contenere potenzialità trasformative, soprattutto quando si traduce in forme collettive di empowerment, mutualismo e costruzione di legami comunitari.
Tuttavia, la letteratura mette in guardia anche rispetto ad alcune ambivalenze. Möller (2021), ad esempio, analizzando l’operato dei food banks nel Regno Unito, evidenzia come all’interno di contesti apparentemente solidali possano riprodursi pratiche paternalistiche e moralizzanti. Riprendendo il concetto di pastoral power elaborato da Foucault, l’autore mostra come il volontariato, anziché promuovere l’autonomia, possa talvolta contribuire alla costruzione di soggettività disciplinate, veicolando una responsabilizzazione individuale della povertà e offuscando le sue cause strutturali. Per evitare che la motivazione spirituale si traduca in pratiche escludenti o giudicanti, è fondamentale che i percorsi di volontariato includano momenti di formazione e autoriflessione critica. Stacey (2018) propone, a questo proposito, la nozione di postsecolarità performativa, secondo cui anche i volontari non religiosi possono essere accompagnati nel riscoprire le narrazioni, i valori e i miti che orientano le loro azioni di solidarietà. In questa prospettiva, la spiritualità può essere intesa come un orizzonte comune — non necessariamente confessionale — che consente di costruire legami e significati condivisi in contesti di pluralismo culturale e religioso (Stacey, 2018; 2019). Tale prospettiva si rivela particolarmente utile per ripensare la formazione dei volontari e degli operatori sociali come luoghi di elaborazione simbolica, oltre che tecnica, del proprio agire.
Oltre alla dimensione individuale e relazionale, la spiritualità può agire anche come motore del lavoro comunitario, contribuendo a costruire legami di solidarietà capaci di andare oltre la somma dei singoli atti di volontariato. In questo senso, il volontariato spiritualmente ispirato non si limita a offrire risposte individuali a bisogni emergenti, ma può attivare processi collettivi di trasformazione simbolica e sociale.
Come osserva Monforte (2020), molte iniziative nate in contesti di crisi — come i centri alimentari o i progetti di prossimità — generano nel tempo forme di resilienza comunitaria fondate su narrazioni condivise, rituali quotidiani e senso di appartenenza. Queste dimensioni, spesso informate da riferimenti spirituali (espliciti o impliciti), permettono non solo di contenere la fatica, ma di restituirle un significato condiviso e narrabile. In tal modo, lo spazio comunitario non è solo un luogo di erogazione di servizi, ma anche un orizzonte simbolico e affettivo, dove le persone — volontari e beneficiari — possono ritrovare dignità, agency e riconoscimento reciproco.
Stacey (2018) suggerisce di interpretare questi luoghi come spazi post-secolari, in cui la spiritualità — anche quando non istituzionalizzata — contribuisce a rigenerare la connessione tra l’etica del dono, il legame sociale e la responsabilità verso l’altro. La dimensione spirituale, in questo quadro, non opera come fattore di chiusura identitaria, ma come apertura all’altro, fondamento di un comunitarismo plurale che riconosce il bisogno umano di senso, interdipendenza e cura.
Questa prospettiva si collega alle riflessioni sul lavoro comunitario come costruzione di legami e produzione di senso, in cui la spiritualità può essere intesa come una risorsa relazionale e culturale capace di generare coesione. Folgheraiter (2007), pur non trattando esplicitamente la spiritualità, propone un modello di social work relazionale centrato sui legami di reciprocità e sul patrimonio simbolico delle comunità, da cui è possibile inferire una visione della spiritualità come risorsa relazionale e culturale. In tal senso si colloca anche Donati (1991), con la sua teoria dei beni relazionali. In questo senso, la spiritualità non è un contenuto da trasmettere, ma una struttura profonda di significazione che aiuta a «tenere insieme» (MacQueen et al., 2001) le persone e le loro esperienze frammentate. Questa funzione aggregante si esprime anche attraverso la capacità della spiritualità di mobilitare e sostenere la coesione sociale, specialmente nelle comunità che condividono riferimenti valoriali, rituali e orizzonti morali.
Crisp (2018) sottolinea come le pratiche spirituali,6 soprattutto quando radicate nelle comunità locali, possano contribuire al benessere sociale, rafforzando i legami tra le persone e promuovendo reti di supporto reciproco. Allo stesso tempo, molte tradizioni spirituali offrono un’etica dell’impegno sociale e della giustizia: valori come la compassione, l’equità, l’ospitalità, il servizio agli altri possono diventare fondamento per azioni di advocacy, iniziative contro la povertà e percorsi di solidarietà concreta (Nash, 2006; Lee, 2007). In tal modo, la spiritualità non solo rafforza il tessuto comunitario esistente, ma può orientare progetti di trasformazione sociale ispirati a visioni di mondo alternative e inclusive.
Infine, in un contesto sempre più plurale e interconnesso, la spiritualità può offrire un terreno fertile per il dialogo interreligioso e interculturale. Come sottolineano Canda e Furman (2010), la promozione del rispetto per la diversità spirituale all’interno dei contesti comunitari contribuisce alla pace sociale e alla convivenza, rendendo il lavoro di comunità un laboratorio di cittadinanza interculturale e di riconoscimento reciproco.
Lungi dall’essere un’aggiunta accessoria, la dimensione spirituale può dunque costituire un fondamento generativo per costruire comunità: luoghi dove non si distribuiscono solo beni, ma si coltivano significati condivisi, si elaborano visioni del mondo, si produce riconoscimento. In questa ottica, i contesti volontari diventano laboratori simbolici e relazionali, in cui il lavoro sociale si intreccia con la costruzione di un senso collettivo dell’abitare, del servire e del vivere insieme.
Tuttavia, se da un lato la spiritualità può generare senso, motivazione e legame, dall’altro è necessario mantenere uno sguardo critico sulle modalità con cui essa viene integrata nella pratica sociale. Come ogni dimensione profonda dell’esperienza umana, anche la spiritualità può essere fraintesa, strumentalizzata o trattata in modo improprio. Per questo, è fondamentale interrogare i limiti, i rischi e le ambivalenze che l’uso della spiritualità nel lavoro sociale può comportare.
Rischi metodologici ed etici nell’integrazione della spiritualità
Integrare la spiritualità nella pratica del lavoro sociale comporta una serie di questioni etiche e metodologiche che non possono essere ignorate. Per quanto tale dimensione rappresenti una risorsa significativa, riconosciuta e valorizzata a livello internazionale, essa espone anche a rischi di semplificazione, appropriazione e normalizzazione che richiedono una costante attenzione critica.
Un primo rischio riguarda la tecnicizzazione della spiritualità. Nel tentativo di renderla «trattabile» all’interno della relazione d’aiuto, vi è il pericolo di ridurla a una variabile osservabile, misurabile o categorizzabile. Come rilevato da Canda e Furman (2010), questa tendenza può portare a trattare la spiritualità come un insieme di dati da raccogliere piuttosto che come una dimensione profondamente vissuta, relazionale e simbolica. L’uso eccessivo o non riflessivo di strumenti operativi (schede, checklist, ecomappe) rischia così di produrre un approccio normativo, che si limita a «inquadrare» l’esperienza spirituale senza davvero incontrarla.
Altrettanto rilevante è il tema della posizione dell’operatore e della sua implicita funzione normativa. Sheridan (2009) sottolinea l’importanza di mantenere confini professionali chiari: l’assistente sociale non è né un consigliere spirituale né un facilitatore religioso, ma un professionista del legame, chiamato ad ascoltare senza dirigere. Tuttavia, come evidenziato da Hodge (2010), ogni relazione professionale è attraversata da asimmetrie di potere, non sempre visibili ma altamente operative. L’operatore, per il solo fatto di occupare una posizione riconosciuta socialmente come autorevole, esercita un potere epistemico e simbolico che può influenzare profondamente l’utente: nelle domande che pone, nei silenzi che accoglie o lascia cadere, nei linguaggi che legittima o ignora.
Seguendo la prospettiva foucaultiana, il potere non si manifesta solo come imposizione, ma come forza produttiva: esso struttura i discorsi, determina ciò che può essere detto e ciò che resta indicibile, orienta i significati che assumiamo come validi o attendibili (Foucault, 1977). Anche nella relazione spirituale, ciò che l’assistente sociale accoglie o scoraggia contribuisce a configurare un campo di visibilità: alcune spiritualità possono apparire come «risorse» legittime, altre come problematiche da correggere o silenziare. In tal modo, la pratica rischia di diventare un luogo di regolazione dell’intimità, dove la spiritualità viene «normalizzata» secondo griglie culturali dominanti.
Questa dinamica si rende particolarmente evidente nei casi in cui l’operatore, anche senza intenzionalità, attribuisce valore o legittimità a determinati riferimenti spirituali a scapito di altri. Il rischio è duplice: da un lato, quello dell’imposizione implicita di valori, che contraddice il principio di autodeterminazione dell’utente; dall’altro, quello della mancanza di ospitalità epistemica, ovvero l’incapacità di accogliere narrazioni spirituali non allineate con le aspettative culturali o istituzionali dell’intervento.
Un’ulteriore criticità metodologica riguarda la confusione tra spiritualità e disagio psichico (Hodge,2004). Senza una capacità critica nel decifrare le forme simboliche con cui si esprimono vissuti interiori profondi, si rischia di fraintendere esperienze spirituali intense come segnali di patologia o viceversa. Questo accade soprattutto in contesti dove prevale un modello clinico-diagnostico, che tende a interpretare il riferimento al trascendente come manifestazione di alterazione o disfunzione.
Infine, è necessario interrogare la tensione tra il riconoscimento della soggettività spirituale dell’utente e le logiche standardizzanti che caratterizzano molte pratiche di welfare contemporaneo. La spiritualità, in quanto eccedenza di senso e spazio narrativo non normabile, può entrare in attrito con modelli organizzativi orientati all’efficienza, alla valutazione e alla rendicontazione. Ma proprio in questo scarto risiede la sua forza etica: quella di aprire nella relazione professionale uno spazio in cui le domande ultime della persona — quelle sul significato, la giustizia, la sofferenza, la speranza — possano essere accolte senza essere immediatamente chiuse, interpretate o neutralizzate.
Concentrando l’attenzione sulla dimensione comunitaria un ulteriore rischio etico ci viene presentato da Banks e Nøhr (2014:196-204) i quali presentano il rischio che determinati aspetti della religione (o interpretazioni degli stessi) possano confliggere con l’etica professionale, nel caso specifico la convinzione che la fede possa sostituire una terapia farmacologica.
Se, come abbiamo visto, l’integrazione della spiritualità nel lavoro sociale comporta numerosi interrogativi etici e metodologici, è nella concretezza delle situazioni che tali interrogativi si fanno più vivi e urgenti. Per comprendere meglio come la spiritualità possa emergere nella pratica, in forma spesso implicita e ambivalente, può essere utile soffermarsi su un caso ispirato all’ambito delle cure palliative pediatriche.
Riconoscere la spiritualità nella pratica quotidiana: un caso per stimolare la riflessività
Il racconto che segue, pur frutto di finzione narrativa, nasce da esperienze reali e da suggestioni tratte anche dal lavoro di Mario Cagna (2020), e si sviluppa seguendo la struttura proposta da Senreich (2013), offrendo al lettore possibili alternative di azione. Non si tratta di un esempio da seguire, ma di un’occasione per riflettere, attraverso la narrazione, sulle complessità dell’agire sociale di fronte al mistero della sofferenza e della ricerca di senso.
Il contesto
L’ospedale pediatrico «Monteluna» è una struttura pubblica di riferimento per le cure palliative pediatriche nel Nord Italia. Vi opera un’équipe multiprofessionale composta da medici, psicologi, infermieri e un’assistente sociale, Serena, affiancata da un piccolo gruppo di genitori della comunità locale che offrono un supporto tra pari. L’ospedale dispone anche di un cappellano, don Bruno, la cui presenza è discreta e attivabile su richiesta.
La storia
Serena accompagna da alcune settimane la famiglia di Gabriele, un bambino di otto anni affetto da una grave forma di leucemia. I genitori, Claudia e Marco, sono riservati.
Nei primi incontri con l’équipe, parlano del percorso clinico con compostezza, evitando riferimenti emotivi o personali. Tuttavia, in un incontro informale, la madre dice: «A volte prego, anche se non so più bene a chi…». Serena la ascolta e annota mentalmente la frase.
Qui si apre un bivio.
- Potrebbe accogliere il riferimento con una domanda aperta: «Le capita spesso di pregare? Le dà conforto?». Questo approccio, sensibile e rispettoso, potrebbe aprire uno spazio di condivisione.
- Oppure potrebbe sorvolare, temendo di invadere uno spazio troppo intimo. Così facendo, però, rischierebbe di perdere un’occasione di connessione.
Durante un successivo colloquio, Marco si sofferma su una domanda: «Perché proprio noi? Che senso ha tutto questo?». Non piange, ma la voce è carica di tensione.
Anche qui si apre un bivio.
- Serena potrebbe spostare l’attenzione sul presente: «Capisco, ma ora è importante stare vicino a Gabriele giorno per giorno…».
- Oppure legittimare la domanda come ricerca di senso: «Molte persone si pongono interrogativi simili… le va di parlarne un po’?».
Sviluppi possibili
Serena accoglie l’apertura di Claudia. Nei colloqui successivi, emergono sentimenti ambivalenti tra fede e rabbia. Marco rimane più chiuso. In supervisione, l’équipe discute sull’opportunità di coinvolgere il cappellano. L’idea resta sospesa, finché Claudia chiede esplicitamente se può parlare con qualcuno «che sappia ascoltare anche queste domande».
Serena propone il supporto di don Bruno e l’incontro con alcuni volontari del gruppo «Tra cielo e terra», attivi in ospedale. Claudia accetta; Marco, inizialmente titubante, partecipa in silenzio.
Poco dopo, in riunione d’équipe, l’infermiera riporta una frase di Gabriele detta a bassa voce: «Se io non torno a scuola, mamma continuerà a volermi bene?». La frase colpisce l’équipe. L’infermiera si chiede se parlarne con lui o aspettare.
Si apre un ulteriore bivio.
- L’équipe potrebbe decidere di non approfondire subito, per evitare di generare ansie.
- Oppure potrebbe coinvolgere l’educatrice, che ha un buon rapporto con Gabriele, per esplorare attraverso il gioco eventuali pensieri nascosti, concordando prima con i genitori l’approccio più adatto.
Infine, Marco confida a Serena: «A volte, mentre guardo Gabriele dormire, sento come se ci fosse qualcosa che ci accompagna… poi penso che forse sto solo impazzendo».
Serena coglie la delicatezza del momento:
- Potrebbe approfondire: «Questa sensazione la fa stare meglio o la preoccupa?», offrendo ascolto senza giudizio.
- Oppure evitare il tema, per timore di sovrapposizioni con ambiti psicologici. Ma così facendo, rischierebbe di chiudere uno spazio prezioso.
In équipe, la psicologa invita a non classificare troppo in fretta. Anche don Bruno, presente in via informale, sottolinea come immagini, sogni e intuizioni possano aiutare a tollerare l’impotenza.
Considerazioni conclusive
Il caso appena esaminato mette in luce quanto la spiritualità, anche in contesti laici e professionalizzati, possa attraversare le pratiche di cura come dimensione viva, ambivalente, relazionale. Le scelte possibili non sono mai neutre né scontate, e richiedono sensibilità, riflessività e vigilanza etica. Ma cosa accade quando questa consapevolezza fatica a entrare nel dibattito professionale? Com’è trattata la spiritualità nel contesto italiano, nei percorsi formativi, nella letteratura accademica, nelle prassi quotidiane dei servizi? Per rispondere, occorre volgere lo sguardo al nostro panorama nazionale.
La situazione in Italia: silenzi, segnali e prospettive
La letteratura scientifica internazionale suggerisce che la spiritualità — intesa non solo come appartenenza a una religione organizzata, ma come un aspetto profondamente personale e soggettivo dell’esperienza umana — rappresenti un elemento rilevante della pratica del lavoro sociale (Crisp, 2018). Tuttavia, nel nostro Paese non si trova traccia sistematica di questa riflessione né a livello accademico né operativo. Le ragioni di questa assenza meriterebbero un’indagine approfondita, ma sembrano legate anche al processo di costruzione del welfare state e alla crescente professionalizzazione delle discipline di cura. Tale processo ha segnato una progressiva separazione dal ruolo storico della Chiesa Cattolica, e con essa dalla dimensione spirituale, percepita come premoderna e deprofessionalizzante.
Nella mia esperienza professionale e di ricerca ho osservato che la spiritualità, pur talvolta evocata nei racconti degli operatori, risulta quasi assente dai documenti ufficiali, dai percorsi formativi e dalla riflessione metodologica. La mancanza di un lessico condiviso, la frequente sovrapposizione con la religiosità confessionale e la paura di un ritorno a modelli caritativi contribuiscono a questo silenzio disciplinare.
Alcuni segnali di attenzione emergono in ambito pedagogico: Milan e Cestaro (2016) riflettono sul bisogno di spiritualità nei giovani, indicando come tale dimensione — sebbene soggettiva e frammentata — richiami la cura e l’educazione. In ambito sanitario, lo studio di Cagna (2020) sulle cure palliative pediatriche mostra la spiritualità come risorsa di coping e accompagnamento nella sofferenza, e propone strumenti valutativi utili anche nel lavoro sociale. In linea con queste riflessioni, Vecchiato (2008) sottolinea come la spiritualità non sia un contenuto da trasmettere, ma una dimensione relazionale e simbolica che può arricchire le pratiche di cura, se affrontata con consapevolezza e rigore professionale. Anche Lombi (2023) invita a considerare la spiritualità come parte di un approccio integrato alla persona, rispettoso della sua complessità.
Nonostante questi contributi, manca ancora un’elaborazione sistematica della spiritualità come dimensione professionale del lavoro sociale. Non esistono linee guida, strumenti condivisi o percorsi formativi specifici. Questo vuoto può tuttavia essere colto come un’opportunità per sviluppare una riflessione situata, capace di valorizzare la spiritualità in chiave critica, relazionale e generativa. Le conclusioni che seguono propongono alcune piste per iniziare a colmare questo ritardo.
Conclusioni e piste di lavoro: per un lavoro sociale sensibile alla dimensione spirituale
La riflessione proposta in questo saggio ha cercato di riportare al centro del discorso professionale un aspetto che, pur riconosciuto a livello internazionale come importante, resta ancora largamente trascurato nel panorama italiano: la spiritualità nel lavoro sociale. Lungi dall’essere un tema confessionale o marginale, la spiritualità è emersa come una dimensione trasversale e profondamente umana, che attraversa le esperienze di crisi, di cura, di ricerca di senso e di relazione.
La letteratura e le linee guida internazionali hanno ormai chiarito che non è possibile un intervento olistico senza un riconoscimento della spiritualità come parte dell’identità e del vissuto delle persone. Questa consapevolezza ha dato origine a modelli teorici, strumenti operativi, piste formative e riflessioni etiche mature, che si stanno diffondendo anche in ambiti complessi come la salute mentale, le cure palliative e il lavoro di comunità.
Nel corso del saggio è emersa con forza la necessità di superare le dicotomie ereditate dalla modernità, che hanno separato il corpo dallo spirito, la soggettività dalla tecnica, il sapere dalla sapienza. La spiritualità, se compresa come campo relazionale e simbolico, può offrire al lavoro sociale una grammatica nuova per ascoltare ciò che spesso resta taciuto, per nominare l’indicibile, per accompagnare la sofferenza senza ridurla a disfunzione. Essa consente di risignificare parole profonde — come dignità, speranza, giustizia, connessione — nel vocabolario professionale, non come orpelli retorici, ma come categorie vive e situate; pur riconoscendo la complessità e la sfida che questo comporta.
Nel contesto italiano, però, questa riflessione appare ancora in ritardo. L’assenza di una cornice teorica condivisa, la carenza di percorsi formativi, la scarsità di ricerche empiriche e la timidezza del dibattito pubblico sono tutti elementi che indicano un vuoto da colmare, ma anche un’occasione da cogliere. Come si è visto, esistono segnali di apertura che indicano l’urgenza di un lavoro culturale e scientifico capace di riconnettere etica, spiritualità e prassi professionale.
In questo scenario, il lavoro sociale, anche in Italia, può ritrovare nella spiritualità una risorsa non solo per aiutare meglio, ma per supportare profondamente il proprio mandato. Essa non offre un modello alternativo o complementare, ma un orizzonte critico da cui interrogare le pratiche, ascoltare il senso, riscoprire la relazione come luogo generativo. In tempi di crisi sistemiche — sociali, ambientali, spirituali — la spiritualità non è una fuga dall’impegno, ma una radice da cui rigenerare il pensiero e l’azione professionale.
In questo senso, la riflessione sulla spiritualità non è solo una questione accademica: per chi opera quotidianamente nei servizi, rappresenta anche una possibilità concreta di riscoprire il significato umano e relazionale dell’agire sociale, oltre le logiche burocratiche e prestazionali.
Per questo, è auspicabile che i prossimi anni vedano un maggiore impegno nella ricerca qualitativa su questi temi, nella co-costruzione di strumenti sensibili al contesto culturale italiano, e nella creazione di spazi di confronto interdisciplinare, interculturale e interreligioso. Il lavoro sociale ha oggi bisogno di riconnettere ciò che è stato separato, per abitare con maggiore profondità tutte le domande che le persone portano. La spiritualità, se ascoltata con rispetto e consapevolezza, può essere una delle chiavi per farlo.
Bibliografia
Bone J. e Fenton A. (2015), Spirituality and child protection in early childhood education: A strengths approach, «International Journal of Children’s Spirituality», vol. 20, n. 2, pp. 86-99.
Bullis R.K. (1996), Spirituality in social work practice, Washington, DC, Taylor & Francis.
Cabiati E. (2020), Intercultura e social work. Teoria e metodo per gli interventi di aiuto con persone di minoranza etnica, Trento, Erickson.
Cagna M. e Manfredini L. (2021), L’assistenza spirituale in cure palliative pediatriche, «La Rivista Italiana Di Cure Palliative», vol. 23, n. 1, p. 41.
Canda E.R. (2011), Spiritual connection in social work: Boundary violations and transcendence, «Journal of Religion & Spirituality in Social Work», vol. 30, n. 3, pp. 234-247.
Canda E.R. e Furman L.D. (2010), Spiritual diversity in social work practice. The heart of helping, Oxford, Oxford University Press.
Carlisle P. (2017), The absent presence of religion and spirituality in mental health social work in Northern Ireland. In B. Crisp (a cura di), The Routledge handbook of religion, spirituality and social work, London, Routledge.
Cheung S.L. et al. (s.d.), A bio-psychosocial spiritual assessment guide for health and social work, The Singapore Association of Social Workers.
Comba E. (2002), Antropologia delle religioni. Un’introduzione, Torino, UTET Università.
Crisp B.R. (2010), Spirituality and social work, London, Routledge.
Crisp B.R. (2017), The Routledge handbook of religion, spirituality and social work, London, Routledge.
Crisp B.R. (2018), Religion, spirituality and social work: An international perspective, «International Journal of Human Rights in Healthcare», vol. 11, n. 2, pp. 91-99.
Derezotes D.S. (1995), Spiritually oriented social work practice, «Social Work», vol. 40, n. 2, pp. 180-190.
Devore W. e Schlesinger E.G. (1994), Ethnic-sensitive social work practice, Boston, MA, Allyn & Bacon.
Dombo E.A. (2023), Continuing the work: Exploring intersections of religion, spirituality, and social work, «Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought», vol. 42, n. 2, pp. 133-134.
Donati P. (1991), Teoria relazionale della società, Milano, FrancoAngeli.
Folgheraiter F. (2007), Relational Social Work: Toward Networking and Societal Practices, London, Jessica Kingsley Publishers.
Foucault M. (1977), Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi.
Fulton R.A. e Moore C.M. (1995), Spiritual care of the school-age child with a chronic condition, «Journal of Pediatric Nursing», vol. 10, n. 4, pp. 224-231.
Furman L., Benson P., Grimwood C. e Canda E. (2004), Religion and spirituality in social work education and direct practice at the millennium: A survey of UK social workers, «British Journal of Social Work», vol. 34, n. 6, pp. 767-792.
Gardner F. (2020), Social work and spirituality: Reflecting on the last 20 years, «Journal for the Study of Spirituality», vol. 10, n. 1, pp. 72-83.
Gilligan P. e Furness S. (2006), The role of religion and spirituality in social work practice: Views and experiences of social workers and students, «British Journal of Social Work», vol. 36, n. 4, pp. 617-637.
Hodge D.R. (2000), Spiritual ecomaps: A new diagrammatic tool for assessing marital and family spirituality, «Journal of Marital and Family Therapy», vol. 26, n. 2, pp. 217-228.
Hodge D.R. (2001a), Spiritual assessment: A review of major qualitative methods and a new framework for assessing spirituality, «Social Work», vol. 46, n. 3, pp. 203-214.
Hodge D.R. (2001b), Spiritual genograms: A generational approach to assessing spirituality, «Families in Society», vol. 82, n. 1, pp. 35-48.
Hodge D.R. (2002), Conceptualizing spirituality in social work: How the metaphysical beliefs of social workers may foster bias toward theistic consumers, «Social Thought», vol. 21, n. 1, pp. 39-61.
Hodge D.R. (2004), Spirituality and people with mental illness: Developing spiritual competency in assessment and intervention, «Families in Society», vol. 85, n. 1, pp. 36-44.
Hodge D.R. (2005a), Developing a spiritual assessment toolbox: A discussion of the strengths and limitations of five different assessment methods, «Health & Social Work», vol. 30, n. 4, pp. 314-323.
Hodge D.R. (2005b), Spiritual lifemaps: A client-centered pictorial instrument for spiritual assessment, planning, and intervention, «Social Work», vol. 50, n. 1, pp. 77-87.
Hodge D.R. (2010), Spirituality and religion in social work: Respondent definitions, «Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought», vol. 29, n. 1, pp. 1-19.
International Association of Schools of Social Work (IASSW) (2018), Dichiarazione di principi etici del servizio sociale mondiale, https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2019/03/Italian-version-of-Ethical-principles-in-Global-SW-2018.pdf (consultato il 23 luglio 2025).
King D. e Cutsinger M. (2023), Faith integration: Student perspectives on spirituality and social work in a Christian Master of Social Work (MSW) program, «E-Journal of Religious and Theological Studies», pp. 337-350.
Lee E.O. e Barrett C. (2007), Integrating spirituality, faith, and social justice in social work practice and education: A pilot study, «Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought», vol. 26, pp. 1-21.
Lombi L. (2023), La cura spirituale, Milano, Vita e Pensiero.
Mathews I. (2009), Social work and spirituality, Learning Matters Ltd.
Meinert R. (2009), Introduction: Controversial issues in religion, spirituality, and social work, «Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought», vol. 28, n. 1-2, pp. 1-4.
Milan G. e Cestaro M. (2016), Adolescenti, spiritualità, religiosità. Quale educazione?, «Studium Educationis», vol. 17, n. 3, pp. 391-408.
Monforte P. (2020), From compassion to critical resilience: Volunteering in the context of austerity, «The Sociological Review», vol. 68, n. 1, pp. 110-126.
Nash M.M. e Stewart B. (2006), Spirituality and hope in social work for social justice, «Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal», vol. 4, n. 1, pp. 1-10.
NHS Education for Scotland (2021), Spiritual Care Matters: An Introductory Resource for all NHSScotland Staff, Edinburgh, NES, https://www.nes.scot.nhs.uk/media/xzadagnc/spiritual-care-matters-an-introductory-resource-for-all-nhsscotland-staff.pdf (consultato il 23 luglio 2025).
Nickel B.J. (2020), The Routledge handbook of religion, spirituality and social work, «Religious Studies Review», vol. 46, n. 4, pp. 509-511.
Pathan S. (2016), Islamic spirituality and social work interventions: The person-in-relation approach, «International Social Work», vol. 59, n. 3, pp. 406-418.
Psaila C. (2017), Spirituality and religion in Maltese social work practice: a taboo?. In B.R. Crisp (a cura di), The Routledge handbook of religion, spirituality and social work, London, Routledge, pp. 43-51.
Puchalski C.M., Ferrell B., Virani R., Otis-Green S., Baird P., Bull J. et al. (2009), Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care: The report of the Consensus Conference, «Journal of Palliative Medicine», vol. 12, n. 10, pp. 885-904.
Puchalski C., Vitillo R., Hull S. e Reller N. (2014), Improving the spiritual dimension of whole person care: Reaching national and international consensus, «Journal of Palliative Medicine», vol. 17, n. 6, pp. 642-656.
Rice S. (2002), Magic happens: Revisiting the spirituality and social work debate, «Australian Social Work», vol. 55, n. 4, pp. 303-312.
Robbins S.P., Chatterjee P. e Canda E.R. (1999), Ideology, scientific theory, and social work practice, «Families in Society», vol. 80, n. 4, pp. 374-384.
Scales T.L. e Kelly M.S. (a cura di) (2011), Christianity and social work: Readings on the integration of Christian faith and social work practice, Botsford, CT, North American Association of Christians in Social Work.
Segal R.A. (1998), Diagnosing Religion. In T.A. Idinopulos e B.C. Wilson (a cura di), What Is Religion?, Leiden, Brill, pp. 107-112.
Senreich E. (2013), An inclusive definition of spirituality for social work education and practice, «Journal of Social Work Education», vol. 49, n. 4, pp. 548-563.
Sheridan M.J. (2009), Ethical issues in the use of spiritually based interventions in social work practice: What are we doing and why, «Journal of Religion & Spirituality in Social Work», vol. 28, n. 1-2, pp. 99-126.
Vecchiato T. (2008), Spirituale e professionale: un difficile incontro, «Studi Zancan», vol. 5, pp. 24-36.
World Health Organization (2020), Palliative care, Fact Sheet N° 402, Geneva, WHO, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care (consultato il 23 luglio 2025).
-
1 Caritas Diocesana di Reggio Emilia, Phd in Social Work and Personal Social Services.
-
2 Caritas Diocesana di Reggio Emilia, Phd in Social Work and Personal Social Services.
-
3 La traduzione presa da Comba (2002).
-
4 Per assistenza spirituale si intende il sostegno alla dimensione di significato, speranza e connessione della persona (OMS, 2020; Puchalski et al., 2009), fornito — quando necessario — da figure specialistiche (cappellani, spiritual care providers). Diversamente, l’assistenza sociale ha mandato professionale su diritti sociali, risorse e protezione, pur cooperando con l’assistenza spirituale in una prospettiva bio-psico-sociale-spirituale
-
5 Traduzione dell’autore.
-
6 Come meditazione, preghiera, rituali personali, pratiche di riflessione sul senso, autoriflessività…
Vol. 2, Issue 1, July 2025