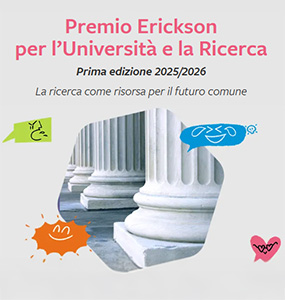Vol. 2, n. 2, ottobre 2025
L’educazione onlife al tempo della complessità
Gennaro Balzano1
Sommario
Sulla base dei cambiamenti socioculturali, tecnologici ed economici che stanno interessando l’educazione, delle dinamiche complesse all’interno degli ambienti educativi, come la diversità culturale, l’interconnessione globale e la rapida evoluzione dei media digitali, si vuole approfondire il concetto di complessità (Morin, 2017) come elemento non di secondo piano nell’analisi di nuovi paradigmi educativi, tra questi l’educazione onlife.
L’impianto teorico dell’onlife (Floridi, 2014) non può di fatto prescindere da un’analisi che focalizzi con attenzione la categoria della complessità come chiave interpretativa dell’educazione in una prospettiva di studio si interdisciplinare, ma certamente guidata dal sapere pedagogico, dall’informale e all’educazione permanente. Questi fondamenti teorici forniscono la base concettuale per sviluppare pratiche educative in grado di affrontare le sfide dell’era digitale e della complessità.
La realtà di connessione pervasiva, il tema delle identità multiple, la consapevolezza digitale, i rischi e le opportunità, la privacy e la valutazione critica delle informazioni sono al centro del dibattito educativo nella prospettiva onlife. L’opportunità del vivere in simbiosi con tecnologia e costantemente connessi richiede anche competenze avanzate, una patente che renda ognuno in grado di attuare comportamenti consapevoli. L’onlife richiama, in ultimo, a una formazione longlife e longwide (Baldacci et al., 2012; Federighi, 2018).
Parole chiave
Complessità, onlife, digitale, cittadinanza, educazione.
Onlife education in times of complexity
Gennaro Balzano2
Abstract
Based on the socio-cultural, technological and economic changes that are affecting education, the complex dynamics within educational environments, such as cultural diversity, global interconnectedness and the rapid evolution of digital media, we would like to deepen the concept of complexity (Morin, 2017) as a non-secondary element in the analysis of new educational paradigms, among them onlife education.
The theoretical framework of onlife (Floridi, 2014) cannot in fact disregard an analysis that carefully focuses on the category of complexity as an interpretative key to education in a perspective of study that is indeed interdisciplinary, but certainly guided by pedagogy, from informal to lifelong learning. These theoretical foundations provide the conceptual basis for developing educational practices capable of meeting the challenges of the digital age and complexity.
The reality of pervasive connection, the topic of multiple identities, digital awareness, risks and opportunities, privacy and critical evaluation of information are at the center of the educational debate in the onlife perspective. The opportunity of living in symbiosis with technology and being constantly connected also requires advanced skills, a license that makes everyone capable of conscious behavior. Onlife calls, in the end, for a longlife and longwide education (Baldacci et al., 2012; Federighi, 2018).
Keywords
Complexity, onlife, digital, citizenship, education.
Introduzione
L’avvio di una ricerca, seppur teorica, su tale tema, necessita preventivamente dalla definizione di cosa intendiamo per educazione e per complessità, parole chiave centrali dalle quali prende forma l’intero lavoro. In più è necessario porre le basi concettuali necessarie per esplorare l’interrelazione tra l’educazione e i sistemi complessi, nonché gli ambienti che li caratterizzano. Da qui lo sguardo all’interazione tra i processi di apprendimento individuali e i più ampi contesti socioculturali, economici e tecnologici all’interno dei quali l’educazione si attua.
Non di secondo piano può considerarsi la rilevanza educativa del concetto di complessità, perché l’educazione non è un processo lineare e prevedibile ma aperto, dinamico e multidimensionale, in più influenzato da molteplici fattori interconnessi tra loro. Partendo da qui si possono sfidare le concezioni tradizionali, aprendo lo sguardo a nuove prospettive per comprendere e migliorare le pratiche educative, alla luce di un crescente complessificarsi della realtà.
In ultimo va considerato il ruolo della diversità nell’educazione, l’impatto della globalizzazione e della tecnologia e l’importanza di approcci didattici adattivi e flessibili. L’onlife tiene dentro tutto ciò e lo amplifica, alimentando e generando, talvolta, ulteriore complessità.
Educazione e complessità
Tanto educazione quanto complessità sono termini di eccessivo uso comune e, pertanto, potrebbero risultare ovvi in un significato che ovvio non è per una serie di ragioni e, soprattutto, si arricchisce quando questi due termini si incontrano e generano dialogo.
Il concetto di complessità ha assunto una rilevanza preponderante in diverse discipline, inclusa la pedagogia, poiché non rappresenta un semplice incremento quantitativo di informazioni o conoscenze, ma implica un riconoscimento della natura intrinsecamente interconnessa, dinamica e spesso imprevedibile dei sistemi entro i quali gli esseri umani sono chiamati a vivere e interagire. Pertanto, è interessante comprendere in che modo l’educazione possa non solo rispondere alle sfide imposte dalla complessità, ma anche educare le persone a vivere un mondo che è sempre più caratterizzato da dinamiche complesse in fieri (Morin, 2017).
Il termine complessità, ampiamente utilizzato in diversi contesti, viene generalmente impiegato per descrivere sistemi che si contraddistinguono per le molteplici interazioni, non lineari e frequentemente imprevedibili, tra le loro componenti. Sul fronte educativo la complessità si manifesta in modo evidente attraverso l’interazione di molteplici fattori — sociali, culturali, economici e tecnologici — che insieme influenzano profondamente i processi di apprendimento e insegnamento, che sollecita un approccio proiettato oltre le tradizionali metodologie educative.
I modelli classici spesso incentrati su una visione specifica e lineare dei processi di apprendimento, si rivelano inadeguati quando si vanno ad applicare ai contesti della complessità, poiché i problemi che emergono in tale ambito, per loro natura, non possono essere affrontati o risolti tramite l’applicazione di formule predefinite; necessitano, invece, di un approccio multidimensionale, un agire che integri il pensiero critico, sistemico e la capacità di cogliere le relazioni tra fenomeni apparentemente disgiunti. Diventa imprescindibile che l’educazione si orienti verso lo sviluppo delle capacità di interpretazione e gestione della complessità. Questo implica tanto per gli studenti quanto per ogni persona in ogni tempo della sua vita, adeguata formazione, attraverso l’acquisizione di strumenti cognitivi e metacognitivi avanzati, per affrontare con competenza l’incertezza, l’ambiguità e le dinamiche interconnesse che caratterizzano i diversi aspetti della realtà contemporanea (Selmo, 2021).
La complessità richiede un approccio educativo che promuova non solo l’apprendimento interdisciplinare e transdisciplinare, ma anche l’integrazione profonda delle conoscenze provenienti da diversi ambiti e interconnessi tra loro. Si modifica, dunque, il modello: piuttosto che limitarsi all’approfondimento di singole discipline o all’utilizzo di un unico modello esemplificativo, è fondamentale l’esposizione a una varietà di metodologie e prospettive, permettendo così di affrontare i problemi da molteplici angolazioni e differenti punti di vista.
Centrale nel rapporto tra educazione e complessità è la necessità di adottare un modello pedagogico flessibile, capace di adattarsi alle esigenze specifiche del contesto e alle sempre nuove sfide emergenti, aprendosi a un apprendimento che sia attivo e partecipativo, piuttosto che passivo e quasi esclusivamente ricettivo. Nei contesti educativi dalla complessità è essenziale il ruolo dei facilitatori, dei mentori e dei co-costruttori di conoscenza.
L’apprendimento come processo dinamico e continuo è un altro elemento chiave quando parliamo di complessità, un processo continuo di scoperta, adattamento e rielaborazione delle informazioni; una serie di step di apprendimento in cui si esplorano nuove idee, si sperimenta (con diverse metodologie) e si riflette criticamente sulle esperienze vissute in virtù di una costruzione di nuove conoscenze e nuovi apprendimenti. In più attraverso la riflessione critica si attua una comprensione più profonda (Boffo e Fedeli, 2018).
La complessità in educazione implica il riconoscere e valorizzare la diversità. Ogni persona porta con sé un’identità unica, che influenza il modo in cui apprende e interagisce. Un approccio educativo che abbraccia la complessità ha necessità di essere inclusivo così da poter valorizzare questa diversità, creando situazioni stimolanti.
Elemento medio e punto di contatto tra educazione e complessità sono proprio la tecnologia e il suo uso. Questo perché non solo ha permesso di accedere alle informazioni ma ha altresì trasformato radicalmente i contesti di vita, l’agire umano e anche i metodi di apprendimento. Seppure la tecnologia rappresenti uno strumento importante e fondamentale per il progresso umano ma anche potente da un punto di vista didattico e apprenditivo, non è da sottovalutare l’esposizione a sfide sempre nuove e significative che costantemente propone all’essere umano. Affinando l’interesse sul fronte pedagogico didattico queste sfide si concretizzano nell’attenzione frammentata, nella ridotta riflessione critica e anche nell’isolamento sociale; è perciò doveroso bilanciare l’uso delle tecnologie con l’intento primo di promuovere attività, e, dunque, apprendimenti, significativi (Rivoltella, 2017).
Il rapporto tra educazione e complessità è terreno fertile per comprendere le sfide e le opportunità del nostro tempo, proiettato verso una riformulazione dei metodi educativi tradizionali, enfatizzando apprendimento interdisciplinare, riflessione critica e integrazione e uso consapevole della tecnologia. In considerazione delle sfide e delle opportunità future, in un contesto educativo complesso, è imperativo riconoscere la natura in continua evoluzione dei paradigmi educativi. Gli approcci educativi devono rispondere anche al contesto globale interconnesso e in rapida trasformazione, dove i confini disciplinari tradizionali stanno progressivamente sfumando (Pati, 2007). La strada delinea modelli di apprendimento interdisciplinari e transdisciplinari, capaci di fornire le competenze necessarie per navigare con efficacia tra complessità e incertezze. Il ritmo accelerato del progresso tecnologico, inoltre, rappresenta tanto un’opportunità quanto una sfida; tra le principali preoccupazioni vi sono l’uso etico dei dati, il divario digitale e l’impatto della tecnologia su interazione umana e sviluppo cognitivo (Rivoltella, 2017; Iavarone e Aruta, 2022).
Educare alla complessità quindi significa, in ultima analisi, preparare le persone non solo a essere esperte in un determinato campo, ma anche a diventare pensatori flessibili e adattabili, capaci di navigare in un ambiente globale e interconnesso. Solo attraverso una proposta educativa che abbracci pienamente la complessità sarà possibile formare cittadini consapevoli e competenti, pronti a contribuire positivamente alla società in cui vivono.
La realtà dell’onlife
Come atto preliminare, prima di affrontare le stringenti questioni riguardanti la realtà attuale, definita da più parti della connettività pervasiva, è bene tracciare un percorso che delinei innanzitutto che cosa si intende per onlife. Si tratta di una nuova condizione esistenziale caratteristica di un mondo sempre più permeato dall’integrazione tra la dimensione fisica e quella digitale. La distinzione tra online e offline diventa sempre più sfumata e si fa strada l’idea di onlife che esplora le implicazioni sociali, culturali e filosofiche della crescente connessione tra persone e tecnologie.
Il termine onlife, introdotto dal filosofo Luciano Floridi nel 2013 all’interno del celebre Onlife manifesto, ha rappresentato il punto di partenza per analizzare come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) stessero trasformando in maniera profonda e radicale il modo in cui gli esseri umani sperimentano la realtà. Il costante dialogo con il digitale sta infatti portando a una progressiva erosione della tradizionale distinzione tra il mondo online (virtuale) e quello offline (reale), generando una nuova condizione esistenziale definita appunto con il termine onlife.
Donne e uomini vivono in una condizione di interconnessione continua, dove le azioni e le interazioni nei mondi online e offline si intrecciano e si sovrappongono in modo indissolubile. Ma la questione è molto più profonda, poiché si tratta di una trasformazione ontologica del nostro modo di esistere nel mondo, in cui la realtà digitale non è più un’alternativa a quella fisica, ma diventa una sua componente integrale e ineludibile. L’onlife riformula e ridefinisce l’esperienza umana. La connettività costante, l’ubiquità di tale condizione, non è più eccezione ma bensì una consuetudine. Si è perennemente connessi e questa connettività pervasiva influenza profondamente il modo di lavorare, socializzare, apprendere, divertirsi, conoscersi, viversi e coinvolge anche la sfera sentimentale (Peters e Jadrić, 2019).
Si genera una convergenza tra identità online e offline: questo è un ulteriore nodo cruciale. Infatti, al tempo dell’onlife non pare esserci più distinzione tra le identità digitali e quelle fisiche virgola che si fondono in un’unica identità tanto interconnessa quanto frammentata. Accade dunque che le azioni compiute, la vita nel mondo digitale ha ripercussioni in quello reale e viceversa; in questo le persone si ritrovano a costruire una propria identità attraverso un continuo scambio tra la dimensione digitale e quella fisica. La commistione, la frammentazione, la confusione sono tanto rischi quanto naturali conseguenze (Floridi, 2017).
Altra dimensione che viene riorganizzata nella prospettiva onlife è quella della temporalità. L’immediatezza con cui è possibile accedere alle informazioni e la capacità di comunicare in tempo reale generano una percezione accelerata del tempo, dove l’urgenza e l’immediatezza diventano le nuove norme e spesso anche i valori di riferimento.
L’onlife catalizza in sé profonde implicazioni riguardanti l’identità che è stata sempre intesa classicamente come un costrutto stabile, definito da fattori fisici, sociali e culturali. Tali implicazioni riguardano sostanzialmente la trasformazione di tale identità in qualcosa di dinamico, fluido, che si plasma attraverso quelle relazioni che hanno luogo tanto nell’ambiente digitale quanto in quello fisico e che reciprocamente si influenzano. Proprio l’identità onlife si colora di un nuovo aspetto: la performatività. Ciò significa che, mentre online c’è la possibilità di presentare un se curato sotto ogni punto di vista e progettato in relazione all’obiettivo del momento, tutto questo non è un riflesso della realtà fisica ma frutto di manipolazione, alterazione, esagerazione per mostrarsi ciò che non si è o anche semplicemente qualcosa di leggermente diverso rispetto a quel che si è, compromettendo di fatto l’autenticità di ognuno. Così si dà luogo a una identità altamente performativa e costantemente negoziata. Ognuno non è più solo se stesso, dunque, vincolato a una singola identità, ma è possibile, attraverso una pluralità di avatar, variare la propria identità in base ai contesti e alle situazioni. Pluralità ma anche frammentazione, che non è libertà ma Per la propria identità, così esposta attenzioni, conflitti, soprattutto quando le diverse identità entrano in collisione tra loro.
Rilevanti le conseguenze sia sociali che educative: anzitutto, la ridefinizione delle relazioni interpersonali. Le interazioni sociali non si limitano più all’incontro faccia a faccia, ma si estendono attraverso i luoghi non fisici, le piattaforme digitali, ad esempio, che consentono la comunicazione istantanea e a distanza. Ciò ha portato alla creazione di nuove forme di comunità e di connessione, ma ha anche sollevato il problema della connessione debole, dove i legami sociali risultano superficiali e facilmente dissolvibili.
In seconda istanza l’onlife interessa anche la sfera pubblica e politica. Infatti, si è trasformato il modo in cui si accede all’informazione, in cui si partecipa al dibattito politico e anche il modo in cui sì pratica la cittadinanza (Pizzolorusso, 2022). Indubbiamente, guardando al bicchiere mezzo pieno, potrebbe promuovere una maggiore partecipazione democratica e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza del singolo, ma vi è anche il rischio concreto di disinformazione, creazione di echo chambers e polarizzazione politica.
Sfera pubblica, politica ma anche lavoro ed economia. Il remote work, i nuovi lavori digitali e le future professioni sono diventati sempre più rilevanti nel panorama lavorativo, soprattutto a seguito della pandemia che ha di fatto rappresentato un acceleratore naturale per tali questioni (Balzano, 2022). Quel che si è modificato, oltre al fare concreto, sono le modalità, le relazioni, i confini tra vita professionale e vita privata, la sorveglianza, il controllo e le questioni riguardanti le donne e la conciliazione dei tempi vita-lavoro. Tutto ciò accanto a una vita vissuta in connessione ha ulteriormente modificato la vita delle persone, in parte anche in modo inconsapevole.
In conclusione, ma non in ordine di importanza, le questioni etiche, che riguardano tanto la gestione della privacy quanto quella della protezione dei dati più in generale. Anche qui oltre a un bilanciamento tra la necessità di partecipare e il rischio di esposizione e di sfruttamento delle proprie informazioni personali, diventano cruciali le competenze digitali in materia di uso consapevole delle tecnologie. Su tale scia si innesta anche la questione riguardante le dipendenze da tecnologia. L’uso eccessivo della tecnologia può infatti portare a fenomeni quali l’isolamento sociale, la perdita di controllo sul tempo e l’erosione delle capacità cognitive.
L’onlife rappresenta davvero una nuova e rivoluzionaria condizione esistenziale che riflette le trasformazioni radicali del nostro tempo. Questa condizione sfuma i confini tra il mondo online e quello offline, ridefinendo l’identità, le relazioni sociali e le questioni etiche. Comprendere e affrontare le implicazioni dell’onlife è il compito autentico del presente e del futuro (Floridi, 2017).
La realtà digitale delle questioni umane
La contemporaneità è segnata da un paradosso sempre più evidente, o forse meglio definibile come una dualità: la persistente e intricata separazione tra il mondo digitale e quello reale. Per alcune persone, questa frattura rappresenta una questione di natura profondamente personale; per molti, infatti, la dimensione virtuale è divenuta il loro principale ambiente di vita, dove trovano maggiore comfort, felicità, informazione e sicurezza (Malavasi, 2020). In questo contesto digitale, essi possono godere di un flusso continuo di stimoli intensi e di un anonimato parziale che permette loro di assumere rischi che eviterebbero nelle interazioni dirette, pur dovendo al contempo affrontare livelli superiori di oppressione e vulnerabilità rispetto a quelli riscontrabili nella realtà fisica. Al contrario, per un’altra parte della popolazione, il digitale appare come un’illusione o un territorio oscuro che suscita sospetto, paura e ansia: un regno astratto e disorientante, popolato da entità misteriose i cui pensieri, emozioni e motivazioni rimangono incomprensibili e impenetrabili.
Dal punto di vista sociale, emergono notevoli preoccupazioni riguardo la sostenibilità, sia fisica che psicologica, dei processi di comunicazione e interazione, specialmente quando si tratta di comunicazione di massa tra pari, mediata dalla tecnologia informatica, la quale si rivela estremamente problematica e imprevedibile. Fenomeni quali la partecipazione collettiva, le emozioni di massa, la diffusione virale di contenuti, l’influenza politica e il comportamento delle folle all’interno delle reti sociali sono tutti aspetti che rientrano in questa dinamica complessa. Inoltre, eventi privati o di piccoli gruppi si trasformano spesso in spettacoli inquietanti che coinvolgono l’intera società, poiché la connettività ossessiva e la sorveglianza pervasiva amplificano l’esposizione, la vulnerabilità e la paranoia collettiva. Le risposte sociali nel mondo reale, come movimenti di protesta o rivolte, che trovano origine e diffusione su scala globale attraverso i social media, sono altrettanto enigmatiche e preoccupanti, rafforzando l’esigenza di un maggiore distanziamento, controllo, e regolamentazione (Digennaro, 2021).
Nel tentativo di decifrare l’enigma onlife che si sta gradualmente manifestando, il digitale e il reale sono stati trasformati in vere e proprie zone di confine, divenendo anche campi di battaglia dove si svolgono conflitti incessanti volti alla conservazione e alla trasformazione dell’esistenza, tanto individuale quanto collettiva. L’esistenza di queste due dimensioni è strettamente legata all’esito di tali scontri. Ansie e timori riguardanti l’invasione digitale, la colonizzazione tecnologica, l’erosione delle libertà e il dominio emergono con forza, alimentando la preoccupazione di perdere elementi fondamentali come la vita stessa, il libero arbitrio, la razionalità e la sicurezza. Questi sentimenti scavano nelle profondità dell’immaginazione collettiva, evocando scenari di trasparenza assoluta, ipercontrollo, potere opprimente e una dominazione crudele simboleggiata dalla sorveglianza pervasiva, dal Panopticon, e dal neurocontrollo. Nonostante ciò, parallelamente a queste paure, emergono speranze e aspettative che riguardano una nuova vita, liberazione, emancipazione, anonimato, sicurezza e un’etica possibile attraverso una connessione decentralizzata e senza limiti. Questo complesso e inquietante intreccio di controllo, contenimento e protezione continua a stimolare il dibattito sulla natura del nostro futuro digitale.
Internet, insieme ai computer e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha provocato cambiamenti radicali e profondi all’interno della società, rivoluzionando il modo in cui le persone comunicano, interagiscono tra loro, apprendono, lavorano, acquistano beni, conducono affari, valutano i rischi e i benefici associati alle nuove tecnologie, e come costruiscono la loro identità e le loro relazioni sociali.
La vita, così come viene tradizionalmente concepita nella quotidianità e lungo il corso della storia, si fonda su un’idea di continuità che attraversa le dimensioni temporali, spaziali e sociali. Tuttavia, questa concezione tradizionale sta progressivamente svanendo in un mondo sempre più «onlife», dove l’esperienza umana è frammentata in esposizioni, ampliamenti, potenziamenti, trasformazioni e sovrapposizioni di percezioni, eventi ed esperienze, che vengono vissuti come una serie di istantanee disconnesse, osservate attraverso finestre digitali differenti, ciascuna con un proprio grado di dettaglio e precisione.
Per analizzare i complessi processi che definiscono l’onlife, concetto descritto da Manuel Castells come una società in continua evoluzione all’interno della dimensione comunicativa, risulta essenziale comprendere ciò che la sociologia suggerisce (Castells, 2004). L’autore evidenzia come le teorie sociologiche siano cruciali per interpretare questo nuovo mondo, e a tal fine combina tre linee di differenziazione sociologica, elaborate da Jacques Ellul, un filosofo francese della tecnologia che ha considerato la tecnica un fenomeno sociale. Ellul adotta una prospettiva marcatamente critica della tecnologia, che conduce Castells a delineare due dualità apparenti, indispensabili per comprendere il rapporto tra pensiero sociologico, pensiero tecnico e sviluppi cibernetici (Castells, 2004).
In questo scenario, la prima dualità evidenziata riguarda il progresso tecnico e la regressione sociale. Da un lato, i progressi tecnologici hanno migliorato la qualità della vita, estendendo l’aspettativa di vita di circa trent’anni. Dall’altro, la logica tecnica impone una standardizzazione che fissa le società umane a parametri rigidi, trasformando culture tradizionali, valori e norme sociali per costruire una cultura omogenea fondata sulla standardizzazione e sul consumo. La tecnologia informatica, nello specifico, è vista come un elemento di disgregazione sociale, che cerca di convertire la nuova sfera privata in uno spazio digitale, esponendo tutte le attività personali su un forum pubblico. La seconda dualità proposta da Castells riguarda la tensione tra libertà individuale e controllo totale (Castells, 2004). Con l’avvento delle tecnologie dell’informazione, la spinta verso la globalizzazione ha portato a una significativa riduzione dell’autonomia personale, rendendola un bene sempre meno prezioso, in parte a causa dell’incremento del potere detenuto dai governi e dalle grandi organizzazioni. In situazioni di guasti improvvisi dei sistemi, come durante disastri naturali o fallimenti tecnologici, la vulnerabilità umana diventa particolarmente evidente, poiché l’unica risorsa disponibile è la capacità di operare all’interno del sistema sociale. Ogni interruzione, pertanto, comporta una forma di sanzione che preserva la vita all’interno della società, mettendo in luce l’importanza del funzionamento continuo e ininterrotto dei sistemi su cui la vita moderna si basa.
Nel panorama dell’onlife gioca un ruolo interessante l’Internet of Things (IoT), che rappresenta un importante passaggio dall’internet delle persone a quello degli oggetti, dove la connettività diventa invadente e pervasiva, permettendo così anche i dispositivi di essere identificabili, dotati di sensori e in grado di muoversi all’interno di reti di reti. (Arquilla e Vitali, 2016). Nasce proprio così un mondo completamente interconnesso in grado di influenzare quasi tutti i contesti dell’umano e capace di intervenire anche su questioni come benessere felicità e dinamiche sociali (Montag e Diefenbach, 2018).
Un fenomeno i cui numeri fanno letteralmente spavento: si stima un potenziale per l’IoT entro il 2025 tra i 4 e gli 11 trilioni di dollari annuali, al netto di tutte le nuove future opportunità di business.
Resta aperto il dibattito sul futuro, ossia sull’impatto possibile dei mondi digitali su uomo e contesti di vita reali, senza considerare il crescente sviluppo dell’intelligenza artificiale. Qualche probabilmente più interessa e l’interconnessione esistente tra la tecnologia e i cambiamenti sociali, che di fatto coinvolgono in primo piano l’educazione. L’Internet of Things (IoT) è un paradigma tecnologico rivoluzionario che disegna un futuro in cui qualsiasi oggetto, anche di uso quotidiano equipaggiato con microcontrollori e trasmettitori digitali, permettendo così una comunicazione costante con gli utenti e rendendolo di fatto parte della rete (Rajashekhar, 2016). La capacità e la possibilità di connettere un numero notevolissimo di oggetti comuni alla rete e permettere loro di interagire e scambiare dati, se da un lato facilita la comunicazione dall’altro permette di creare oggetti intelligenti capaci di generare essi stessi comunicazione e risultare — non poco — rilevati da un punto di vista educativo.
L’educazione onlife
L’educazione onlife è certamente un nuovo paradigma educativo che necessita di essere studiato, compreso, rappresentato attraverso precise categorie di riferimento; su queste, un riferimento a quanto già detto, la complessità, che già Morin ha ampiamente argomentato sul fronte educativo (Morin, 2017). Una complessità che riguarda l’intero paradigma, la pratica e la prassi educativa, i luoghi e i contesti, la rete, le reti e le non reti. Il web
diventa un educatore con maggiori possibilità di generare apprendimento. […] Quella del web è una frammentata piazza comunicativo-educativa virtuale che, oltre a produrne di nuove, ha assorbito riformulando molte delle occasioni educative informali prima collocate in una dimensione di prossimità, in una certa misura controllabili da coloro che avevano funzioni di orientamento dei corsi di vita altrui. Sono quindi esperienze che si affiancano a quelle di prossimità vis-à-vis e costituiscono un’ossimorica «prossimità distante»: chat di autoaiuto virgola di conversazione virgola di formazione, tutte esperienze comunicative virgola in diretta o in differita, con persone EO piattaforme all’interno delle quali si verifica un apprendimenti di vario genere e intensità punto a, senza considerare quello che si sta verificando, e si verificherà sempre più, con l’«intelligenza artificiale» (Tramma, 2024, pp. 149-150).
Si comprende bene che l’educazione onlife è un concetto in costruzione, al quale anche questo saggio e molti altri scritti provano a contribuire. È necessario far riferimento al concetto originario sviluppato da Floridi, in cui si descrive di fatto una condizione in cui vita digitale e vita fisica sono intrinsecamente connesse (Floridi, 2014). Da qui l’idea corre immediatamente verso i luoghi classici dell’apprendimento, la scuola, in cui si potrebbe immaginare il tutto come una ragionata e dialogante integrazione tra tecnologie digitali e apprendimento classico, studenti e docenti online e offline (Digennaro, 2024). Un modello in cui vi è continua integrazione tra ambiente fisico e digitale, nel quale si attua un processo fluido e dinamico, che va anche oltre i luoghi fisici delle scuole confondendosi con le esperienze quotidiane e quelle mediate da tecnologia.
Tuttavia, la necessità stringente e il contributo di innovazione che si vuole qui fornire riguarda una visione dell’educazione che travalichi i contesti formali dell’apprendimento e sia sufficientemente generalizzabile anche sul fronte dell’informalità, abbracciando in modo concreto il concetto di onlife, dunque, che non si limiti ai contesti formativi puri ma coinvolga 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ogni persona.
Tra le principali caratteristiche dobbiamo quindi partire dall’integrazione ubiqua delle tecnologie digitali all’interno del processo di apprendimento.
Questo richiede competenze specifiche avanzate sia da parte degli educatori che da parte degli educandi: sono specifiche e avanzate perché si ravvisa la necessità di spendibilità e integrazione con sempre nuovi strumenti, nuovi contesti, nuove piattaforme, in virtù di quella natura interconnessa e dinamica dell’onlife.
Ovvia e significativa la sfida che qui si pone ossia quella delle disuguaglianze d’accesso alle tecnologie digitali; seppure si viva totalmente connessi esistono ancora disparità nell’accesso sia ai dispositivi che alla rete, soprattutto nei contesti affetti da svantaggio socioeconomico o culturale. Questo inciso per sottolineare che esiste il rischio di ampliare questo divario digitale e amplificare ulteriormente le disuguaglianze educative già esistenti. Ma anche la possibilità di dar vita a vere e proprie tribù digitali, comunità virtuali che si formano attorno a interessi comuni, valori condivisi o obiettivi specifici, spesso attraverso social media, forum e/o piattaforme di comunicazione online; tra le loro caratteristiche più importanti c’è l’appartenenza (e quindi l’identità), ovvero il sentirsi parte di un gruppo, e la cultura della condivisione (esperienze, risorse, ecc.). Inoltre, possono anche configurarsi come luoghi della personalizzazione dell’apprendimento in cui ognuno può unirsi a una comunità che soddisfa le proprie esigenze educative. Non di rado possono aver generarsi fenomeni di peer learning, comunità di pratiche e ambienti di apprendimento ibridi.
Nel momento in cui l’educazione diventa onlife si rischia anche un sovraccarico informativo. La costante esposizione a un’enorme quantità di informazioni e risorse, che per svariate ragioni possono risultare di difficile digestione, può creare confusione e incapacità di discernere l’utile da non utile, le informazion rilevanti da quelle irrilevanti, le fonti affidabili da quelle non affidabili. Le svariate possibilità che offre l’apprendimento online stanno di fatto rivoluzionando a livello globale prima d’istruzione e poi l’intero panorama dell’education.
L’educazione onlife richiama a una riflessione filosofica ed etica su cosa significhi realmente educare in un tempo in cui di fatto risultano marginali gli educatori classici. Allora viene da porsi una prima domanda sul ruolo degli educatori e su chi lo svolgerà, se ancora lo svolgerà o non verrà soppiantato totalmente dalla tecnologia e dall’IA; e una seconda domanda sul nuovo senso e corso dell’intenzionalità educativa. Dall’IE (intenzionalità educativa) all’IA (intelligenza artificiale) il passo sembra più breve del previsto.
La formazione del pensiero è altro tema di stringente attualità e non proprio disconnesso da quanto fin qui detto. L’onlife, sebbene offra tante nuove opportunità educative, può anche condizionare il modo di pensare degli studenti, il modo in cui apprendono e interagiscono con il mondo e con le persone. Pertanto, la formazione del pensiero, critico, consapevole e argomentato, è fatto più che centrale e, probabilmente, prodromico a ogni altra questione che riguardi la complessa educazione onlife.
Quando parliamo di educazione onlife parliamo di un patrimonio da sprigionare, un potenziale che necessita di un approccio olistico che prenda in considerazione tanto la dimensione metodologica quanto quella strumentale, ma anche tutte quelle implicazioni etiche, sociali e filosofiche, inclusa la formazione del pensiero e le prospettive del longlife e longwide learning (Baldacci et al., 2012; Federighi, 2018). Solo attraverso un’educazione onlife consapevole e critica si può sperare di formare cittadini capaci di navigare con successo nel complesso panorama del vivere digitale.
Conclusioni
Onlife, educazione e complessità sono attualità del nostro tempo, dialoganti e in continua evoluzione. La prospettiva di una educazione onlife, delineata nelle righe precedenti, non è altro che una proposta pedagogica da ascrivere ai comparti dell’educazione informale e dell’educazione permanente. L’onlife è la condizione, l’educazione il fatto, la complessità la chiave interpretativa che apre a una prospettiva interdisciplinare.
Le questioni riguardanti la connessione pervasiva, il tema delle identità multiple, la consapevolezza digitale, i rischi e le opportunità, la privacy e la valutazione critica delle informazioni sono al centro del dibattito educativo nella prospettiva onlife, dibattito che non ha fissato al momento punti d’arrivo ma delineato linee di indagine e prospettive di ricerca. L’opportunità del vivere in simbiosi con tecnologia e costantemente connessi richiede anche competenze avanzate, una patente che renda ognuno in grado di attuare comportamenti consapevoli.
L’onlife richiama necessariamente l’idea di una formazione longlife e longwide (Baldacci et al., 2012; Federighi, 2018), che è anche quel che è richiesto dal tempo della complessità; nel primo caso per essere sempre consapevoli delle azioni compiute in un territorio di mezzo sempre meno reale e sempre più virtuale, nel secondo per essere in grado di interpretare la realtà con il procedere del suo progresso e, dunque, del suo rendersi sempre meno comprensibile e decifrabile.
Bibliografia
Arquilla V. e Vitali I. (2016), Designing in the IoT era: Role and perspectives in design practices. In B.H. Ortuño (a cura di), Systems & design: Beyond processes and thinking, València, Editorial Universitat Politècnica de València, pp. 871-882, http://dx.doi.org/10.4995/IFDP.2016.3311 (consultato il 22 ottobre 2025).
Baldacci M., Frabboni F. e Margiotta U. (2012), Longlife-longwide learning. Per un trattato europeo della formazione, Milano, Mondadori Bruno.
Balzano G. (2022), La sfida relazione dei nuovi lavori remote. In A. Galimberti e A. Muschitiello (a cura di), Pedagogia e lavoro. Le sfide tecnologiche, Fano, Aras Edizioni, pp. 39-57.
Boffo V. e Fedeli M. (a cura di) (2018), Employability & competences: Innovative curricula for new professions, Firenze, Firenze University Press.
Castells M. (2004), The network society: A cross-cultural perspective, Cheltenham, Edward Elgar Pub.
Digennaro S. (2021), Non sanno neanche fare la capovolta. Il corpo dei giovani e i loro disagi, Trento, Erickson.
Digennaro S. (2024), The syndrome of multiple bodies: The transformative impact of the onlife existence on preadolescents, «Frontiers in Education» vol. 9, https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1362448/full (consultato il 22 ottobre 2025).
Federighi P. (a cura di) (2018), Educazione in età adulta. Ricerche, politiche, luoghi e professioni, Firenze, Firenze University Press.
Floridi L. (2017), La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Floridi L. (a cura di) (2014), The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era, Berlin, Springer.
Iavarone M.L. e Aruta L. (2022), Digital skills between soft and hard. The media educator among critical issues and opportunities, «Form@re – Open Journal Per La Formazione in Rete», vol. 22, n. 3, pp. 242-251.
Malavasi P. (2020), Insegnare l’umano, Milano, Vita e Pensiero.
Montag C. e Diefenbach S. (2018), Towards homo digitalis: Important research issues for psychology and the neurosciences at the dawn of the Internet of things and the digital society, «Sustainability», vol. 10, n. 415, pp. 1-21.
Morin E. (2017), La sfida della complessità. Nuova edizione, Firenze, Le Lettere.
Pati L. (2007), Pedagogia sociale. Temi e problemi, Brescia, La Scuola.
Peters M.A. e Jandrić P. (2019), Posthumanism, open ontologies and bio-digital becoming: Response to Luciano Floridi’s Onlife Manifesto, «Educational Philosophy and Theory», vol. 51, n. 10, pp. 971-980. https://doi.org/10.1080/00131857.2018.1551835 (consultato il 22 ottobre 2025).
Pizzolorusso F. (2022), Citizenship education during digital transformation: Post-pandemic scenario as a time of pedagogical reflection to an onlife civic experience, «Formazione & Insegnamento», vol. 20, n. 1 t. II, pp. 621-629.
Rajashekhar M. (2016), A literature study on internet of things for smart cities, «International Journal of Innovative Technology and Research», vol. 4, n. 1, pp. 2752-2756.
Rivoltella P.C. (2017), Tecnologie di comunità, Brescia, La Scuola.
Selmo L. (2021), Formare al futuro. Progettualità, metodi e innovazione, Milano, FrancoAngeli.
Tramma S. (2024), Educazione informale. In D. Simeone (a cura di), Dizionario di pedagogia Generale e Sociale, Brescia, Scholè, pp. 147-152.
Vol. 2, Issue 2, October 2025