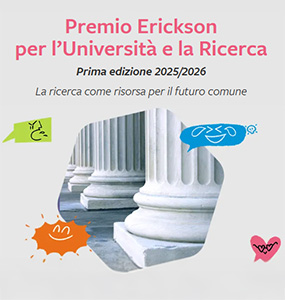Vol. 2, n. 1, aprile 2025
Il canto delle sirene. Il corpo in equilibrio tra reale e virtuale
Rosa Iaquinta1
Sommario
I cambiamenti dei paradigmi socio-culturali hanno contribuito ad attribuire nuovo significato al corpo, assegnandogli un ruolo centrale, privato e sociale, al punto da incidere sullo stato di benessere di giovani e adulti. La percezione del corpo concorre alla costruzione identitaria, generando vere e proprie crisi se non riconosciuto come espressione di Sé o conforme ai canoni contemporanei. Le immagini online dettano le caratteristiche del corpo perfetto, generando nei ragazzi un continuo lavoro di comparazione tra la realtà e il virtuale. Imprescindibile per la pedagogia non solo operare una continua riflessione ermeneutica sugli effetti che i modelli «ideali» dei social media generano condizionando la costruzione del sé corporeo, quanto introdurre azioni educative atte a decostruire ogni falsa rappresentazione. La sfida educativa si incarna nella promozione del Life Deep Learning e della Critical Media Literacy, il cui fine è quello di portare al riconoscimento delle influenze sociali e culturali del tempo, in modo che i giovani possano sviluppare un autoconcetto autentico. L’educazione, generando forme di consapevolezza, consente ai giovani di riconoscere il canto ammaliatrice delle sirene che promette forme di irraggiungibile bellezza, in modo da prevenire situazioni di ansia e depressione, disturbi alimentari nonché il desiderio, sempre più precoce, di intervenire.
Parole chiave
Autoconcetto, corpo, critical media literacy, educazione, lifedeep learning.
The Siren’s Song: The Body in Balance Between Real and Virtual
Rosa Iaquinta2
Abstract
Changes in socio-cultural paradigms have helped to give new meaning to the body, giving it a central role, both private and social, to the point of affecting the welfare state of young people and adults. The perception of the body contributes to the construction of identity, generating true and proper crises if not recognized as an expression of self or in accordance with contemporary canons. The online images dictate the characteristics of the perfect body, generating in the children a continuous work of comparison between reality and the virtual. It is essential for pedagogy not only to carry out a continuous hermeneutic reflection on the effects that the «ideal» models of social media generate, and which condition the construction of the bodily self, as well as introducing educational actions to deconstruct any false representation. The educational challenge is embodied in the promotion of Life Deep Learning and Critical Media Literacy, the aim being to bring about the recognition of the social and cultural influences of the time, so that young people can develop an authentic self-concept. Education, generating forms of awareness, allows young people to recognize the enchanting song of the sirens that promises forms of unattainable beauty, so as to prevent situations of anxiety and depression, eating disorders and desire, The European Commission has been working on this issue since the beginning of the year.
Keywords
Body, critical media literacy, education, lifedeep learning.
Corpo costrutto sociale
Negli ultimi decenni il corpo ha assunto una rilevanza senza precedenti, i cui effetti concorrono a definire l’identità personale. L’importanza che esso ha assunto è tale da incidere profondamente sul benessere psicologico di giovani impegnati nella ricerca della propria identità e meno giovani bisognosi di conferme (Haidt, 2024).
La centralità del corpo nella cultura contemporanea è la risultante di un’evoluzione socio-culturale complessa, durante la quale il corpo si è trasformato da contenitore biologico a simbolo d’identità.
Il mutamento radicale che si è venuto a determinare è pari alle implicazioni, le quali generano conseguenze a livello individuale e collettivo i cui effetti necessitano di un’approfondita analisi dei meccanismi che oggi saldano insieme corpo e identità.
Il concetto di corpo come costrutto sociale si è affermato progressivamente, guadagnando terreno dagli anni Sessanta del Novecento, anche in virtù dei messaggi che attraverso la televisione raggiungevano un numero sempre maggiore di persone e che entravano in contatto con i modelli proposti.
Nel corso dei millenni il corpo è stato oggetto di segregazione e repressione, con l’intento di annullarlo cancellandone la portata, in modo da privarlo del suo valore, dunque del potere che avrebbe potuto esercitare sugli altri in ragione delle sue caratteristiche. La rilettura delle diverse epoche, alla luce dei principi e dei valori che le hanno caratterizzate, consente di seguire la traiettoria attraverso cui l’esercizio del potere è stato espresso proprio attraverso il controllo del corpo, con particolare riguardo a quello femminile. Controllo del corpo che, rappresentando uno strumento di potere, è stato utilizzato sia per esercitare supremazia e dominazione che per mantenere l’ordine sociale. Michel Foucault effettua un’analisi profonda e dettagliata del fenomeno e introduce i concetti di «biopolitica» e «anatomo-politica», utilizzati per descrivere come il potere si articoli certo attraverso la forza e le leggi, ma anche mediante il controllo dei corpi e delle pratiche quotidiane.
In Sorvegliare e punire (1975) il filosofo esplora come il corpo sia stato disciplinato e modellato attraverso le istituzioni sociali, e descrive prigioni, scuole e ospedali, luoghi progettati per disciplinare i corpi e conformarli a specifiche norme sociali. Rende evidente come esso non possa essere considerato solo un’entità biologica ma un terreno su cui si proiettano norme, valori e ideologie sociali. Visione, questa, che ha aperto la strada a un’esplorazione più ampia e articolata concernente l’interazione corpo-identità (Iofrica e Madonna, 2019). Riguardo alla prigione, questa rappresenta il luogo per eccellenza del controllo, dove attraverso la sorveglianza continua, la regolamentazione dei movimenti e l’imposizione di rigide regole viene attuata la disciplina. Quest’ultima non è solo finalizzata a limitare fisicamente gli individui, quanto a educarli, facendogli interiorizzare le norme sociali in modo da renderli capaci di aderire a un sistema di potere più ampio e non circoscritto alle mura carcerarie.
Nel campo della medicina il controllo sul corpo viene esercitato attraverso la regolamentazione della salute e delle pratiche igieniche, e Foucault ne esamina gli aspetti nell’analisi della «biopolitica», in cui descrive il modo attraverso cui lo Stato gestisce le popolazioni ricorrendo alla regolazione della vita biologica. Le pratiche mediche ed igieniche diventano strumenti per il controllo sociale, delineando ciò che viene considerato «normale» o «anormale», di conseguenza stabilendo chi rientra nell’ambito della cura e chi del controllo.
Non è secondario il controllo del corpo esercitato attraverso la gestione della sessualità, e Foucault, ne La volontà di sapere (1976), sottolinea come la sfera sessuale sia stata oggetto di regolamentazione da parte delle autorità attraverso la medicina, la psichiatria e la legge. Ambiti che hanno concorso a definire e controllare i comportamenti sessuali, stabilendo una gerarchia di azioni e modi di agire ritenuti accettabili rispetto a quelli da reprimere o punire. Lo studioso non poteva certamente tralasciare di esaminare la scuola, luogo per eccellenza della regolamentazione dei corpi sin dalla infanzia, dove gli allievi sono stati sempre sottoposti a una rigida disciplina che anticipava all’istruzione e alla formazione la regolamentazione dei giovani corpi e dei comportamenti, allo scopo di formare cittadini produttivi e obbedienti. Foucault considera tale processo come forma di «addestramento» orientata a creare corpi docili, pronti a essere inseriti nel meccanismo produttivo della società moderna.
Il rapporto corpo-potere ha caratterizzato numerosi ambiti della vita sociale, la strategia di controllo oltrepassava la coercizione fisica e si connotava quale modo attraverso il quale il plasmare i comportamenti rappresentava solo l’espetto esteriore di un ulteriore intento, meno evidente ma più profondo, come quello di incidere sulle identità degli individui, i quali appartenendo a un dato sistema di potere questo pervade ogni aspetto dell’esistenza.
In ambito antropologico il corpo ha rappresentato un oggetto privilegiato di ricerca in ragione degli usi, costumi e rappresentazione che consentivano di comprendere le tradizioni di un popolo, dove le «tecniche del corpo», concetto introdotto da Mauss, rendevano possibile indicare «[…] i modi in cui gli uomini, nelle diverse società, si servono, uniformandosi alla loro tradizione, del corpo» (Mauss, 1965, p. 385). Le tecniche sono espressione del bagaglio di un popolo e della sua cultura del corpo, al punto che Mauss arriva a sostenere che «[…] la posizione delle braccia, quella delle mani mentre si cammina costituiscono una idiosincrasia sociale, e non semplicemente il prodotto di non so quali congegni e meccanismi puramente individuali, quali interamente psichici» (Mauss, 1965, p. 388). Il nucleo della riflessione antropologiche riconosce come il corpo riflette i significati sociali incarnandoli sotto forma di habitus, e si distinguono non tanto in ragione delle caratteristiche individuali quanto della singolarità delle società. Natura e cultura hanno il loro punto di intersezione nel corpo.
Attraverso il suo involucro l’uomo può trasformare l’ambiente considerando la cultura della comunità cui appartiene e, contemporaneamente, egli stresso si adatta al territorio modificando se stesso.
Numerosi autori si sono inseriti nel filone di ricerca inaugurato da Mauss, tra questi Mary Douglas, che opera una riflessione sul corpo quale forma di simbolismo sociale e sistema di classificazione (Douglas, 1993); Pierre Bourdieu, che considera il corpo quale luogo in cui si attivano gli habitus, ovvero gli schemi di percezione, valutazione e azione, che esprimono in forma incorporata la traiettoria sociale di un soggetto, giungendo a parlare di «costruzione sociale dei corpi» (Bourdieu, 1998a, p. 15), e indicando come il corpo sia una realtà costruita sulla scorta di una concezione cosmologica e antropologica, espressione della visione del mondo e dell’essere umano di una data comunità. Per Bourdieu l’insieme delle disposizioni di un soggetto, determinate dalla posizione e traiettoria nello spazio sociale, sono incarnate nel corpo e si traducono in atteggiamenti e posture che il corpo non assume per natura ma come risultato della «storia sociale» del soggetto (Bourdieu, 1998b, p. 137). Emerge, pertanto, come il soggetto si trovi sempre contenuto tra due tipologie di narrazioni: quella dello spazio sociale — storia di cose — e quella dell’habitus — storia del corpo.
Si accede così, attraverso il corpo, alla comprensione del mondo, che permette di acquisire una conoscenza di tipo pratica, «[…] il mondo è comprensibile, immediatamente dotato di senso, perché il corpo […] è stato a lungo (sin dalle origini) esposto alle sue regolarità. Acquisendo un sistema di disposizioni coerente a queste regolarità, il corpo si trova predisposto e pronto ad anticiparle in condotte che attivano una conoscenza attraverso il corpo» (Bourdieu, 1998b, p. 143).
Il corpo è linguaggio che parla e dal quale si è parlati, rivela ciò che è nascosto e vero, linguaggio «dell’identità naturale […] che è linguaggio dell’identità sociale» (Bourdieu, 1987, pp. 163-164).
Corpo esposto
Con l’avvento dei media di massa e, successivamente, dei social media, al corpo è stata offerto uno spazio espositivo permanente, oggetto tra gli oggetti, esposto al gusto e al giudizio pubblico (Di Fraia, 2023).
Le offerte di contenuti dei social svolgono un ruolo cruciale nel potenziare la bellezza dei corpi, il più delle volte sapientemente costruiti da risultare perfetti quanto irrealistici (Chittaro e Castigliego, 2024). Il modello del fisico perfetto induce gli utenti a comprensibili paragoni che li spingono a industriarsi per modificarsi. Per di più, i media non solo riflettono precisi canoni estetici ma rafforzandoli creano nel soggetto una tensione costante, suscitando un irriducibile bisogno di conformarsi a standard inaccessibili (Bordo, 1993). Tale fenomeno, non circoscrivibile alla sfera estetica, concorre alla costruzione di un’identità soggettiva incentrata sull’apparenza fisica, che può generare crisi identitarie nei soggetti che assumono le immagini come assolutizzanti e non riescono a concepire altre rappresentazioni. Le immagini del corpo esposto sulle piattaforme sono senza dubbio tra i contenuti maggiormente significativi e diffusamente condivisi nella nostra epoca, e concorrono allo sviluppo dell’autostima proprio attraverso l’immagine corporea (Salerno et al, 2017). Gli effetti che i corpi desiderabili hanno sui giovani sono particolarmente incisivi in ragione dei cambiamenti a cui il corpo è sottoposto durante la crescita, e che espone alle opinioni, spesso crudeli, dei coetanei, il cui valore ha una portata psicologica di portata impressionante (Iaquinta, 2023).
La natura del giudizio che viene espressa per alcune caratteristiche del corpo altrui conduce il soggetto destinatario a modificare l’immagine mentale che egli ha di se stesso, inducendolo a rafforzare o rimuovere materialmente ciò che viene accettato o rifiutato.
La sensazione che ci sia motivo di preoccupazione per l’impatto dei media sull’immagine è abbastanza diffusa, la esprimono tanto i genitori, quanto i ricercatori di scienze sociali. Tuttavia, giungere alla misurazione di tale impatto e delle sue conseguenze è piuttosto complesso, in ragione della modalità a doppio senso del funzionamento dei social, i quali se da una parte l’algoritmo influenza le idee dell’utente, dall’altra le interazioni online guidano l’algoritmo (Digennaro e Iannaccone, 2023).
Lo studio di tale fenomeno richiede strumenti raffinati che vadano a misurare gli effetti dell’uso dei media sugli utenti e considerando le numerose e possibili variabili, come l’intersezione di razza, genere e altre identità. Il modo in cui una persona, in un dato giorno, si sente riguardo al proprio corpo, che sia indifferenza, infelicità, soddisfazione, amore e apprezzamento, determina l’uso dei social e le tracce che lascerà, di contro l’algoritmo, risentendo delle visualizzazioni, mostrerà ciò che andrà a influenzare l’immagine corporea. Le informazioni raccolte dalle piattaforme verranno utilizzate per «dare forma» a ciò che si ritiene possa rientrare negli interessi dell’utente, generando un ulteriore effetto sulla immagine corporea. Mentre le riviste e la televisione sono canali unidirezionali, i social vengono utilizzati e arricchiti dai fruitori, ed è la loro connotazione bidirezionale a rendere complessa la comprensione del loro impatto. Gli esiti dei social sull’immagine corporea risultano difficili da studiare in ragione degli effetti altamente individuali, che risentono della quantità di tempo del loro utilizzo e da come si interagisce dopo la visione di nuovi contenuti e per quali ragioni.
Le ricerche condotte in tale ambito sono ancora insufficienti per giungere a delle soluzioni condivise. Uno dei pochi studi longitudinali degno di nota è quello condotto nel 2023 da alcuni studiosi australiani (Jarman et al., 2023). La ricerca ha preso in esame un ampio campione di adolescenti per la durata di dodici mesi, durante il periodo sono state analizzate le preferenze e come i social hanno modificato la loro percezione corporea. Il campione è stato suddiviso in sottogruppi a seconda del tempo di interazione e la condivisione di contenuti. L’uso dei social è stato quantificato attraverso una serie di variabili, quali il tempo trascorso su piattaforme incentrate sull’aspetto fisico, la motivazione nell’uso dei social, l’editing delle foto, le conversazioni focalizzate sull’aspetto mostrato sui media, l’insoddisfazione del proprio corpo, le restrizioni alimentari e le strategie per aumentare la massa muscolare. Gli esiti della ricerca hanno mostrato che le persone il cui uso dei social era in aumento stavano vivendo preoccupazioni per la propria immagine. I dati hanno rafforzato ciò che in un certo senso era già noto, vale a dire che gli effetti sull’immagine corporea non dipendono solo dalla quantità di tempo che si trascorre sulle piattaforme, quanto dal tempo impiegato in attività legate alle immagini di se stessi che devono essere pubblicate e commentate. Lo scopo della ricerca è stato anche quello di ottenere informazioni sufficienti su quali siano i gruppi di persone che necessitano di maggiore supporto e da quali invece si può imparare in termini di utilizzo positivo dei media (Gasseau et al. 2024).
La fase dell’adolescenza e della giovane età adulta, dai 17 ai 25 anni, rappresentano i periodi maggiormente vulnerabili, durante i quali si verificano numerosi cambiamenti psicologici, fisici, neurobiologici, comportamentali e sociali (Wood et al., 2018). In tale arco esistenziale si registra un elevato uso dei social media collegato a un’alterata percezione dell’immagine corporea (Amendola et al, 2020).
Con il concetto di immagine corporea si fa riferimento alla rappresentazione interna che un soggetto ha del proprio aspetto esteriore (Grogan, 2016), che comprende le autopercezioni relative al corpo e agli atteggiamenti personali, inclusi pensieri, convinzioni, sentimenti e comportamenti (Cash, 2012). «L’immagine del proprio corpo non si identifica con i limiti anatomici dell’organismo. Corporeità e soma sono categorialmente irrapportabili. […] Comunque l’immagine del proprio corpo non è mai una sorta di fedele replica della morfologia del corpo» (Schilder, 1973, p. 22). La rappresentazione assume carattere multidimensionale composto da quattro componenti: soddisfazione soggettiva globale (valutazione del corpo), affetto (sentimenti associati al corpo), cognizioni (investimento nell’aspetto e convinzioni sul corpo) e comportamenti (evitamento di situazioni di esposizione del corpo). Per la molteplicità di tali fattori e la loro variabilità, l’immagine corporea si connota come fenomeno complesso, anche in virtù delle numerose componenti che la interessano e che richiamano fattori di genere, etnici e socioculturali. L’insoddisfazione che nasce da sentimenti e pensieri riguardanti il corpo sono correlati a valutazioni negative da ricondurre alle dimensioni, alla forma e al peso, che implicano una discrepanza percepita tra la valutazione del proprio corpo e quello ideale (Tiggermann, 2011). La prevalenza dell’insoddisfazione corporea negli adolescenti varia a seconda dei diversi paesi occidentali; secondo i risultati di uno studio trasversale condotto su quindicenni europei e americani, è emerso come il 40% delle ragazze e il 22% dei ragazzi siano insoddisfatti del proprio peso corporeo (Inchley, 2016).
L’immagine di se stessi è per il corpo un cerchio mancato, dove la percezione è succube della consapevolezza, ma nessuno possiede l’immagine fedele del proprio corpo (Galimberti, 2023, p. 318).
Corpo e identità
La società contemporanea vive nel culto del corpo, divenuto lo strumento principale attraverso il quale l’individuo comunica se stesso. Centralità che ha innescato un fenomeno da molti considerata «crisi dell’identità», a causa dello stretto legame e della distanza tra la percezione che ciascuno ha in sé del proprio corpo e la sua reale conformazione, dando vita a due rappresentazioni che difficilmente coincidono (Smolak, 2012). È un costrutto multidimensionale quello che riferito all’immagine corporea, caratterizzato da percezione e valutazione del soggetto (Cash e Puzinsky, 2002). Nelle situazioni in cui il l’aspetto del corpo di cui si è dotati non soddisfa le aspettative personali o sociali, la persona può arrivare a sperimentare una disconnessione tra il Sé percepito e il Sé desiderato, il cui divario genera sentimenti d’inadeguatezza e/o di ansia (Giddens, 1991). Il concetto di Sé esprime l’immagine che ciascuno ha di sé, ed è influenzato da una molteplicità di elementi, tra questi, a titolo di esempio, le interazioni con le persone maggiormente significative nella propria vita. Il concetto include anche il modo attraverso cui vengono percepiti comportamenti, abilità e caratteristiche, o anche credenze che inducono a ritenersi gentili o buoni amici, e ancora il modo di considerare i tratti della personalità o come viene percepito il proprio ruolo nella vita, tutti aspetti che possono risultare rilevanti al punto da che strutturare il concetto globale. La percezione di sé influenza, inoltre, le motivazioni, gli atteggiamenti e i comportamenti, nonché il modo in cui ci si sente riguardo alla persona che si pensa di essere. Il concetto di sé è esposto a un elevato grado di flessibilità durante la giovinezza, quando si è fortemente impegnati nella scoperta e nella formazione dell’identità, mentre con l’avanzare dell’età si comprende cosa si considera importante, e le auto-percezioni diventano maggiormente dettagliate e organizzate.
Possiamo affermare che il primo dato sul concetto di sé è l’insieme della raccolta sia delle credenze su se stessi che delle risposte degli altri. Carl Rogers (2012) riteneva a tal proposito che il concetto di Sé fosse composto da tre parti: la prima riferita alla persona che si desidera essere; la seconda alle caratteristiche o qualità che si desidera possedere e la terza riferita a chi si immagina di essere se si fosse esattamente come si vorrebbe. L’immagine di sé si collega a come ci si vede in uno specifico momento, con le caratteristiche fisiche, i tratti della personalità e i ruoli sociali, che insieme agiscono sulla percezione della propria immagine con una forte ricaduta sull’autostima collegata a quanto ci si piace, ci si accetta e apprezzi. Tuttavia l’autostima non è scevra da condizionamenti esterni, essa può essere influenzata da come ci vedono gli altri, come ci si confronta e qual è il ruolo sociale, determinando una condizione di incongruenza o congruenza riguardante l’allineamento, o meno, del concetto di sé con la realtà. Le radici dell’incongruenza si rintracciano nel tempo dell’infanzia, quando i genitori pongono condizioni sul loro affetto per i figli, conseguentemente i piccoli iniziano a distorcere i ricordi delle esperienze che li hanno fatti sentire indegni dell’amore dei genitori. L’amore incondizionato, invece, li aiuta e li rafforza nella costruzione di un concetto congruente di loro stessi. Sperimentando tale forma di amore i bambini non avvertono il bisogno di alterare i loro ricordi per poter credere che gli altri li ameranno e li accetteranno così come sono.
Lo sviluppo di tale concetto risente fortemente, oltre che dall’interazione con i familiari, delle relazioni con gli amici e con le persone che a vario titolo concorrono alla costruzione dell’identità, un esempio significativo è dato dalla relazione con un insegnante che, credendo nelle alte capacità di uno studente, esercita una tale influenza sul giovane da lasciare tracce indelebili.
Non è da trascurare che il concetto di sé relazione subisce modificazioni a seconda delle persone con le quali si interagisce, ancor di più se queste fanno parte della quotidianità e/o rivestono ruoli di leadership. La costruzione del concetto può svilupparsi, inoltre, attraverso l’ascolto di storie, che oggi avviene prevalentemente attraverso le narrazioni dei media, i cui messaggi vengono assorbiti e fatti propri, calati nel vissuto senza alcun tipo di aderenza con il contesto educativo, familiare e sociale o di appartenenza, a differenza di quanto avveniva in passato, dove la narrazione era la rappresentazione di un mondo e valori che si intendevano tramandare.
Henri Tajfel è portatore di un differente modo di pensare al concetto di sé, sostiene come esso sia composto da due aspetti chiave, il primo riferito alla identità personale, quale insieme di tratti e caratteristiche che rendono unico e differente ogni individuo, il secondo riguarda l’identità sociale, che deriva dall’appartenenza a gruppi sociali (Tajfel, 1999). Le persone sono inclini a categorizzare se stesse e gli altri a seconda dell’appartenenza gruppale, intesa come nazionalità, professione, religione, genere e ciò aiuta nella semplificazione e comprensione del mondo sociale. La teoria dell’identità sociale sviluppata da Henri Tajfel si concentra su come le persone definiscono se stesse a seconda del gruppo sociale di appartenenza. Gli individui tendono a tali forme di classificazione le cui conseguenze riguardano il concetto di sé e il modo di percepirsi e incidono sul senso di autoefficacia e sull’autostima, quindi sullo stato emotivo e sui comportamenti.
Concezione differente è quella proposta da Bruce Bracken (2009), credeva a un concetto di sé multidimensionale, composto da sei tratti indipendenti: Accademico: successo o fallimento a scuola; Affetto: consapevolezza degli stati emotivi; Competenza: capacità di soddisfare i bisogni fondamentali; Famiglia: quanto bene si opera nel nucleo familiare; Fisico: come ci si sente riguardo al proprio aspetto, salute, condizione fisica; Sociale: capacità di interagire con gli altri.
Sulla scorta dei tratti Bracken ha sviluppato la Scala Multidimensionale del Concetto di Sé (1992), che verte su una valutazione nella quale ciascuno dei diversi elementi viene esaminato nei bambini e negli adolescenti.
Lo sviluppo del concetto di sé non può ritenersi mai pienamente completato, tuttavia anche se l’identità personale è organizzata per strutturarsi prevalentemente durante l’infanzia, le esperienze dell’età adulta possono concorrere a modificare il modo in cui ci si sente.
L’inedita visibilità: il corpo nell’era digitale
L’evoluzione del paradigma corporeo riflette i profondi cambiamenti intervenuti nel nostro tempo, dove il corpo oltre che espressione dell’identità soggettiva è anche il terreno sul quale si gioca il riconoscimento sociale e l’autostima. Tale processo, fortemente influenzato dai media e dalle norme culturali, ha reso il corpo un elemento centrale nel determinare lo stato di benessere personale (Iofrida, 2019). La comprensione di questo processo è essenziale per affrontare le sfide psicologiche e sociali che ne derivano, specialmente nell’epoca che pone l’immagine corporea costantemente al vaglio altrui (Iannaccone, et. al 2024).
L’insoddisfazione che deriva dal possedere un dato corpo è stata collegata a una serie di problemi di natura fisica e mentale, e nelle società occidentali essa viene riconosciuta come un problema di salute pubblica (Health and Social Care Committee, 2022). I social media concorrono attraverso le immagini di corpi perfetti a generare difficoltà di accettazione delle sembianze personali, tanto da essere considerati dannosi per la costruzione dell’immagine corporea (de Valle et al., 2021). Le immagini dei corpi sono incentrate sulla celebrazione di caratteristiche, per lo più quella della magrezza, spesso esaltata attraverso fisici tonici o figure a clessidra (McComb e Mills, 2022). Tuttavia si registra da qualche tempo un timido orientamento verso la decostruzione di immagini corporee esclusivamente etere ed evanescenti, rintracciabile nella presenza, sporadica e isolata, sulle passerelle della moda di donne dai corpi non filiformi e/o giovanissime. Anche sui social sono rintracciabili utenti che mostrano imperfezioni universalmente condivise. Ritroviamo condivisioni di condizioni di disabilità, malattia, perdita di persone care che suscitano critiche feroci ma anche vicinanza emotiva o psicologica (Boccia Artieri et al, 2018).
Tra i social media, quelli che pongono maggiore enfasi su contenuti e attività basati sull’aspetto sono considerati ancor più responsabili nel generare effetti negativi per l’immagine corporea rispetto alle piattaforme che pongono maggiore enfasi sulle interazioni incentrate sul testo (Engeln et al., 2020). Recenti indagini indicano un crescente corpus di prove che collegano l’uso dei media, specie se per tempi prolungati, con il disturbo di immagine (Vandenboschet e al., 2022), il suggerimento va nella direzione di agire identificando strategie di intervento preventive ed efficaci (Harriger et al., 2023).
Il corpo nella trappola del digitale viene plasmato per renderlo adatto alla vetrina sociale, la cui esposizione ha implicazioni sul modo in cui l’identità viene costruita, percepita e negoziata sia nella sfera pubblica che privata.
Rivoluzionando la natura dei corpi e dandogli visibilità, i social media hanno consentito la condivisione della propria immagine con un pubblico potenzialmente globale, rendendo il corpo «biglietto da visita». Sherry Turkle, in un lavoro dal titolo esemplificativo, sostiene che le piattaforme digitali offrendo un’opportunità senza precedenti per sperimentare diverse versioni del sé, richiedono un prezzo elevato all’utente, che consiste nella profonda compromissione della propria autenticità (Turkle, 2011). La pressione a conformarsi agli standard estetici e culturali imposti dalle piattaforme ha condotto a una rappresentazione incentrata sull’apparenza piuttosto che sull’essenza.
Entra in scena inevitabilmente il concetto di «performance» del corpo, che assume centralità nell’analisi dell’identità nell’era digitale. Goffman (1959) ha introdotto l’idea che la vita sociale consiste in una serie di rappresentazioni teatrali, dove gli individui mettono in scena il proprio ruolo a beneficio del pubblico. Metafora che si applica perfettamente al modo in cui i fruitori dei social media costruiscono le identità online. Il corpo diventa strumento attraverso cui gli individui «performano» la loro identità, cercando di aderire agli ideali estetici del momento per ricavarne approvazione e riconoscimento sociale.
Il ricorso all’uso di filtri correttivi e alle manipolazioni digitali rappresentano alcuni aspetti che generano profonde preoccupazioni per via della inclinazione nel costruire un’immagine di corpo idealizzata, il cui rischio è l’identificazione con una struttura artificiale la cui forma non esiste nel mondo reale, di conseguenza neanche chi con essa si assimila. La pratica in uso altera la percezione del corpo altrui, arrivando a distorcerne l’autopercezione. L’uso di filtri simula il corpo rendendolo maggiormente desiderabile rispetto a quello di cui si è dotati, conducendo a un divario tra due identità.
Il concetto di iperrealtà esplorato da Jean Baudrillard può essere qui richiamato in maniera pertinente per affrontare il tema delle identità corporee costruite digitalmente (Baudrillard, 1981). L’iperrealtà descrive un mondo in cui la distinzione tra realtà e simulazione diventa indistinguibile, e Baudrillard sostiene che nella società contemporanea i simboli e le immagini (nei media come nella pubblicità) non rappresentano più la realtà, ma ne creano una a sé stante, una «realtà più reale del reale», dove il confine tra vero e falso, originale e copia, sfuma fino a dissolversi. Condizione che viene amplificata attraverso le identità digitali, che possono differire significativamente dalla realtà «offline» dell’individuo, spesso manipolate per dotarsi di un’immagine ideale piuttosto che autentica. Baudrillard stesso avrebbe visto le identità digitali come un’ulteriore manifestazione dell’iperrealtà, in cui quelle costruite e mantenute online diventano più «reali» di quelle fisiche.
Il legame tra iperrealtà e identità digitali si concretizza nell’esperienza online, dove le persone interagiscono principalmente con rappresentazioni, simulacri di sé stessi e degli altri, piuttosto che con la loro essenza reale. Simulazione delle identità che conduce a una sovrapposizione di mondi, digitale e fisico, facendo sì che la percezione della realtà venga sempre più mediata dalle tecnologie.
L’importanza del corpo nei social media è un tema che coinvolge numerosi e differenti aspetti, tra questi le norme culturali, l’autenticità e la salute mentale. Rientrano tra questi quelli riguardanti i seguenti rapporti:
- Immagine e Autenticità: i social media sono spesso una vetrina per mostrare la propria vita, e molti avvertono la pressione di presentare un’immagine ideale del proprio corpo. Il cui rischio è una distorsione della realtà, in cui il confronto costante con gli altri influenza la propria autostima;
- Norme Culturali e Stereotipi: le piattaforme sociali possono perpetuare norme di bellezza archetipiche e stereotipi riguardanti il corpo. Tali rappresentazioni possono escludere la diversità dei corpi e portare a ideali irraggiungibili, contribuendo ad alimentare problemi di autovalutazione e disordini alimentari;
- Body Positivity e Inclusività: negli ultimi anni lo sviluppo del movimento di body positivity promuove l’accettazione di tutti i tipi di corpi e incoraggia le persone a valorizzare e celebrare la propria unicità. Movimento che ha guadagnato attenzione sui social media ispirando discussioni sulla bellezza e l’accettazione;
- Marketing e Consumo: il corpo viene frequentemente utilizzato nel marketing per vendere prodotti e servizi. Le campagne pubblicitarie presentano modelli che seguono determinati standard di bellezza influenzando le aspettative del pubblico e contribuendo a dinamiche di consumo;
- Salute Mentale: l’uso intensivo dei social media e la costante esposizione a immagini curate possono influenzare negativamente la salute mentale, portando a condizioni di stress, ansia e depressione. Promuovere la capacità di riconoscere tali effetti e promuovere pratiche più sane nell’uso delle piattaforme sociali è necessario;
- Empowerment e Attivismo: i social media possono devono essere utilizzati come strumenti di empowerment, permettendo alle persone di condividere le proprie esperienze con il corpo, affrontare argomenti come la discriminazione per l’aspetto fisico e mettere in atto azioni che vadano a supportare il cambiamento sociale.
L’iperrealtà e le identità digitali pongono interrogativi riguardanti l’autenticità, la privacy e l’autodeterminazione nel mondo contemporaneo. La percezione del proprio sé e quello degli altri può essere profondamente influenzata dalle dinamiche digitali, rendendo difficile distinguere chi si è nella realtà e chi nel mondo virtuale.
Gli studi di settore confermano come l’esposizione costante a immagini idealizzate sui social media può generare una riduzione dell’autostima e un aumento di disturbi come l’ansia e la depressione, soprattutto tra i più giovani (Fardouly et al., 2015). L’identità corporea nell’era digitale rappresenta non solo un terreno di espressione, ma anche una fonte di vulnerabilità psicologica per i conflitti generati dalle pressioni esterne.
Responsabilità pedagogica e strategie educative
In ambito educativo l’importanza di una autentica costruzione identitaria può essere supportata attraverso la promozione di un ambiente di formazione in cui le interazioni tra gli allievi siano incoraggiate e guidate dal docente, allo scopo di ridurre ogni forma di ostacolo e pregiudizio.
Il fenomeno di costruire un’identità digitale non aderente a quella reale, pratica diffusa che emerge dalla ricerca condotta da Digennaro (2023), genera, tra l’altro, un allontanamento tra la vita digitale e la realtà. Divario i cui effetti si ripercuotono nel processo di crescita e in ambito scolastico, dove le inedite difficoltà che le nuove generazioni si trovano a fronteggiare sono palesi.
Si registra, pertanto, la necessità di una maggiore formazione dei docenti sulla specificità della problematica, la cui insufficienza si riflette nella messa in atto di interventi educativi capaci di rispondere alle problematiche che investono i giovani, in ragione, anche, della rapidità delle trasformazioni sociali e dei loro effetti. Tuttavia, per quanto gli scenari risultino complessi e articolati, lo sguardo pedagogico è dotato di cornici epistemiche e ontologiche che lo rendono atto ad affrontare difficoltà derivanti dall’identità corporea (Mariani, 2020).
Il sapere educativo si connota per specificità nell’approcciare ogni tematica giovanili e individuare modalità di intervento attraverso le quali supportare gli allievi nel riconoscere le caratteristiche del tempo in cui vivono.
Orientare l’attenzione su come le dinamiche socio-culturali e digitali condizionano l’immagine che ciascuno è impegnano a costruire significa rendere lo spazio classe luogo di riconoscimento privilegiato, nel quale la formazione interessandosi del lavoro di costruzione individuale si doti di senso.
In Occidente il pensiero dell’età moderna ha parlato poco del corpo, considerandolo secondario rispetto all’importanza della mente. Il tempo in cui la formazione richiedeva agli allievi l’esclusivo coinvolgimento del cervello e la passività dei corpi, relegati in una condizione anestetizzante, di cui dimenticarsi perché non necessari all’apprendimento è ormai superato. Eppure, anche quando la richiesta invitava i ragazzi a «lasciare tutto fuori dalla porta prima di entrare in classe», il corpo, volutamente ignorato e passivo, ha sempre svolto un ruolo indispensabile nel veicolare ogni sapere. È a partire dal corpo che si può percepire, vedere, toccare, sentire e orientarsi durante ogni tipo di attività scolastica ed extrascolastica. Attraverso il corpo, punto di partenza dell’esserci, vengono attivate singolari modalità comunicative da parte degli alunni — la testa sul banco, lo sguardo altrove, il dondolarsi sulla sedia, le numerose richieste di uscire dall’aula — che lasciano ai docenti territori utili alla scoperta e strade da percorrere per raggiungere i giovani aiutandoli a scoprire loro stessi, permettendo che inclinazioni e tendenze vengono a rivelarsi attraverso il loro corpo.
Risulta evidente come le istanze pedagogiche non possono trascurare la dimensione conoscitiva del corpo inibito dal digitale. L’intervento del docente consiste nel contestualizzare la produzione dei contenuti tecnologici e il loro consumo, rendendo palesi le strutture che legano tra loro i materiali fruiti da milioni di utenti, e come molti contenuti operino al di sotto del livello di coscienza ordinaria.
Il campo della Critical Media Literacy è un ambito significativo per la promozione di interventi che, coinvolgendo insegnanti e studenti, impegnano in un lavoro di analisi degli scritti e delle immagini, in un processo critico che consideri gli scopi dei contenuti, il pubblico al quale sono rivolti e le parti che traggono vantaggio dalla loro diffusione. Lavoro che richiede competenze di natura critica e capacità interpretativa dei problemi sociali e delle situazioni che generano forme di condizionamento, manipolazione e oppressione. Capacità critica che si presenta oggi appannata ma fortemente necessaria per valutare se i contenuti materiali o immateriali sono funzionali al benessere dei fruitori o se generano forme di disagio e disuguaglianza.
La CML si connota, allora, processo di empowerment delle persone attraverso un percorso di «coscientizzazione» (Freire, 2023). Il suo obiettivo, secondo la definizione del Comitato direttivo della Critical Media Literacy Conference of the Americas, è quello di esaminare criticamente strutture, ideologie, rappresentazioni che modellano le relazioni tra potere e conoscenza (Kellner e Share, 2019). La necessità di promuovere una specifica educazione ai media si fonda nella necessità di proteggere giovani e giovanissimi, dalla dipendenza e dai pericolosi meccanismi di manipolazione (Boyington et al., 2022).
Ellen Seiter mette in guardia dal rischio di un crescente condizionamento fortemente temuto dalle popolazioni di livello socioculturale medi e alti, «i media sono considerati più potenti da coloro che lavorano e vivono in situazioni di relativo privilegio; nei centri più poveri i media sono visti solo come un fattore meno significativo del ruolo svolto dalla povertà, dall’assenza dei genitori e dalla violenza» (Seiter, 2002, pp. 59-60). La comprensione degli effetti dei social media e delle questioni legate al condizionamento sono necessari per affrontare un’educazione che esplori le interconnessioni tra informazione e condizionamento. La Media Literacy adottata in aula può trasformare l’educazione promuovendo nei giovani capacità interpretative attraverso l’esplorazione dei linguaggi e delle comunicazioni affinché si possa giungere a una profonda comprensione del messaggio e delle implicazioni (Pireddu, 2023). La pervasività dei social media ha reso anche il corpo testo, contenuto che attraverso immagini è dotato di elementi da interpretare attraverso cui tutto l’essere, soma e psiche, si trasforma in comunicazione rendendosi disponibile, dichiarando di esistere per ciò che si vede e si nasconde.
Social Media e TIC sono strumenti fortemente emancipativi a condizione che le persone possiedono strumenti e struttura che gli consentono di utilizzarli per raccontare storie ed esprimere se stessi.
I social media detengono il potere di liberare o dominare, manipolare o illuminare, ed è fondamentale che gli educatori insegnino come utilizzarli e analizzarli criticamente (Kellner, 2004). L’alfabetizzazione mediatica critica offre l’opportunità di impegnarsi nelle numerose realtà sociali del mondo. Tuttavia, un’alfabetizzazione che si concentra prevalentemente sulla separazione tra realtà e finzione non si caratterizza come un’alfabetizzazione che possa essere considerata sufficientemente critica, poiché essa può focalizzare l’attenzione sul pensiero binario (vero/falso, noi/loro) senza produrre alcun effetto di analisi profonda. Se questa viene ridotta alla separazione tra ciò che è autentico o meno, l’educazione si trasforma in un compito meccanico che «può essere allenato attraverso una pratica prolungata, indipendentemente dal contesto specifico» (Kellner, 2004, p. 36). Prima che abilità la Critical Social Literacy dovrà promuove il giudizio informato, durante e come risultato dell’impegno nei media. Nasce la qui la necessita di ricorrere al Life Deep Learning, allo scopo di sostenere un apprendimento continuo e profondo che perduri per l’intero percorso di vita, non solo in ragione di un apprendimento continuo quanto per la sua capacità multifocale. Apprendimento può essere implementato a condizione che i giovani vengano aiutati: a riconoscere e abbandonare la propria zona di comfort e si mostrino disponibili ad accogliere nuove visioni e opportunità, che se per alcuni rappresentano un’attitudine innata, per altri occorre l’intervento dell’educatore; a lasciarsi coinvolgere dagli altri, il cui apporto è cruciale per generare un apprendimento condiviso; ad attivare forme di riflessione, sia collettive che personali.
L’apprendimento generato dal Life Deep Learning oltrepassa l’acquisizione e l’implementazione delle conoscenze, richiede continui adeguarsi alle nuove situazioni, affrontando difficoltà e opportunità. Tra i numerosi vantaggi di questa forma di apprendimento si caratterizza per l’aiuto ai giovani per generare un migliore adattamento alle esigenze del mondo reale attraverso un apprendimento pratico e contestualizzato che risponde alle istanze del digitale.
Il concetto di Life Deep Learning è un ambito che coniuga intelligenza artificiale e apprendimento automatico concentrandosi su tecniche di Deep Learning in contesti particolari della vita quotidiana. La cui peculiarità consiste nell’adattamento dinamico alle mutevoli esigenze e circostanze, nonché a rispondere alle esigenze dei giovani, al loro modo di apprendere, interpretare e interfacciarsi con la realtà attraverso la mediazione digitale.
Gli ambiti di utilizzo del Lide Deep Learning considerano, inoltre, l’integrazione del digitale nei variegati ambiti e attività quotidiane i cui ambiti di esplorazione riguardano la salute, attraverso il ricorso ad algoritmi che consentono non soli il monitoraggio della stessa quanto di effettuare diagnosi predittive; la finanza, per la previsione delle tendenze di mercato, la gestione dei rischi e l’analisi delle frodi; la Smart city, per l’ottimizzazione dei servizi urbani e della mobilità attraverso l’analisi dei dati raccolto da sensori e dispositivi, e naturalmente in campo educativo, attraverso il ricorso alle applicazioni di sistemi di intelligenza per l’apprendimento personalizzato e l’analisi dei comportamenti degli studenti. Utilizzando il Deep Learning gli allievi sono portati a sviluppare sei competenze globali, note anche come 6C, riguardanti il carattere, la cittadinanza, la comunicazione, la collaborazione, la creatività e il pensiero critico.
La competenza relativa al carattere richiama le qualità dell’individuo ritenute necessarie per vivere in un mondo complesso, come la grinta, la tenacia, la perseveranza, la resilienza, l’affidabilità e l’onesta. La competenza riferita alla cittadinanza aiuta i giovani a pensare come cittadini del mondo, considerando le questioni globali sulla base di una profonda comprensione dei diversi valori e sviluppando un autentico interesse nel collaborare insieme ad altri per risolvere problematiche complesse che hanno un impatto sulla sostenibilità umana e ambientale; la competenza della comunicazione implica la padronanza delle tre modalità della comunicazione: orale, scritta e digitale; la collaborazione richiama la capacità di lavorare in modo interdipendente e sinergico in team possedendo competenze interpersonali e di squadra, assumere decisioni e apprendere attraverso il contributo degli altri; la creatività implica lo sviluppo di uno sguardo imprenditoriale per le opportunità sociali, in modo da porre le giuste domande e generare idee innovative dimostrando capacità da leader, infine il pensiero critico, utile per valutare criticamente informazioni e argomentazioni, individuare schemi e connessioni, costruire conoscenze significative e applicarle.
Conclusioni
Il repentino cambiamento sociale e il conseguente susseguirsi di paradigmi hanno interessato anche il modo attraverso cui il soggetto identifica se stesso attraverso la propria immagina corporea. Il corpo ha rivestito da sempre un ruolo strategico nella costruzione identitaria, in modo particolare durante l’adolescenza, generando smarrimento e difficoltà nel tentativo di far coincidere il mondo interiore con l’aspetto fisico, con la speranza di mettere in riga il mondo visibile e quello invisibile. La visibilità concessa dai social per alcuni aspetti ha operato una sorta di liberazione del corpo, che ha abbandonato ogni nascondimento e cancellato ogni riserva, ma lo ha anche esposto senza cautela, sottoponendolo all’approvazione del vasto pubblico che gareggia nel tentativo di mostrare il raggiungimento di un’impossibile perfezione.
La necessità di essere dotati di un corpo bello, armonioso e perfetto, seppur manipolato per privarlo di ogni naturale imperfezione, suscita, soprattutto nei più giovani, il desiderio di raggiungere un traguardo inesistente. La distanza tra l’immagine costruita virtualmente e quella reale esercita notevole pressione sulle nuove generazioni, impegnate nello sforzo di incollare i due se stessi in modo da ricavare l’immagine che si vorrebbe corrispondesse al vero in un unico se stesso.
Promuovere in ambito scolastico processi di Life Deep Learning e di Critical Media Literacy significa intervenire affinché i giovani possano sviluppare forme critiche di autoconsapevolezza che agiscano quanto più velocemente possibile nel generare condizioni di benessere psichico ed emotivo.
Urgenti e indispensabili il ricorso a strategie educative che consentano di riconoscere condizionamenti socio-culturali e digitali che incidono sul modo di percepirsi dei giovani e che li possano guidare in un percorso di comprensione autentica e valoriale di sé e del proprio corpo.
Bibliografia
Agamben G. (2005), Homo Sacer: Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi.
Amendola A., Castellano S. e Troianiello N. (2020), #likeforlihe. Categorie, strumenti e consumi nella social media society, Roma, Rogas Edizioni.
Baudrillard J. (1970), La società dei consumi, Bologna, il Mulino.
Baudrillard J. (1981), Simulacres et Simulation, Parigi, Éditions Galilée.
Boccia Artieri G., Gemini L., Pasquali F., Carlo S., Farci M. e Pedroni M. (2018), Fenomenologia dei social network, Milano, Guerini.
Bordo S. (1993), Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body, Berkeley, University of California Press.
Bourdieu P. (1998a), Il dominio maschile, Milano, Feltrinelli.
Bourdieu P. (1998b), Mediazioni pascaliane, Milano, Feltrinelli.
Braken B.A (1992), Multidimensional Self-Concept Scale Examiner’s Manual, Austin, TX: Pro-Ed.
Bracken B.A. (2009), Handbook of Positive Psychology in Schools, Londra, Routledge.
Boyington B., Buller A. T., Higdon N., Huff M. e Roth A.L. (2022), The Media and Me: a Guide to Critical Media Literacy for Young People, Bay City, Triangle Square.
Cash T.F. (2012), Encyclopedia of Body Image and Human Appearance. In Cognitive-behavioral perspectives on body image, vol. 1, Londra, Academic Press, pp. 334-342.
Cash T.F. e Pruzinsky T. (2002), Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice,
New York, Guilford Press.
Chittaro L. e Castigliego G. (2024), Le illusioni dei social media. Maschere e specchi della nostra personalità, Milano, Mimesis.
de Valle Gallego-Garcia M., Williamson P. e Wade T. D. (2021), Social media, body image, and the question of causation: Meta-analyses of experimental and longitudinal evidence, «Body Image», vol. 39, pp. 276-292.
Digennaro S. e Iannaccone A. (2023), Corpi duplicati: l’utilizzo dei social media tra gli under 14, https://www.researchgate.net/publication/367542522_Corpi_Duplicati_l’utilizzo_dei_social_media_tra_gli_under_14 (consultato il 21 ottobre 2024).
Di Fraia G. (2023), Quando le tracce digitali diventano corpi. Identità e Metaverso. In E. Risi e A. Gandini (a cura di), Tracce digitali e ricerca sociologica. Riflessioni ed esperienze di sociologia digitale, Milano, FrancoAngeli, pp. 139-155.
Douglas M. (1988), I simboli naturali. Sistema cosmologico e struttura sociale, Torino, Einaudi.
Douglas M. (1993), Purezza e pericolo, Bologna, Il Mulino.
Fardouly J., Diedrichs P.C., Vartanian L.R. e Halliwell E. (2015), Social comparisons on social media: The impact of Facebook on young women’s body image concerns and mood, «Body Image», vol. 13, pp. 38-45.
Foucault M. (2014), Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi.
Foucault M. (2013), La volontà di sapere, Milano, Feltrinelli.
Freire P. (2023), La pedagogia degli oppressi, Milano, Mondadori.
Galimberti U. (2023), Il corpo, Milano, Feltrinelli.
Garland D. (2001), The Culture of Control: Crime and Social Order, «Contemporary Society education», vol. 1, n. 1, pp. 9-37.
Gasseau M., Scategno W. e Seidita L. (a cura di) (2024), Gruppi online e psicodramma. Esperienze, metodi, tracce, sperimentazioni e ricerche, Milano, FrancoAngeli.
Giddens A. (1991), Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Milton, Polity Press.
Goffman E. (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, New York, Doubleday.
Grogan S. (2016), Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women and Children, New York, Routledge.
Haidt J. (2024), La generazione ansiosa, Milano, Rizzoli.
Harriger J.A., Thompson J.K. e Tiggemann M. (2023), TikTok, TikTok, the time is now: Future directions in social media and body image, «Body Image», vol. 44, pp. 222-226.
Health and Social Care Committee (2022), The impact of body image on mental and physical health, https://committees.parliament.uk/publications/23284 (consultato il 20 ottobre 2024).
Iannaccone Al, Piccirilli L., Tescione A. e Digennaro S. (2024), Il ruolo dell’interazione sui social media nella formazione dell’immagine corporea e della intelligenza emotiva dei preadolescenti: uno studio trasversale. In F. Peluso Cassese (a cura di), Research on Edicational Neuroscienze 2024, Roma, Edizioni Universitarie Romane.
Iaquinta T. (2023), Come cammelli nella cruna dell’ago. La «religione del corpo» e la pedagogia dell’incorporare, «Pedagogia e Vita», vol. 3, pp. 29-35.
Inchley J., Currie D., Young T., Samdal O. et al. (2016), Growing up Unequal: Gender and Socioeconomic Differences in Young People’s Health and Well-Being, Geneva, World Health Organization.
Iofrica G. e Madonna G. (2019), Il corpo come luogo di identità: prospettive socio-culturali, «Giornale italiano di educazione alla salute, sport e didattica inclusiva», vol. 15, n. 3, pp. 45-60.
Iofrida M. (2019), Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica dell’ecologia, Macerata, Quodlibet.
Jarman H.K., Fuller-Tyszkiewicz M. e McLean S.A. (2023), Who’s most at risk of poor body image? Identifying subgroups of adolescent social media users over the course of a year, «Computers in Human Behavior», vol. 147, pp. 1-17.
Kellner D. (2004), Technological transformation, multiple literacies, and the re-visioning of education, «E-Learning and Digital Media», vol. 1, n. 1, pp. 9-37.
Kellner D. e Share J. (2019), The Critical Media Literacy Guide. Engaging Media and Transforming Education, Boston, Brill Sense.
Mariani A. (2020), Riflessioni sul corpo in pedagogia: tre percorsi, «Annali on-line della Didattica e della formazione docente», n. 20, pp. 7-14.
Mauss M. (1965), La nozione di tecnica del corpo, Milano, Einaudi, pp. 395-406.
McComb S.E. e Mills J.S. (2021), Young women’s body image following upwards comparison to Instagram models: The role of physical appearance perfectionism and cognitive emotion regulation, «Body Image», vol. 38, pp. 49-62.
Pireddu M. (2023), L’uomo, la tecnica, la formazione, note sulla pedagogia critica nelle società delle piattaforme, «Meridiana Rivista di storia e scienze sociali», n. 107, pp. 117-137.
Rabinow P. e Rose N. (2006), Biopower Today, «BioSocieties», vol. 1, pp. 195-201.
Rogers C. (2012), Un modo di essere, Firenze, Giunti.
Salerno L., Guarnaccia C., Lo Coco G., Giannone F., Falgares G. e Mancuso L. (2017), Relazioni interpersonali, immagine corporea ed autostima in adolescenza. Uno studio condotto con studenti degli istituti superiori, «Giornale italiano di psicologia, Rivista trimestrale», n. 4, pp. 939-956.
Scheper-Hughes N. e Lock M. (1987), The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology, «Medical Anthropology Quarterly», vol. 1, n. 1, pp. 6-41.
Schilder P. (1973), Immagine di sé e schema corporeo, Milano, FrancoAngeli.
Seiter R. (2002), Television and new media audiences, New York, Oxford University Press, pp. 59-60.
Smolak L. (2012), Appearance in childhood and adolescence. In N. Rumsey e D. Harcourt (a cura di), The Oxford handbook of the psychology of appearance, Oxford, Oxford University Press, pp. 123-141.
Tajfel H. (1999), Gruppi umani e categorie sociali, Bologna, Il Mulino.
Turkle S. (2011), Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, London, Basic Books.
Vandenbosch L., Fardouly, J. e Tiggemann, M. (2022), Social media and body image: Recent trends and future directions, «Current opinion in psychology», vol. 45, pp. 101-129.
Wood D.L., Crapnell T., Lau L., Bennett A. G., Lotstein D.S., Ferris M. e Kuo A.A. (2018), Emerging adulthood as a critical stage in the life course, «Handbook of life course health development», Londra, Springer.
Xavier Inda J. (2005), Anthropologies of Modernity: Foucault, Governmentality, and Life Politics, Hoboken, Wiley-Blackwell.
Vol. 2, Issue 1, April 2025